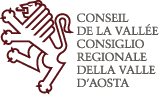Evénements et anniversaires
29 février 2012
“Chissà perché si chiama così”: un viaggio nel vocabolario dei monti valdostani
«Ci sono delle ovvietà talmente ovvie che finiscono per essere ignorate. Nella ricca collezione di documenti e di libri che riguardano la natura valdostana, largo spazio trovano la flora, la fauna persino i minerali, le pubblicazioni con le foto di montagne molto accattivanti. Ma tanta nomenclatura non si trova sulle nostre montagne che pure sono il palcoscenico ove si canta la lirica delle nostre bellezze naturali. Posso quindi affermare che Umberto Pelazza con il supporto di Marica Forcellini abbia prima di tutto fatto un regalo prezioso alla conoscenza della natura valdostana.» Così il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Cerise, ha aperto la serata di presentazione del libro “Chissà perché si chiama così”, mercoledì 29 febbraio 2012, davanti ad una vasta platea intervenuta a Palazzo regionale.
Il volume, promosso dal CAI della Valle d’Aosta, con il sostegno dell’Assemblea regionale ed edito dalla Tipografia Duc, è una raccolta di articoli a firma di Umberto Pelazza pubblicati su “Montagnes Valdôtaines”, il periodico delle sezioni valdostane del Club alpino italiano, tra il 1994 e il 1997. L’edizione è stata curata da Marica Forcellini ed è stata arricchita da note, approfondimenti e aforismi oltre che da un centinaio di foto realizzate da fotografi soci del CAI.
«Il libro – ha spiegato il Presidente del CAI Valle d’Aosta, Sergio Gaioni – racchiude lo spirito dei soci del CAI, che è quello di un amore illimitato per la montagna. Per noi rappresenta il risultato di un bel lavoro di gruppo, che è stato reso possibile grazie all’impegno volontario e disinteressato che il CAI riesce sempre, o quasi, a trovare fra i suoi soci, e che è alla base di tutte le sue molteplici attività. Questa pubblicazione non vuole presentarsi come fondamentale o esaustiva, ma rappresenta sicuramente un modo nuovo per promuovere e approfondire la conoscenza della nostra regione. Andare a cercare i motivi per cui una montagna si chiama così vuol dire andare a cercare le ragioni storiche, geografiche, ambientali di un territorio.»
La serata ha visto numerosi interventi del pubblico che ha posto domande e avuto risposte a piccole curiosità. La riflessione emersa è che, come sottolineato dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Cerise, «le montagne e i loro nomi possiedono una instabilità che è frutto della storia, della stessa geologia, delle lingue, dei dialetti e persino delle storpiature di questi.» Pelazza presenta un patrimonio di oronimi (circa 390 monti) in modo semplice e originale, ossia raggruppandoli in 12 gruppi di montagne che finiscono per comporre una specie di bouquet di fiori che consentono di acquisire dei nomi e in parte l’origine di questi. Il documento è accattivante, ironico e fortemente divulgativo e le citazioni presenti rappresentano un viatico interessante per introdurre il pubblico a questa branca del sapere.
Il Consiglio regionale ha voluto sostenere questo progetto perché, come ha evidenziato il Presidente Cerise, «c’è necessità di sviluppare un cultura montana autoctona per valorizzare il rapporto di un popolo che vive dentro le montagne, intra montes. Questo compito spetta anche all’istituzione pubblica che deve cercare di aiutare la gente a scoprire il proprio territorio, la propria cultura e le proprie origini.»
A passeggio nel vocabolario dei monti valdostani, gli abitanti di Aosta scopriranno che la loro montagna di riferimento, il Monte Emilius, deve il suo nome – come racconta Umberto Pelazza – alla quattordicenne Emilie Argentier, sorella di Auguste Argentier (1830-1874) medico di Cogne e alpinista, che nel 1839 vi fu accompagnata dall’abbé Carrel, che la battezzò quindi in suo onore, «mentre i canonici aostani, per onorare papa Pio IX, avevano invece già pensato a Mont Pie che sarebbe stato un irriverente gioco di parole. Pie, infatti, è anche la gazza ladra.» Così come, i valligiani di Ayas e Gressoney sanno che il Monte Rosa non riceve il suo nome dagli splendidi tramonti che si possono ammirare sulle sue cime, bensì «rosa, roise, roese, reuse, roesy e simili sono voci di genere femminile giunte tramite i Celti e su tutta la catena alpina denotano le zone coperte di ghiaccio.» O ancora, alla corte del Monte Bianco, svela Pelazza, «l’attributo ‘bianco’ dovuto alle punte nevose è raro. I nomi, infatti, sono saliti dal basso, dove la neve viene e va. Quindi solitamente il ‘bianco’ rispecchia il colore delle rocce. Il candore delle nevi avrà certamente colpito l’immaginazione degli antichi abitanti della valle, ma ben più degni di attenzione erano per loro i valichi a quota inferiore, come il Colle del Piccolo San Bernardo, l’Alpis Graia di Strabone e Tacito: il celtico gray (greya in patois), bianco, indicava le rocce gessose del passo. Latinizzato in albus, l’aggettivo diventerà blanc sotto l’influsso franco-germanico. Nelle cronache locali, dopo Mont Alban, il Monte Bianco fu alternativamente Mon Maudit, Mont Mallet, Mont Malay, di evidente valore repulsivo. Il nome attuale apparirà soltanto nel 1744 e avrà la sua definitiva sanzione ad opera di De Saussure al tempo della prima ascensione.»
Il volume, promosso dal CAI della Valle d’Aosta, con il sostegno dell’Assemblea regionale ed edito dalla Tipografia Duc, è una raccolta di articoli a firma di Umberto Pelazza pubblicati su “Montagnes Valdôtaines”, il periodico delle sezioni valdostane del Club alpino italiano, tra il 1994 e il 1997. L’edizione è stata curata da Marica Forcellini ed è stata arricchita da note, approfondimenti e aforismi oltre che da un centinaio di foto realizzate da fotografi soci del CAI.
«Il libro – ha spiegato il Presidente del CAI Valle d’Aosta, Sergio Gaioni – racchiude lo spirito dei soci del CAI, che è quello di un amore illimitato per la montagna. Per noi rappresenta il risultato di un bel lavoro di gruppo, che è stato reso possibile grazie all’impegno volontario e disinteressato che il CAI riesce sempre, o quasi, a trovare fra i suoi soci, e che è alla base di tutte le sue molteplici attività. Questa pubblicazione non vuole presentarsi come fondamentale o esaustiva, ma rappresenta sicuramente un modo nuovo per promuovere e approfondire la conoscenza della nostra regione. Andare a cercare i motivi per cui una montagna si chiama così vuol dire andare a cercare le ragioni storiche, geografiche, ambientali di un territorio.»
La serata ha visto numerosi interventi del pubblico che ha posto domande e avuto risposte a piccole curiosità. La riflessione emersa è che, come sottolineato dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Cerise, «le montagne e i loro nomi possiedono una instabilità che è frutto della storia, della stessa geologia, delle lingue, dei dialetti e persino delle storpiature di questi.» Pelazza presenta un patrimonio di oronimi (circa 390 monti) in modo semplice e originale, ossia raggruppandoli in 12 gruppi di montagne che finiscono per comporre una specie di bouquet di fiori che consentono di acquisire dei nomi e in parte l’origine di questi. Il documento è accattivante, ironico e fortemente divulgativo e le citazioni presenti rappresentano un viatico interessante per introdurre il pubblico a questa branca del sapere.
Il Consiglio regionale ha voluto sostenere questo progetto perché, come ha evidenziato il Presidente Cerise, «c’è necessità di sviluppare un cultura montana autoctona per valorizzare il rapporto di un popolo che vive dentro le montagne, intra montes. Questo compito spetta anche all’istituzione pubblica che deve cercare di aiutare la gente a scoprire il proprio territorio, la propria cultura e le proprie origini.»
A passeggio nel vocabolario dei monti valdostani, gli abitanti di Aosta scopriranno che la loro montagna di riferimento, il Monte Emilius, deve il suo nome – come racconta Umberto Pelazza – alla quattordicenne Emilie Argentier, sorella di Auguste Argentier (1830-1874) medico di Cogne e alpinista, che nel 1839 vi fu accompagnata dall’abbé Carrel, che la battezzò quindi in suo onore, «mentre i canonici aostani, per onorare papa Pio IX, avevano invece già pensato a Mont Pie che sarebbe stato un irriverente gioco di parole. Pie, infatti, è anche la gazza ladra.» Così come, i valligiani di Ayas e Gressoney sanno che il Monte Rosa non riceve il suo nome dagli splendidi tramonti che si possono ammirare sulle sue cime, bensì «rosa, roise, roese, reuse, roesy e simili sono voci di genere femminile giunte tramite i Celti e su tutta la catena alpina denotano le zone coperte di ghiaccio.» O ancora, alla corte del Monte Bianco, svela Pelazza, «l’attributo ‘bianco’ dovuto alle punte nevose è raro. I nomi, infatti, sono saliti dal basso, dove la neve viene e va. Quindi solitamente il ‘bianco’ rispecchia il colore delle rocce. Il candore delle nevi avrà certamente colpito l’immaginazione degli antichi abitanti della valle, ma ben più degni di attenzione erano per loro i valichi a quota inferiore, come il Colle del Piccolo San Bernardo, l’Alpis Graia di Strabone e Tacito: il celtico gray (greya in patois), bianco, indicava le rocce gessose del passo. Latinizzato in albus, l’aggettivo diventerà blanc sotto l’influsso franco-germanico. Nelle cronache locali, dopo Mont Alban, il Monte Bianco fu alternativamente Mon Maudit, Mont Mallet, Mont Malay, di evidente valore repulsivo. Il nome attuale apparirà soltanto nel 1744 e avrà la sua definitiva sanzione ad opera di De Saussure al tempo della prima ascensione.»