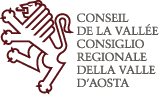Objet du Conseil n. 3047 du 20 février 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3047/XI Approvazione della relazione sanitaria e sociale 2001 ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 5/2000.
Deliberazione Il Consiglio
Vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali prodotte ed erogate nella Regione";
Visto l'articolo 4 - comma 1 - della suddetta legge, che prevede la predisposizione annuale della Relazione sanitaria e sociale da parte della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali;
Visto l'articolo 4 - comma 3 - della suddetta legge, che prevede che tale Relazione sia presentata dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Capo servizio Risorse, dal Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
di approvare l'allegata Relazione sanitaria e sociale 2001 ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 5/2000.
Allegato
(Omissis)
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Vorrei ringraziare anzitutto i colleghi consiglieri che hanno partecipato alla presentazione ufficiale di questa relazione, così come coloro che hanno lavorato all'interno della V Commissione consiliare; per questo motivo, do per letta la relazione che ho presentato in quella sede, che era collegata alla relazione sugli anziani, ma che ha una stretta attinenza rispetto alla relazione socio-sanitaria. Mi limito a fare alcune osservazioni in premessa di larga massima, rinviando al dibattito consiliare l'analisi nel merito delle singole questioni.
Inizio con il dire che questa è la prima ricerca campionaria sulla salute fatta in Valle d'Aosta che abbia un peso scientifico, perché sono state intervistate più di 1.200 famiglie con un numero cospicuo di interviste e mai un'indagine così ampia è stata realizzata in Valle d'Aosta; per cui, i dati che ne escono, hanno una grossa valenza dal punto di vista epidemiologico e della conoscenza della società valdostana, la quale si interseca trasversalmente su diversi settori e che va ben al di là della sanità e della salute, perché ci permette, per la prima volta forse, di fotografare sotto una luce diversa la nostra realtà.
Direi anche che questa ricerca è la prima che valuta sia gli aspetti socio-sanitari che gli aspetti sociali. Cosa ne esce fondamentalmente? Ne esce un elemento che, a mio parere, è da approfondire in questa e in altre sedi, vale a dire che dove c'è meno povertà e, al contrario, c'è più benessere economico, questo porta a più salute. Questo fenomeno ci deve far riflettere, perché dovremo indirizzare le nostre politiche - non mi riferisco solo alle politiche dell'Assessorato regionale alla sanità, ma anche alle politiche del Governo regionale e del Consiglio regionale - verso questi macro-obiettivi, per cui la sconfitta della povertà in Valle d'Aosta, il miglioramento del benessere, il rafforzamento delle reti di solidarietà, anche intergenerazionali, oltre che istituzionali.
Possiamo partire da un assunto che è apparentemente molto qualificante, quello secondo cui i Valdostani percepiscono il loro stato di salute per addirittura il 93 percento negli uomini e l'87 percento nelle donne come uno stato di salute che è o molto buono o buono: questo potrebbe tranquillizzarci per dire che non abbiamo più nulla da inventarci, dobbiamo mantenere l'esistente, dobbiamo monitorare il tutto. Vorrei invece analizzare criticamente questo dato, che è sicuramente positivo, ma che testimonia che dalla percezione di salute lo stato di salute effettivo poi corrisponde a questa sensazione che ognuno di noi ha; è importante percepire bene lo stato di salute, ma questo aspetto non deve far dimenticare che, a volte, il percepire bene il proprio stato di salute, nasconde una mancata politica di prevenzione e di cura da parte di ogni singolo cittadino. Questo è un altro degli aspetti su cui dobbiamo puntare, cioè l'informazione, la conoscenza, perché la salute la si difende autonomamente e con l'aiuto, ovviamente, delle istituzioni pubbliche, ovvero regioni, enti locali, "non profit", volontariato, terzo settore, ma fondamentalmente deve essere il cittadino che, autonomamente, deve interagire con le strutture pubbliche.
Un secondo assunto che esce dalla relazione è che lo stato di salute dei Valdostani è buono, che è migliore di altre regioni del nord Italia e che, sostanzialmente, possiamo dirci soddisfatti. Vorrei toccare però alcuni punti di criticità che non possono non partire dallo studio degli anziani. In Valle d'Aosta, nel 2000 abbiamo, con riferimento alla popolazione intera, il 18,5 percento di anziani ultrasessantacinquenni rispetto al 20,1 percento del Piemonte, al 16,5 percento del Trentino e al 17,7 percento per l'Italia. È un dato apparentemente in linea con le Regioni del nord Italia, ma se lo andiamo ad analizzare nel dettaglio - e partirei dall'indice di vecchiaia - vediamo che ci porterà a situazioni preoccupanti, alcune delle quali sono già assolutamente preoccupanti oggi.
L'indice di vecchiaia, che comprende il numero di anziani oltre i 65 anni rispetto ai bambini in età 0-14 anni, ci dà nel 2003 un numero di circa 150 anziani ogni 100 bambini, per proiettarci nel 2011 a 170, nel 2016 a 195, nel 2021 a 225, nel 2026 a 255 anziani per 100 bambini. Se questo è un dato incontrovertibile, a meno che politiche familiari, situazioni socioeconomiche generali non solo della Valle d'Aosta, ma dell'Italia e dell'Europa intera, non controbilancino questa tendenza, è assodato che vivremo in una società di anziani. E la nostra proiezione come Valle d'Aosta rispetto al Piemonte non si differenzia di molto, ma si differenzia rispetto all'Italia e rispetto al Trentino Alto Adige, dove, a fronte dei nostri 255 anziani per 100 bambini del 2026, il Trentino ne avrà solo 200. Questo differenziale demografico è anche un differenziale in termini di salute, perché la correlazione diretta tra invecchiamento della popolazione e salute è un dato incontrovertibile.
Se passiamo all'indice di vecchiaia esistente, suddiviso per comune della Valle d'Aosta, segnalo che già oggi alcuni comuni hanno un indice di vecchiaia che va dal 156,9 per 100 bambini a addirittura 350 per 100 bambini. Nelle schede che vi ho consegnato sono evidenziati in nero questi comuni; li cito perché gli amministratori comunali di questi comuni devono seriamente pensare alla sopravvivenza dei comuni stessi; sono i Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Ollomont, Doues, Allein, Chamois, Bard, Arnad, Verrès, Issogne, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Brusson, Saint-Vincent, Saint-Denis, Verrayes, Gaby, Fontainemore, Perloz, Saint-Marcel, Cogne, Rhêmes-Saint-Georges. In questa scheda vediamo che nella "banlieue" di Aosta vi è una situazione migliore, ma probabilmente questo fatto è dovuto all'effetto attrattivo della città di Aosta rispetto alle realtà periferiche che sono dotate di meno servizi rispetto alla città.
Questa fotografia della realtà valdostana è drammatica, perché deve far riflettere non solo gli amministratori comunali, ma "in primis" questa Assemblea su tutte le politiche, da quelle scolastiche a quelle di investimento, dalle politiche produttive, al turismo. Dobbiamo assolutamente far sì che i servizi vadano sul territorio, che Aosta venga decongestionata perché ogni posto di lavoro nella periferia produce un volano economico e un volano sociale incontrovertibile. Non vi è alternativa, in Valle d'Aosta, a questa politica di territorializzazione di servizi, di servizi non in senso stretto, ma di servizi intesi come attività produttiva, perché il reddito di ogni singolo nucleo familiare è prodotto dal lavoro.
Rispetto alla struttura socio-demografica della Valle d'Aosta, questo è un altro punto di criticità che voglio sottolineare: assieme a quello degli anziani, vi è un'alta prevalenza di persone sole, singoli fra gli adulti e vedove - quest'ultimo dato per effetto della maggiore sopravvivenza delle donne -, e una significativa proporzione di famiglie separate con minori dipendenti. Ne parleremo dopo per dare delle indicazioni. Tralascio quelli che sono stati evidenziati come gli stili negativi in ordine di importanza; ne cito solo alcuni: fuma un uomo su quattro, una donna su cinque, fa vita sedentaria un uomo su cinque, una donna su quattro, un anziano su tre; è obeso un adulto su quindici, un anziano su dieci; sono forti bevitori di vino una persona su quindici. Rispetto all'abitudine del fumo essa è andata diminuendo fra i giovani: oggi fumano cinque giovani su dieci adulti, contro sette su dieci tra gli anziani. Il rapporto nelle donne è aumentato quattro su dieci oggi, due contro dieci tra le anziane.
Rispetto agli stili di vita, quelli negativi si associano spesso a condizioni di svantaggio sociale e questo è il terzo elemento di valutazione. Il fumo è una volta e mezzo superiore negli uomini con basso titolo di studio. C'è inoltre una stretta correlazione tra condizioni sociali, accesso ai servizi sociosanitari e condizioni di salute.
Rispetto alle malattie croniche, come è stato detto, siamo in linea con le regioni del Nord e meglio della media nazionale. Le malattie croniche si studiano per stimare i carichi assistenziali, necessari a rispondere al bisogno con il servizio pubblico. Sono in questo caso le malattie diagnosticate da un medico e riferite dall'intervistatore, per cui vi è un rischio di sottostima di malattie che non si dichiarano volentieri. Questo dato va preso quindi con beneficio di inventario: alcune malattie classiche, dalla cirrosi al tumore, a tante altre, non vengono dichiarate dal cittadino all'intervistatore, però questo rischio di sottostima lo registrano anche le altre regioni. In Valle d'Aosta il 21 percento degli uomini adulti e il 29,4 percento delle donne, il 55 percento degli uomini anziani e il 66 percento delle donne anziane dichiara almeno una malattia cronica.
Passo al terzo aspetto che voglio sottolineare, dopo l'anzianità, che è quello della disabilità, che è sì in linea con le altre regioni, ma sappiamo che si tratta purtroppo ovunque di una dato ancora sottostimato, perché non vi è ombra di dubbio che vi è molto sommerso. Il 2003, quest'anno, è l'anno del disabile, è in arrivo una nuova classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che rivoluzionerà la logica di approccio alla disabilità; logica che passa da "cosa gli manca per essere normale" a "cosa gli serve per avere la stessa funzionalità del normale". Nell'ambito lavorativo questa viene definita la "residua capacità lavorativa". Questo certamente porterà una ridefinizione dell'elenco nominativo dei disabili, non solo in Valle d'Aosta e sarà molto positivo, perché permetterà di fare interventi mirati sul vero disabile. Permetterà, nel momento in cui avremo definito le categorie, di indirizzare le nostre politiche rispetto alle diverse situazioni.
Rispetto ai disabili c'è da evidenziare, come su altri versanti, una differenziazione fra donne e uomini; nelle donne vi è una minore prevalenza rispetto alla media nazionale, negli uomini vi è più difficoltà nel movimento rispetto alla media nazionale, e su questo versante si deve anche sottolineare il grosso peso che ha nella disabilità il lavoro manuale, rispetto al lavoro non manuale, per cui è un altro dei settori su cui dovremo porre molta attenzione in termini preventivi.
Vado per sommi capi e mi riferisco a un altro capitolo che è fondamentale, il capitolo della prevenzione, citando, per antonomasia, la prevenzione secondaria che facciamo attraverso pap-test e mammografie. Segnalo che sotto l'età di 65 anni l'82 percento delle donne ha effettuato un pap-test nei 12 mesi che hanno preceduto l'intervista incluso quello organizzato dall'Assessorato regionale alla sanità e gestito dall'azienda USL, mentre sopra i 65 anni è ricorsa al pap-test il 40 percento. Questo è un dato molto incoraggiante e positivo. Rispetto alla mammografia ne hanno ricorso, incluso lo "screening", solo il 45,5 percento delle donne di età inferiore ai 65 anni e identica percentuale sopra i 65 anni. È un dato buono nella media nazionale, ma può e deve essere migliorato se si tiene conto che l'età utile a fini preventivi per questo test è dai 50 ai 69 anni con un controllo biennale.
Dobbiamo capire perché il 55 percento circa delle donne in età a rischio non partecipa ad esami mammografici, quando è certo - e i dati ce lo segnalano - che spesso vengono diagnosticati dei tumori in fase ancora iniziale, cosa che permette alle donne di essere salvate. Dobbiamo impegnarci tutti a far sì che queste percentuali migliorino. Un dato interessante da sottolineare, in linea con la nostra cultura, è l'uso delle medicine non convenzionali. Ne fa uso un uomo su quattro e una donna su tre e il 20 percento degli anziani, che ricorrono maggiormente ai trattamenti manuali e alla fitoterapia. Siamo i maggiori utilizzatori di medicine non convenzionali, le donne si pareggiano con le donne trentine, e sono particolarmente elevati in entrambi i sessi e a tutte le età i trattamenti manuali e l'agopuntura.
Questo ci conforta del fatto che nel nostro piano sanitario abbiamo dedicato un capitolo specifico alle medicine convenzionali, anche se è un timido approccio a questo argomento che viene vissuto ancora dal mondo scientifico tradizionale con molta approssimazione e con una sorta di distacco, per non usare altri termini. Il tentativo, nel prossimo futuro, sarà di far entrare le medicine non convenzionali nei livelli essenziali di assistenza. (Sapete che la Regione Piemonte ha legiferato in questo senso, ma che il Governo ha impugnato la legge che prevedeva il riconoscimento dei titoli). È interessante anche qui rilevare dalla Relazione che le medicine non convenzionali allo stato attuale sono appannaggio quasi esclusivo di persone che hanno alta istruzione, che hanno storie lavorative non manuali, che non sono coniugate - in special modo donne -, e che giudicano positivamente le loro risorse economiche. Sono quindi le classi sociali elevate più sensibili al disagio psicologico, che scelgono metodi alternativi e più personalizzati rispetto alla medicina tradizionale, probabilmente anche senza abbandonare la medicina tradizionale in quanto tale, ma optando sicuramente per un approccio alle medicine cosiddette "non convenzionali".
Vado rapidamente alle conclusioni, perché mi riservo di sentire il dibattito che ne deriverà, per dire che la salute, la prevenzione e il ricorso ai servizi sono buoni, ma l'analisi delle differenze sociali indica delle "riserve di salute" ancora possibili fra i gruppi di popolazione a minore vantaggio sociale. Mi pare che da quanto emerge dalle due relazioni (la Relazione Sanitaria e Sociale 2001 e quelle sugli Anziani) si possa concentrare l'attenzione su tre categorie di soggetti: le persone sole, le persone a basso reddito e le persone a bassa istruzione. Non vi è ombra di dubbio che questi sono i settori, anche se è un termine che non vorrei usare, sui quali dobbiamo puntare l'attenzione, perché la solitudine, il basso reddito e la bassa istruzione sono i settori che più incidono sia sulla spesa sanitaria, che sul benessere fisico e mentale dei Valdostani. Gli anziani soli, non coniugati e le persone che vivono in solitudine rappresentano una quota di vulnerabilità sociale che ha bisogno di salute maggiore e di maggiore assistenza da parte delle istituzioni.
Nella presentazione ho detto che dobbiamo puntare su una sanità pubblica più equa e solidale, che punti di nuovo a rivalutare la rete intergenerazionale, la rete dei villaggi, la rete del "non profit", rete che ha una grossa valenza in Valle d'Aosta, soprattutto nelle fasce forti che possono aiutare le fasce deboli. Dobbiamo puntare su una sanità pubblica equa e solidale, che significa personalizzare le politiche, significa investire sui servizi sociosanitari, ma questo non significa investire senza avere degli obiettivi precisi: significa, al contrario, mirare a dare alle fasce più deboli quello che ancora oggi non ottengono o ottengono con difficoltà.
Mi pare di poter concludere che questi due documenti, la relazione socio-sanitaria e il documento riguardante gli anziani - anche se oggi esaminiamo solo la relazione socio-sanitaria, perché così dice la legge - sono dei breviari che dovremmo aprire periodicamente. Non lasciamoli nel cassetto, perché ogni pagina di questi merita attenzione, approfondimento e investimenti. È questo l'invito che ho rivolto agli amministratori comunali, alle parrocchie e al settore del "non profit", perché la società valdostana che sta bene può e deve migliorare nei prossimi anni.
Président Le débat est ouvert.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Farò un intervento che forse non appare così organico, perché volevo soffermarmi su due o tre aspetti particolari.
Innanzitutto una premessa. Credo che chi, come la sottoscritta, sente la necessità di avere dati sulla conoscenza della situazione sanitaria, sui bisogni espressi e non, sugli esiti degli interventi, sulle criticità esistenti, per poter cogliere quali sono le priorità, per operare delle scelte, ha letto con interesse, e ha seguito attentamente la presentazione di questa relazione. Questa relazione dimostra anche all'Assessore che ha avuto così tanta difficoltà a metterlo in cantiere, l'importanza dell'Osservatorio epidemiologico, che recentemente è stato esteso anche alle politiche sociali. Ricordo che in tutta la passata legislatura inutilmente la sottoscritta aveva chiesto l'istituzione di questo servizio all'interno dell'Assessorato della sanità. Ben vengano, dunque, questi studi e questi dati, specie se frutto di ricerca scientificamente corrette, specie se consentono di operare confronti con le realtà nazionali e con quelle di regioni omogenee, su una serie di indicatori chiari.
Ci dispiace al massimo che la Regione non si sia ancora attrezzata per gestire in modo informatico tali dati e che debba ricorrere a consulenze esterne, seppure molto qualificate, ma tali da non creare in loco delle professionalità e delle "expertises", che poi possono continuare a fare questo tipo di lavoro di ricerca ed analisi dati. Quanto detto vale essenzialmente per la parte sanitaria, che ha utilizzato i dati dell'indagine ISTAT sulla salute degli Italiani per descrivere la situazione così come viene percepita dai cittadini, e lo ha fatto - questo è l'aspetto interessante - mettendolo in relazione con dati geografici, demografici, culturali, così da individuare quali sono le categorie più esposte alle malattie o a certi tipi di malattie.
In alcuni casi si ha l'impressione che i dati siano riportati e commentati in modo benevolo. Faccio un esempio che avevo già sollevato in commissione: per descrivere il livello di istruzione vengono accorpati due titoli di studio - diploma e laurea - e, pur sapendo che in Valle il tasso di laureati è molto basso rispetto ai dati nazionali, non lo si è scorporato dai dati dei diplomati. Si può dire allora che in Valle d'Aosta il livello di istruzione è comparabile a quello delle altre regioni praticamente per tutti i livelli considerati: questo non è del tutto vero, forse era più corretto fornire ugualmente il dato e spiegare poi il motivo dell'accorpamento. L'aspetto più interessante della relazione, come dicevo prima, è il fatto che i dati sono messi in relazione fra loro con analoghi dati degli stessi presentati a livello nazionale o regionale ed è da questo confronto che sorgono le questioni, perché, come ricordava due giorni fa il Professor Costa nella presentazione del documento, ricercare le differenze a livello di area territoriale fa evidenziare i problemi. Quanto ho detto finora non vale per la parte sociale della relazione, ma su questo tornerò in seguito nella seconda parte del mio intervento.
Come leggere questa relazione? Chi, come me, si aspettava una descrizione della situazione della sanità in Valle, cioè la relazione sociosanitaria classica, chi pensava di potersi trovare di fronte ad una relazione che faceva il punto sulla realizzazione del piano, è stato deluso; sa che deve aspettare altri momenti, ma c'è da chiedersi quali sono questi momenti! Non il momento del bilancio di previsione; non la relazione annuale che si fa in Consiglio, perché abbiamo visto che l'Assessore ha dato un altro taglio, motivandolo. Però questo momento non c'è; neanche la Conferenza sulla sanità, che pure era prevista nel piano, non è mai stata attuata. Questo sarebbe stato il momento in cui poter fare una pausa di riflessione e di analisi sulla situazione in generale: tutto questo non c'è! C'è, invece, la presentazione di uno studio-ricerca interessante, ma settoriale; ad esempio, chi fa l'esperienza rispetto ad altri servizi esistenti sul territorio, rispetto ad altri bisogni che non vengono intercettati, rispetto ad alcune tipologie di servizi sanitari che non rispondono alle esigenze dell'utente, si è trovato un po' spiazzato, perché non ha trovato nella relazione elementi di informazione. Studio, bisogna darne atto all'Assessore - forse sta sperimentando tecniche nuove di comunicazione quando forse sarà Presidente di Regione? - che è stato presentato in una conferenza pubblica con la partecipazione di esperti del settore e con modalità interessanti anche di comunicazione.
Cosa si può dire in Consiglio di questa ricerca? O se ne prende atto oppure si cerca di utilizzare questo momento del dibattito per riflettere su alcuni dati, per mettere a fuoco alcuni problemi: ed è questo che vorrei fare, d'altra parte è questo il taglio che ha dato l'Assessore nel presentare la sua relazione! Intanto è uno sguardo settoriale: infatti, chi frequenta l'Ospedale e si trova a vivere il dramma di persone che ancora muoiono senza poter fare un'esperienza di situazione umana in cui morire o chi deve fare l'esperienza di lunghe liste di attesa non trova, qui, nessuna eco ai suoi bisogni. D'altra parte proprio perché è settoriale, ha dei vantaggi interessanti, perché guarda a fondo alcuni aspetti, per esempio è interessante la descrizione delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione che troviamo all'inizio delle due parti della relazione. Qui vorrei sottolineare alcuni dati, per estrarre poi alcuni problemi, come ha fatto l'Assessore e come ci suggerisce la stessa relazione. Abbiamo molte persone che vivono sole, soprattutto uomini, un po' come succede nel Trentino Alto Adige, ma con tassi molto più alti rispetto all'Italia o ad altre regioni. Abbiamo un eccesso significativo di divorzi, di separati, di celibi, abbiamo i tassi di separazioni e di divorzio più alti d'Italia: su cento matrimoni quasi la metà termina con una separazione, 48 percento, e più di uno su quattro, 26 percento, si conclude con un divorzio.
Abbiamo un tasso molto basso rispetto alla media italiana delle coppie con figli; abbiamo la più ridotta ampiezza della famiglia, più del 60 percento sono famiglie mononucleosi. Ancora: le nascite fuori dal matrimonio costituiscono una percentuale elevata rispetto a quella delle altre regioni, quasi il doppio rispetto alla media nazionale; abbiamo un tasso di interruzione volontaria della gravidanza superiore a quello nazionale e a quello della zona omogenea dell'Italia settentrionale.
Sono dati di realtà che ci descrivono il contesto entro cui si collocano le azioni del piano sociosanitario. È un contesto che ci descrive una famiglia in grande difficoltà. La relazione insiste più volte sul fatto di aver cercato di esaminare tutti i problemi alla luce della famiglia, prendendo come punto di riferimento la famiglia. Se prendiamo questo riferimento, ci rendiamo conto che è una famiglia in grande difficoltà. È una famiglia che non ha, al suo interno, le risorse per far fronte alle situazioni, a volte improvvise, di malattia, di disagio, di disabilità. Suggerirei all'Assessore di utilizzare l'espressione "diversamente abile" invece di "disabile", espressione che anche la relazione, in alcuni punti, utilizza e che mi sembra sia stata richiesta in questo anno internazionale che riguarda i diversamente abili.
È una famiglia che da sola non può assumersi le responsabilità che la società, l'ente pubblico le demanda. C'è la cura dei bambini, ma questa famiglia in cui c'è solo la mamma e il bambino, collega Marguerettaz, fa sì che la donna sia costretta ad andare a lavorare non tanto per esigenze di carriera, ma per necessità di mantenimento! Se prendiamo i dati, più del 60 percento delle famiglie sono costituite da un solo nucleo, vediamo che c'è la necessità urgente per l'adulto di questa famiglia di lavorare e, contemporaneamente, deve guardare i bambini. C'è la cura degli anziani: l'Assessore ha ricordato la situazione di crescita progressiva degli anziani, ma già adesso la nostra esperienza dice che, in genere, molti adulti hanno due anziani da seguire. La famiglia da sola non riesce a far fronte a tutte queste situazioni! C'è l'assistenza ai dimessi dall'Ospedale; capisco che l'Ospedale voglia diventare Ospedale solo per acuti per tutta una serie di motivi: motivi di risparmio, di uso appropriato delle risorse; però se mandiamo a casa queste persone, queste non hanno le risorse nella rete familiare per far fronte alla momentanea infermità che hanno; se poi si è soli, la situazione è ancora più drammatica! Non è questo il momento di entrare nel merito delle motivazioni di questo modello familiare che si sta affermando, né era questo il compito della ricerca; probabilmente altre ricerche di carattere sociologico possono aiutarci a capire. Questa ricerca però ci aiuta a descrivere con più nitidezza quali sono i destinatari a cui la politica socio-sanitaria si rivolge, e credo che sarebbe importante leggere - come lavoro grosso che gli uffici devono fare e, insieme a loro. la Giunta e il Consiglio regionale - tutti gli interventi regionali, da quelli legislativi a quelli deliberativi, alla luce di questa situazione, perché solo in questo modo riusciamo a far parlare questi dati e ad utilizzarli. Per esempio, se leggessimo la legge sulla famiglia e gli altri interventi a favore della famiglia alla luce di questi dati, forse vedremmo l'inadeguatezza degli strumenti che sono stati messi in atto.
Ancora - qui riprendo il tema dello stato di salute, in rapporto all'analisi di alcuni elementi determinanti -: emergono, con chiarezza di dati, di cifre, di percentuali, fenomeni che sappiamo essere presenti in questa Regione e su cui più volte ci siamo soffermati anche in Consiglio. Intanto c'è l'uso-abuso di alcol: un costo sociale che si può calcolare in circa 15 milioni di euro all'anno - quanto serve ogni anno per finanziare i mutui prima casa - perché è all'origine di malattie epatiche, tre volte e mezzo negli uomini e oltre quattro volte nelle donne superiori al Piemonte, e di elevata mortalità per cancro negli uomini. Esiste anche l'uso-abuso del fumo, di cui tutti conosciamo il rapporto con il cancro ai polmoni. Non voglio elencare tutte le altre malattie, ma questi due elementi ci richiamano, con forza, l'esigenza di impostare azioni incisive per cambiare questa cultura del bere e del fumare.
A livello nazionale c'è una campagna contro il fumo, ci sono delle leggi ben precise, c'è tutto uno studio chiaro e un'informazione al riguardo; per quanto invece attiene all'uso-abuso di alcol, in questa Regione si fa troppo poco. Capisco che questo è un dato culturale molto importante, che c'è una cultura del bere, ma forse occorrerebbe pensare ad una cultura del bere bene, del bere in modo saggio e credo che su questo versante bisogna lavorare in modo serio tutti quanti. La salute non è solo questione di sanità, ma anche di cultura, di rapporti relazionali, è l'espressione di tutta una serie di esperienze, di situazioni economiche, affettive, sociali, culturali; è illusorio che la salute si tuteli solo con interventi sanitari. Credo che questo sia un dato che emerge con forza dalla relazione e allora c'è da chiedersi fino a che punto la stessa Giunta sia consapevole che le scelte che vengono fatte, nei diversi settori, hanno comunque un impatto sui determinanti la salute. Credo che l'Assessore ne sia consapevole - più volte lo ha detto anche in questo Consiglio - però mi sembra che finora non ci sia stata da parte della Giunta una consapevolezza di questo problema e una presa in carico di come sia necessario, nei diversi settori, impostare delle scelte tali da incidere in modo positivo sulle condizioni che determinano lo stato di salute.
Questa relazione ha un senso se diventa criterio da tener presente nelle scelte amministrative quotidiane. Intanto è apparso chiaro come la persona più deprivata per denaro, cultura, relazioni affettive, è quella più esposta alla malattia e al maggior rischio. Ogni azione che mira a consentire alle persone di avere più risorse economiche, più cultura, più vita sociale, pertanto è un intervento che opera nell'ottica di migliorare la qualità della vita, di contrastare le condizioni che sono causa diretta o indiretta della malattia, della disabilità o della morte precoce; ad esempio, tutto lo sforzo che si fa per non emarginare le persone, lo si fa non solo perché questo avrebbe un costo sociale, ma avrebbe anche un costo economico, perché creeremmo le premesse che rendono queste persone più facilmente aggredibili dalla malattia.
C'è da chiedersi se non occorra porre più attenzione alla scuola, alla sua capacità di fornire istruzione, di far venire voglia di continuare ad istruirsi; purtroppo, proprio in questo settore, si devono registrare in Valle percentuali di insuccessi molto alti rispetto alla media nazionale. Operare in questo settore significa allora operare per la salute complessiva dei cittadini, ma questo va preso come un punto importante di un programma di governo. C'è da chiedersi se è utile per la Regione continuare a promuovere per i propri concittadini lavori poco qualificanti, dai cantieri forestali agli addetti agli impianti sciistici, o se è opportuno favorire il proliferare di imprese edili in proporzione quasi doppia rispetto al territorio nazionale: tutto sommato, si sostengono attività che sono ad alto rischio per la salute.
C'è da chiedersi se non occorra mettere in atto un'azione ferma di contrasto alla povertà, che risulta uno dei fattori di rischio più alti per la salute; azione che, finora, non vedo e, se analizziamo gli interventi della Giunta, c'è da chiedersi quanti interventi sono fatti a favore delle fasce più deprivate e quanti a favore delle fasce che già godono un certo benessere. Ci spostiamo così nella parte del sociale. Questa è la parte meno organizzata scientificamente, è la parte in cui vengono descritti i servizi esistenti ma, quasi si volesse fare una relazione informativa a chi non conosce ancora la situazione, manca - o è poco presente - l'individuazione di aspetti critici, di punti deboli da ripensare. Le confesso, Assessore, che quando ho letto questa relazione, la conclusione che ne ho tratto è stata la seguente: tutto quanto andava fatto è stato realizzato in tutti i settori, tutto è stato fatto tenendo conto del piano socio-sanitario le cui linee sono state realizzate: se la finalità era apologetica, credo che l'obiettivo è stato raggiunto. In genere, però, le relazioni servono per fare il punto su una questione, per verificare se la strada scelta ha dato dei risultati, per esaminare la ricaduta degli interventi, per individuare i punti più deboli da rivedere, per mettere in luce le carenze su cui intervenire e, in questo caso, nella parte sociale non troviamo nulla di tutto questo! È come se l'estensore della relazione avesse avuto un "input politico", ovvero non dare adito a possibili critiche, a possibili dubbi, a possibili aspetti problematici.
Porto alcuni esempi. Viene enfatizzata l'importanza della legge sulla famiglia, specie per gli aiuti che vengono dati per i bambini fino a tre anni come contributo economico per crescere i più piccoli. Fra questi c'è anche il contributo per le gestanti sole, per il quale qui viene descritta minuziosamente la procedura; pare un intervento interessante finalizzato ad una categoria precisa, quella appunto delle donne sole con bambino, e tutta la descrizione contribuisce a trasmettere a chi legge la relazione l'importanza dell'intervento. Peccato che nel 2001 solo una gestante abbia goduto di questo contributo ma, a fronte di un simile dato, ci si sarebbe aspettato almeno un dubbio sull'efficacia di questo intervento, un interrogativo sull'eventualità di ripensarlo: o scegliendo meglio il destinatario, o verificando se la procedura da seguire o l'importo modesto o, ancora, la limitatezza temporale dell'aiuto - fino a tre mesi di età del bambino - non rendessero poco accessibile, poco appetibile o poco efficace tale aiuto; invece, niente di tutto ciò, la non utilizzazione di tale misura non pone problema!
A cosa serve allora rilevare questo dato se non si accompagna l'osservazione con la ricerca dei motivi del fallimento di questa misura: una sola persona in un anno! Se l'obiettivo era quello di aiutare la donna sola, incinta, a non ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, sicuramente questa misura si è rivelata inefficace, specie se la confrontiamo con il numero di interruzioni volontarie della gravidanza che persistono, e, nonostante alcune lievi flessioni, sono in aumento proprio nelle fasce più a rischio, quelle dai 15-19 anni o dai 25-29.
Altro esempio: viene elencato tra gli aiuti alla famiglia anche il sostegno alle coppie in difficoltà tramite il servizio di consulenza legale, in sei mesi sessantuno utenti: dieci utenti al mese, due-tre alla settimana. Vengono elencati gli argomenti su cui si sono concentrate le richieste degli utenti e si conclude affermando: "questo servizio è il risultato rispondente all'obiettivo di sostenere le famiglie, soprattutto nei momenti di crisi e di difficoltà". Quante sono le famiglie valdostane in difficoltà? Abbiamo la percentuale più alta di separazioni e di divorzi - lo abbiamo ricordato prima - e non ci si chiede nemmeno quale percentuale di famiglie o di coppie in difficoltà si riesce a raggiungere con questo tipo di servizio! Si ricorda che la gestione dei servizi per l'infanzia è demandata ai comuni, agli enti locali, ma non un cenno al timore che questo si traduca in una disparità di servizi offerti a livello locale; eppure so che c'è questa preoccupazione e che esiste addirittura un servizio regionale per coordinare, sostenere, offrire consulenza a tali servizi territoriali e il territorio - lo ricordava prima l'Assessore - è uno dei punti nodali da presiedere, proprio anche ai fini di facilitare la permanenza di famiglie giovani e l'inversione dell'indice demografico.
Sempre per quanto riguarda gli asili nido, si dice che gli asili nido offrono una copertura dell'utenza del 12 percento, superiore alla media nazionale, ma non si ricorda che in Valle -come anticipavo ieri mattina intervenendo su altro argomento - è più alto rispetto alle altre regioni il tasso di occupazione femminile, per cui è più presente e sentita che altrove l'esigenza di trovare i servizi di cura all'infanzia. Nella parte relativa alle povertà, le informazioni sono per lo più opera di ricerche di enti e associazioni esterne all'Amministrazione. Certamente questi dati saranno approfonditi ed ampliati grazie al lavoro della Commissione regionale sullo stato della povertà e dell'esclusione sociale, istituita da pochi mesi ma, alcuni di questi dati, confrontati con quelli in possesso degli uffici, potrebbero darci immediatamente delle informazioni e suggerirci delle domande.
Ad esempio, si dice che sono 32 i minori assistiti mediante interventi economici straordinari, grazie all'articolo 8 della legge regionale n. 17/1984: questo a pagina 147 della relazione. Si dice però, a pagina 149, che sono 84 i minori che "si affidano agli alimenti del Banco alimentare", quasi tre volte tanto. Come mai tutti questi bambini non sono intercettati dai servizi sociali e/o non rientrano negli aiuti previsti dalla legge? Non sarebbe opportuno fare una verifica incrociata…
(interruzione dell'Assessore Vicquéry, fuori microfono)
… non è escluso, ma se 32 sono i minori assistiti e 84 sono quelli che si affidano al "Banco alimentare", supponiamo pure che di quegli 84, 32 sono assistiti, ma gli altri 52? Non sarebbe opportuno fare una verifica incrociata? Non sarebbe stato opportuno rilevarlo per individuare una pista di ricerca sulla funzionalità delle risposte che noi crediamo di dare ai bisogni delle persone? Mentre la prima parte sanitaria, dicevo prima, acquista la sua importanza proprio dalla capacità di mettere in relazione fra loro i diversi dati, perché questo fa emergere il problema, qui, in questa parte di relazione, è come se mancasse la capacità di mettere a confronto fra di loro i dati. Poiché chi ha redatto la redazione è sicuramente una persona esperta, si può ragionevolmente ipotizzare che c'è stata la scelta - suggerita da qualcuno? - di non collegare tra loro i dati, di non fare emergere la rispondenza delle risposte date ai bisogni evidenziati, di non sollevare problemi, di non sottolineare le difficoltà sia di intercettare i bisogni, sia di darvi una risposta adeguata in tempi brevi? Non fa ancora problema il fatto che la persona che si rivolge ai servizi sociali per un aiuto, previsto dalla legge del minimo vitale, che quindi necessita urgentemente di un aiuto, debba aspettare mesi, due almeno, per avere il contributo che gli sarebbe stato necessario 60 giorni prima, per pagare l'affitto o per comperarsi il necessario per vivere? Le assistenti sociali, da tempo, hanno sollevato - inascoltate - questo problema! Sono individuati i bisogni cui è già stata data una risposta e sembra che, al di fuori di quelli, non ci sia altro da fare!
L'elemento più negativo che accomuna tutta questa parte del sociale è che diverse informazioni vengono collocate sullo stesso piano, senza che siano evidenziate priorità. Non sappiamo pertanto se ci sono dei settori e dei servizi carenti, se alcuni sono sovradimensionati rispetto all'utenza, o se alcuni vanno ripensati o potenziati. La relazione sociale fotografa una realtà senza luci ed ombre, senza che siano evidenziati i primi e i secondi piani e messi in relazione con lo sfondo, per cui non è possibile individuare delle priorità.
Concordo con l'affermazione finale dell'Assessore, di voler avere una sanità equa e solidale; però, per ottenere questo, forse occorrerebbe analizzare tutti gli interventi che già ci sono in questa ottica e verificare se insieme concorrono a questo obiettivo, altrimenti ci troviamo di fronte a un corpo decisionale che è schizofrenico!
Si dà atto che il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare alle ore 16,57.
Président La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA) Non c'è dubbio che la relazione predisposta dall'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, che ho trovato puntuali nelle varie parti, offre un panorama su quelli che sono gli effettivi bisogni nel campo socio-sanitario e quindi offre a noi tutti un supporto alle scelte che si dovranno fare.
Il settore quale quello della sanità e del sociale è sicuramente importante per la vita di noi tutti. È quindi opportuno salvaguardare, secondo me, i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza nell'ambito del settore sanitario e sociale, pur tenendo conto dei costi sempre più in aumento: tutto questo per una migliore qualità della vita dei cittadini valdostani. È vero che nel bilancio 2002/2004 si prevedeva una spesa per il settore sanitario e del sociale di circa 26 milioni di euro, ma credo che occorra - e qui rivolgo un invito all'Assessore e alla Giunta - fare uno sforzo maggiore per incrementare con i finanziamenti necessari alcuni servizi ancora carenti nel territorio regionale. Occorre pertanto dare effettiva attuazione al nuovo piano socio-sanitario regionale, piano che, nelle sue intenzioni, si prefigge alcuni obbiettivi anche ambiziosi, e quindi ci auguriamo che venga tradotto, in termini pratici, dalle intenzioni nei fatti, alla luce anche di questa approfondita relazione. Il piano che prevede la razionalizzazione e l'organizzazione del servizio socio-sanitario va verso questa direzione.
Vorrei, in questa occasione, fare alcune considerazioni personali per portare il mio contributo al dibattito. Leggerò prima però alcune parti della relazione - che ritengo importanti - per sollecitare in noi un'attenta analisi sulle vere problematiche che ancora rimangono da risolvere nel settore socio sanitario. Mi rifaccio ad alcune considerazioni di presentazione da parte dell'Assessore, in occasione dell'incontro del 18, una relazione che ho trovato interessantissima: in una società benestante le disuguaglianze sociali pesano proporzionalmente in misura maggiore e, notoriamente, popolazioni con salute deprivata percepiscono ed esprimono i bisogni di salute minori; la salute della popolazione è determinata soprattutto da fattori socio-economici indipendenti dai settori sanitari, ma è opinione fin troppo diffusa ritenere che ulteriori miglioramenti di salute si possono produrre soprattutto con i soli interventi sanitari.
Interessante anche la parte conclusiva: per la prima volta disponiamo, con queste due pubblicazioni, di una lettura congiunta dello stato di salute e di disagio sociale e di come il secondo incida negativamente sul primo. Occorre imparare a considerare la salute come la risultanza di molti fattori, che giacciono all'interno della nostra comunità e di cui siamo tutti in parte responsabili: l'isolamento e la solitudine, l'alta percentuale di persone sole - particolarmente di persone anziane - e di famiglie monogenitoriali con figli a carico, sono la prova che serve più aiuto.
Per quanto riguarda alcune indicazioni che voglio dare, un riferimento specifico lo voglio fare alle strutture, visto che la relazione fa riferimento al potenziamento sul territorio e lo citava anche l'Assessore nelle premesse del suo intervento. Il nuovo piano socio sanitario dovrebbe riservare più attenzione verso quelli che sono i servizi rivolti al territorio, la definizione dei macro-distretti, e verso coloro che dovranno dirigere i macro-distretti. Siamo infatti convinti che con il decentramento ed il potenziamento dei vari servizi sul territorio, adeguando sia la presenza di presidi sanitari decentrati, sia incrementando i servizi domiciliari, si potranno dare le prime risposte sanitarie il più vicino possibile alle dimore dei cittadini, rispondendo pienamente ai dettati della legge n. 833; servizi che dovranno comportare la riduzione dei tempi per le liste di attesa ancora, purtroppo, con tempi lunghi, in particolare per quanto attiene gli esami di laboratorio, le visite, interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri.
Un'altra puntualizzazione già fatta in altre occasioni in questo Consiglio, e che intendo riproporre oggi, è che occorre prestare un'attenzione più incisiva e puntuale alla "cooperazione sociale" ed al "privato-sociale", componente che sarà sempre più necessaria, sia per ridurre la burocratizzazione dell'ente pubblico, sia per sfruttare a vantaggio della collettività le grandi risorse del volontariato da cui quel settore è animato e, in gran parte, promosso: un fiore all'occhiello per la nostra Regione, ma è necessario, per non vanificare l'impegno delle persone coinvolte, da una parte, dare indicazioni e regole precise riguardo alle attività gestite ed al controllo delle stesse e, dall'altra, decidere con rapidità i finanziamenti necessari. Il privato-sociale fornisce rilevanti servizi alla collettività, a costi inferiori rispetto a quelli che sopporterebbe l'ente pubblico per i medesimi servizi.
Un altro settore delicato è quello dei malati di mente, dei malati di Alzheimer, persone che versano in stato di infermità mentale. Numerosi familiari tutori hanno manifestato, oltre che il proprio disagio per i propri cari, anche quello di recarsi in istituti fuori Valle; i malati che sono ospitati da tempo, cercherebbero di poter rientrare in Valle. Un altro problema è quello dell'assistenza e dei servizi rivolti agli anziani. Le microcomunità non sono purtroppo in grado di soddisfare particolari casi di persone anziane che necessitano di continua assistenza, persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio e, dall'altro canto, questo non è compito delle microcomunità! Le strutture previste per questi casi, sono le Residenze Sanitarie Assistenziali, poche, per la verità, individuate in Valle d'Aosta. Le Residenze Sanitarie Assistenziali devono essere individuate in prossimità di strutture ospedaliere o poliambulatoriali: la stessa legge istitutiva lo sancisce. Per questi particolari casi di anziani, occorre infatti che nelle Residenze Sanitarie Assistenziali ci sia l'indispensabile presenza assidua di personale medico e paramedico, quindi personale che non è certamente così facile da reperire in Valle. A proposito di Residenze Sanitarie Assistenziali, credo che sia prossima la definizione dei lavori della magnifica struttura di Antey, una struttura che sicuramente potrà essere utilizzata, considerata l'ampiezza della stessa, per servizi non solo a carattere comprensoriale, ma anche, a parer mio, per servizi di livello regionale. Un servizio sicuramente ancora decisamente carente è quello della fisioterapia e della riabilitazione: occorre, Assessore, trovare gli strumenti legislativi e burocratici per il reperimento di fisioterapisti. Conosco la difficoltà, ma occorre un impegno particolare dell'Assessore e di noi tutti per reperire tale personale: è un servizio indispensabile, soprattutto per le persone anziane.
Ho cercato di elencare alcune particolari esigenze improcrastinabili, ma perché tutto quanto detto possa avvenire nel modo migliore dei modi, occorre innanzitutto provvedere affinché l'azienda USL sia sempre più autonoma nella sua attività gestionale, e quindi garantire alla stessa gli strumenti necessari per una libertà di azione. Tutto quanto detto le permetterebbe una più snella, sburocratizzata e tempestiva azione, se vogliamo che si possa definire una "USL al passo con i tempi"; in particolare, un'azienda che deve gestire la sanità pubblica, con esigenze che non possono essere rimandate nel tempo. Queste erano alcune considerazioni che intendevo riproporre in Consiglio; dico "riproporre" perché, in alcune occasioni, le avevo già sottolineate; è stata la stessa relazione - devo dire un'ottima relazione - che mi ha dato lo spunto per fare questo tipo di intervento.
Président La parole à la Conseillère Charles Teresa.
Charles (UV) Comme il a été dit, après l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 5/2000, l'article 4 prévoit que la structure régionale compétente en matière de santé rédige chaque année un rapport en matière de santé et d'aide sociale relatif à l'année précédente.
Ce rapport, que nous avons examiné et évalué en Vème Commission, et je pense avoir ici la confiance aussi du Président de la commission et du collègue de mon groupe, même si parfois il est un peu dangereux de compter sur la confiance des collègues, ce rapport est un outil d'information et de connaissance des dynamiques et des exigences du monde de la santé, une planète qui nous touche de près, afin de définir les besoins de personnes atteintes par les maladies et leurs proches, ainsi que les choix dans le domaine des politiques sociales. Il s'agit d'une bonne mesure pour approcher le Conseil régional à la population et pour faire connaître ces problèmes à la presse, comme il s'est vérifié par exemple avant-hier, à travers la présentation du rapport sanitaire et de la monographie consacrée aux personnes âgées, avec des rapporteurs de renom et toute la discussion qui a suivi.
Ce deuxième rapport est très exhaustif, beaucoup plus complet que le précédent, il continue comme l'année précédente à considérer les deux versants, santé et politique sociale et, au fil des pages, nous avons devant nous une comparaison constante entre notre situation sanitaire et d'autres régions italiennes, notamment le Piémont, le Trentin, outre le reste de l'Italie. En particulier, il traite dans le domaine de la santé de l'enquête que l'ISTAT a menée en Vallée d'Aoste sur les conditions de santé et le recours aux services sanitaires, enquête qui se répète tous les cinq ans à travers des interviews. Cette dernière enquête, menée grâce aux contributions du Fonds sanitaire national, a été faite sur un échantillon très important.
Les résultats de cette enquête assez analytiques permettent d'examiner un vaste panorama sur l'état de santé de la population valdôtaine, la présence de handicaps de toute nature, le style de vie, la prévention, le recours aux médicaments, les thérapies non conventionnelles. En Vallée d'Aoste, dans 35 communes ont été interviewés 1.224 familles et 2.800 et plus personnes, en choisissant différentes catégories de personnes sur la base du niveau d'instruction, de l'état civil, de l'activité professionnelle, des ressources économiques. On a examiné la population du point de vue de la structure démographique, familiale, sociale et tous les facteurs positifs et négatifs qui déterminent l'état de santé, voire le style de vie - l'Assesseur en a parlé très bien avant -, l'alimentation, l'obésité, la fumée, l'utilisation du tabac, alcool, activité physique, ainsi que le contexte de vie, c'est-à-dire les conditions socio-économiques, l'environnement en tant que territoire, mais aussi, en tant que distribution de la population, eau, air, gestion des ordures, incendies, avalanches, les choses qui nous ont touchés de près dernièrement.
On a vu la santé au sens strict du terme analysée en tant que perception, et là il est pour moi-même étonnant d'apprendre que 93 pour cent d'hommes répondent qu'ils se portent très bien, et, par contre, il n'y a que 87 pour cent des femmes qui donnent la même réponse. Après le problème des maladies chroniques: par exemple, il y en a moins dans les petits centres, raison en plus toujours et aussi pour d'autres raisons que de garder les petits centres vivants. Après tous les problèmes des personnes handicapées ou - comme il a été justement suggéré par Mme Squarzino - différemment habiles, les maladies infectieuses, la natalité, fécondité, interruption de la grossesse volontaire et spontanée, utilisation des médicaments conventionnels et non: là, par exemple, il faut bien dire que dans notre Vallée d'Aoste cette médicine non conventionnelle, c'est-à-dire traditionnelle, a toujours été très exploitée dans le passé et il me plaît de rappeler ici la figure d'un ancien conseiller, Rolando, qui a traité ce secteur, et après encore mortalité relative à toute la dernière décennie. Par la suite, le rapport analyse les services aux citoyens, l'offre sanitaire et la satisfaction que les citoyens déclarent, pour arriver à une conclusion: qu'il y a souvent un juste rapport du Valdôtain avec la médecine et, normalement, aussi un juste recours à la médicine, mais qu'il faut encore bien travailler - et le rapport le dit bien honnêtement - surtout pour les catégories défavorisées et les catégories moins privilégiées. Il y a aussi des tableaux, qui permettent de mieux comprendre un discours, qui est peut-être parfois technique, et qui nous permettent de saisir clairement toutes les données relatives à un problème, avec les distinctions médicales, d'âge, géographiques, comparaisons entre régions et vision sur l'évolution d'une maladie ou d'un phénomène à l'aide des banques de données officielles.
Enfin il y a la seconde partie, où on examine les politiques sociales, la distribution démographique, la constitution de la famille valdôtaine - on en a déjà parlé longuement - et après encore les frais pour l'activité sociale et d'assistance, la politique de la famille au sein de la société valdôtaine qui est en évolution perpétuelle. Nous avons certes changé plus dans ce dernier demi-siècle que pendant de millénaires, et donc nous nous trouvons confrontés à des nouveautés tous les jours.
Après, les interventions en faveur des personnes âgées, situations parfois lourdes à gérer pour les familles, soutien des couples en difficultés, services pour la première enfance et pour les âges qui suivent, comme le paiement de règlement mensuel des pensionnats, les colonies de vacance, l'A.D.E. - Service d'assistance éducative à domicile -, l'Observatoire régional pour l'enfance et l'adolescence, les politiques en faveur des personnes qui ne peuvent plus suffire à elles-mêmes, les interventions contre l'état de pauvreté et l'exclusion sociale, et le nombre des structures d'accueil qui ne peuvent pas être toujours à la hauteur du phénomène, comme les problèmes dont a parlé aussi l'Assesseur, par exemple la progression des personnes âgées, où il a dit que nous devons nous préoccuper quant à la dépense de tout cela.
Voilà, toutes les mille facettes des mille problèmes qui se posent quotidiennement; beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire, parce que les problématiques évoluent avec les nouveaux styles de vie, avec les prévisions de vieillissement de la population - dramatique, a dit l'Assesseur, cette progression - et il faut constamment s'assurer que l'argent sert vraiment à financer des services aux personnes, parce que les exigences changent et après nous devons nous mesurer tous les jours à l'explosion de la dépense et nous ne trouvons plus les moyens pour la contrôler. Pour rester aux problèmes que nous sommes demandés à traiter aujourd'hui, nous sommes appelés à juger ce rapport et je crois remarquer une chose importante. Ce rapport se présente comme honnête et exhaustif, c'est un rapport qui n'a pas de sujets "tabous" et cela est une très bonne chose, une chose qui fait honneur d'abord à l'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales, qui a travaillé passionnément et à l'autorité politique qui l'a soutenu.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (SA) No, collega Charles, non siamo qui a giudicare il rapporto, noi dovremmo essere qui a giudicare i contenuti, a trarne delle considerazioni e a proporre delle soluzioni. Certo, il rapporto è fatto molto bene, ma il compito del Consiglio regionale credo che dovrebbe andare oltre un semplice apprezzamento sulla bontà del lavoro svolto a livello tecnico con la redazione di questo rapporto. Vorrei quindi parlare anch'io, collega Charles, della famiglia valdostana, "le foyer", che non so più cosa abbia di valdostano, se non una mera residenza in un territorio, ma lei, collega Charles, e insieme a lei tanti in questo Consiglio, mi insegnate che quando - almeno fino a un po' di tempo fa - si parlava di "famiglia valdostana", il significato che questo aggettivo dava al sostantivo "famiglia" era ben più ampio e ben più importante rispetto a una sua semplice collocazione geografica.
Avete capito, colleghi, che non analizzerò il rapporto nella sua interezza; del resto, la parte sanitaria è già stata affrontata dal collega Piccolo. Approfitterei invece di questo rapporto per fermarmi a fare due considerazioni su quelle trenta pagine del rapporto che concernono le politiche familiari, la situazione della famiglia valdostana, come ho già detto. Su questo argomento mi sembra - ma capisco la difficoltà dell'Assessore di dover giungere ad una sintesi di un rapporto così corposo - che l'Assessore abbia non dico "sorvolato", ma si sia soffermato molto poco.
Cominciamo a vedere insieme ciò che ne esce da questo rapporto e scopriamo - come qualche collega ha già ben ricordato - che ci troviamo sotto la voce "caratteristiche della famiglia valdostana", cioè ciò che caratterizza, quindi per certi versi ciò che dovrebbe differenziare - la famiglia della nostra regione con le altre. Scopriamo, dal rapporto, che la famiglia valdostana ha il minor numero di componenti: 2,2 componenti ogni famiglia, uguale alla Regione che spesso ci fa compagnia in questi dati negativi, che è la Liguria. Abbiamo il numero più basso di famiglie che ho definito "tradizionali", cioè quelle famiglie che vengono definite "nucleari" dalla tabella e nella cui nota viene detto sono le famiglie dove vi sono componenti di due sessi con figli, quindi immagino che si intendano anche situazioni di matrimonio e di convivenza.
Comunque, anche se si conteggiassero convivenze non necessariamente legate da un contratto matrimoniale, anche tenendo conto di questo, la caratteristica della famiglia valdostana è di avere il più basso numero di famiglie nucleari: il 60-61 percento rispetto al 72 percento del Piemonte o al 75 percento della Lombardia. Questa famiglia valdostana - come già ribadito dall'Assessore - ha il maggior numero di persone sole: 36 percento rispetto a un 25 percento del Piemonte e un 22 percento della Lombardia, e, fra queste, vi è il più alto numero di famiglie di persone sole che diventano tali non per conseguenza di una vedovanza, ma per la conseguenza di un problema che è sorto; e qui una prima riflessione.
La situazione di solitudine in cui versano molte famiglie valdostane non è solo questione di demografia o di età, se sappiamo che il 48 percento di queste famiglie sole non è dovuto ad una vedovanza, dovrebbe sottintendersi che circa la metà è dovuto a vedovanza e quindi si presuppone che statisticamente almeno siano persone avanti nell'età, ma l'altra metà del cielo probabilmente è composta da persone non necessariamente anziane. Nel capitolo riguardante la costituzione della famiglia scopriamo che in Valle d'Aosta una nuova famiglia, cioè il momento in cui i giovani lasciano la loro famiglia di origine per formarne una nuova, si forma più tardi rispetto alla media italiana, così come scopriamo anche che il tasso più alto di separazione e di divorzi è proprio presente in Valle d'Aosta. Capisco che questi numeri asciutti possano annoiare, però non possiamo non lasciarci interrogare dal fatto che quasi la metà dei matrimoni in Valle d'Aosta termina con una separazione, il 75 percento dei quali coinvolgono dei figli minorenni.
Apro una parentesi: la metà dei matrimoni finiscono e non possiamo sapere quante convivenze finiscono, perché sulle convivenze non credo vi siano dati; quindi verosimilmente abbiamo più della metà delle unioni che si interrompono ad un certo punto della vita. In Valle d'Aosta c'è la più alta presenza di coppie di fatto e questo lo sappiamo. Fecondità: la Valle d'Aosta - lo ha detto l'Assessore - è una delle regioni che sta invecchiando di più forse al mondo, anche perché il tasso di fecondità è uno dei più bassi al mondo, perché 1,2 figli per donna se non è il più basso tasso di fecondità al mondo, poco ci manca! Capiamo tutti, in questo Consiglio, a cui sta molto a cuore la specificità della nostra regione, che con un tasso di fecondità di 1,2 figli a donna - e credo sia più o meno intorno a questa cifra da più di un decennio - la specificità della Valle d'Aosta e quindi della famiglia valdostana è destinata a cambiare, ma a cambiare profondamente con usi, culture, tradizioni esattamente opposte o certamente diverse da quella famiglia valdostana a cui spesso ci si riferisce!
In Valle d'Aosta c'è un tasso di abortività superiore sia a quello registrato in Italia settentrionale, sia a quello medio nazionale, e la percentuale più bassa di certificazione IVG - interruzione volontaria della gravidanza - rilasciata dai consultori. Anche questo è un dato significativo, perché in questo senso la Valle d'Aosta, per quanto riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza, deve soggiacere ad una legge nazionale, la famosa legge n. 194, sulla quale fu fatto un referendum. Quella legge è molto precisa e affida ai consultori familiari la più grande opera di prevenzione in fatto di abortività. Ci chiediamo: i consultori in Valle d'Aosta cosa fanno in questa direzione? Fanno tante cose, ma probabilmente non assolvono a questo compito che riterrei molto importante!
Abbiamo elencato tutta una serie di dati negativi, so già che se fosse qui presente il Vescovo non sarebbe d'accordo sulle cose che sto dicendo, perché lui insiste moltissimo sulla necessità di non sottolineare gli aspetti negativi che caratterizzano le famiglie in generale, ma piuttosto di insistere sulla positività di quelle famiglie che tutte queste situazioni - che ho appena descritto - non vivono. Sono d'accordo con il Vescovo quando afferma queste cose, nella misura in cui a questa linea di pensiero segue una politica parallela e conseguente a questa visione della famiglia. È per questo che ho voluto dare un'impostazione diametralmente opposta, perché anche qui, partendo da questa lettura che ho preso dal rapporto, c'è una politica familiare conseguente.
Vorrei affrontare insieme a voi, facendo alcune riflessioni, il capitolo che ritengo decisivo: le politiche familiari in Valle d'Aosta. Dico solo una cosa, alla quale tengo, perché non ho mezzi né competenze per confutare nulla di dati o di elementi che sono presentati in questo rapporto; uno sì, però, Assessore, perché in una cosa c'è una falsità in questo rapporto, ed è a pagina 124, là dove, facendo riferimento alla I Conferenza regionale sulla famiglia che, prevista dalla legge, si è tenuta nel novembre 2001, il rapporto dice che "la Conferenza è stata anche il momento in cui si sono potute avanzare proposte sulle politiche regionali familiari ed i conseguenti eventuali adeguamenti sui servizi, concordando sul fatto che la famiglia comunque formata è la prima comunità di base": questo no, Assessore, "concordando" proprio no! Ero presente in seno a quella Conferenza e una voce certo minoritaria, ma autorevole, ha detto che su questo non concordava proprio, che la famiglia comunque formata fosse la comunità a cui guardare. La pregherei quindi di correggere il tiro su quella che è stata la conclusione della I Conferenza regionale sulla famiglia.
Il capitolo delle politiche familiari ha un capoverso molto importante: il sostegno alle coppie in difficoltà. Leggo le prime parole di questo capoverso: "il servizio di consulenza legale". "Questo servizio, offerto nell'ambito dei consultori familiari, è risultato - Assessore consiglierei anche qui di correggere, mi auguro che sia un dato errato, ma temo che non lo sia - rispondente all'obiettivo… di sostenere le famiglie"! Assessore, noi li aiutiamo a separarsi per sostenere la famiglia! Diciamo quindi che facciamo una politica per sostenere la difficoltà dell'uomo e della donna, ma non per sostenere la famiglia!
Sempre in fatto di servizi, "Il Pangolo", un consultorio per adolescenti. Questo servizio nel quale opera personale qualificato che ascolta e si prende carico dei problemi che vengono manifestati dagli adolescenti, vuole essere, fra l'altro, una concreta risposta nell'ambito della prevenzione e dell'obiettivo di diminuire il tasso di abortività fra le giovani. Nobilissimo obiettivo: ridurre il tasso di abortività fra le giovani. Posso porre una domanda, Assessore? Sarebbe interessante sapere in che modo! Provo a fare una scommessa, essendo abbastanza certo di vincerla, parlando di contraccezione, e qui cadiamo in un'altra riflessione importante. Prevenire l'abortività significa esclusivamente parlare di contraccezione? So di scioccare qualcuno, ma sono convinto di ciò che dico: il problema è che se ci si ferma lì, l'aborto diventa la soluzione ad una contraccezione sbagliata. Se il messaggio è: "usate i contraccettivi così non abortirete", la volta che il contraccettivo non funziona, si abortisce! Credo che il lavoro educativo nei confronti dei giovani e degli adolescenti dovrebbe avere uno sguardo più ampio e, magari, proporre loro un senso della vita, che l'aborto non è come andare dal callista, ma è un dramma che coinvolge una vita umana.
Mi fermo qui: però, in conclusione, voglio fare alcune riflessioni. Al di là dei dati numerici, sa cosa mi ha sconvolto di più di questo rapporto? A me ha colpito molto una frase che ritengo indicativa perché spiega, più di ogni altra, il tipo di politica familiare che si è finora fatto in Valle d'Aosta. Questa frase è talmente significativa, che è ripresa pressoché tale e quale due volte nel rapporto, una è a pagina 123: "I continui mutamenti che avvengono nei modi di formazione e di organizzazione della famiglia non consentono più di pensare ad essa in modo tradizionale, con una rigida divisione dei ruoli fra i sessi ed una solidarietà estesa e prolungata fra le generazioni che consentiva una minore necessità di intervento da parte degli enti pubblici" e, se andiamo a pagina 127: "Tuttavia i mutamenti che stanno avvenendo nei modi di formazione e di organizzazione della famiglia non consentono più di pensare ad una famiglia di tipo tradizionale". Sarà un caso, ma questa "repetita" che io credo "non iuvant" sia molto significativa!
Questa è la filosofia che finora ha guidato le scelte di politica familiare; non un indirizzo da parte di una legislazione regionale, atta a premiare le famiglie, incentivare quelle situazioni di famiglie "normali", ma, al contrario, è il prendere atto di una situazione, il dichiararsi impotenti di fronte a questo e mettere tutti sulla stessa barca: omosessuali, conviventi, matrimonio civile, matrimonio religioso, madre con il figlio, papà con cugino… così non si scontenta nessuno… soprattutto pensando al consenso elettorale.
Voglio fare un'altra considerazione rispetto a ciò che ha detto la collega Squarzino, perché anche su questo dobbiamo avere il coraggio di interrogarci. Abbiamo, da una parte, tutta una serie di dati ISTAT, che ci dicono che siamo il Paese di Bengodi: uno dei tenori di vita più alti in Italia, Aosta classificata fra le prime dieci città, reddito notevole, agevolazioni grazie all'autonomia… se noi leggiamo i dati ISTAT riguardanti il modo in cui si vive in Valle d'Aosta, vi sarebbe il 90 percento del resto d'Italia che, alla luce di questi dati, vorrebbe stare qui, perché qui si sta meglio. Allora questi dati, collega Squarzino, non contraddicono questi altri che abbiamo letto? Cioè, è veramente pensabile che tutte le difficoltà che ha la famiglia valdostana siano dovute a problemi economici o sociali? Sono due dati contraddittori, perché se qui si sta meglio che in altre realtà, la famiglia dovrebbe essere più stabile, più tranquilla, con meno problemi…
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
… ci arrivo, ecco sono d'accordo con lei, bisogna cercare le motivazioni. Siamo sempre nell'ordine delle statistiche, quindi è chiaro che ci saranno anche dei casi, anche numerosi, quali quelli che lei descriveva, ma nel pensiero più allargato non possiamo fare questa equazione, cioè se in Valle d'Aosta si sta bene, anche le famiglie dovrebbero stare bene; invece in Valle d'Aosta si sta meglio che nelle altre regioni e le famiglie stanno peggio! Allora qualcosa non va!
Le motivazioni: personalmente ho avuto un'altra suggestione che non ho la pretesa che sia la risposta, ma un tentativo di chiave di lettura della questione potrebbe essere anche questa. Non so se avete avuto modo di leggere ciò che rispondono i giovani valdostani che stentano a formare una nuova famiglia. La grande maggioranza di questi continua la convivenza con i genitori, perché "si trova bene" e questo è un dato positivo ed è un modo per "mantenere la propria libertà". Vorrei offrire alla riflessione del Consiglio questa suggestione, che certo non è elettoralistica: non è che la famiglia valdostana, un po' come tutti gli esseri umani al mondo, si stia sempre più deresponsabilizzando, scegliendo invece la strada dello "stare bene" e della propria "libertà"?
Siamo così certi che 20-30 anni fa le coppie andassero d'amore e d'accordo, si amassero alla follia tutta la vita? No! I problemi vi saranno stati come vi sono oggi! Cosa faceva sì che si andasse oltre questo problema? Un'assunzione di responsabilità di fronte a delle scelte di vita, che non sono solo rose e fiori, ma che, come ogni responsabilità, comportano sacrificio, fatica, volontà di superare le difficoltà. Assessore, con la nostra legge favoriamo questo? Chiediamoci se favoriamo un'assunzione di responsabilità, non tanto di fronte alla famiglia ma, in senso lato, di fronte alla vita!
Termino proprio con questa domanda, alla quale necessariamente devo collegarne un'altra. Mi risulta che le riflessioni che sto facendo siano oggetto di approfondimento da parte non so se della "Union Valdôtaine" intera, ma da parte di alcuni suoi eminenti esponenti. Allora vorrei fare una riflessione che vada in questa direzione, dicendo: forse questa legge sulla famiglia, che considera la famiglia comunque formata, va ripensata e forse è il caso di pensare ad una legge che guardi alle famiglie fondate sul matrimonio. Volevo chiedere all'Assessore e al Presidente della Regione se condividono quest'osservazione, nel qual caso, sarò ben lieto di farvi avere - visto che l'ho conservata - la proposta di legge che ho presentato nel marzo 1988, la quale prevedeva questa diversa impostazione.
Président Il n'y a plus de Conseillers inscrits à parler. Je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Ringrazio i colleghi Squarzino, Piccolo, Charles e Marguerettaz, che sono intervenuti e che hanno dimostrato di aver analizzato in gran parte la relazione. Confesso che non è semplice entrare nel merito di un rapporto così complesso, che deve servirci solo come base di riflessione; non dobbiamo essere così presuntuosi di dare oggi delle risposte esaustive, perché, per la prima volta in modo un po' completo, abbiamo la possibilità di confrontarci, non solo sulle politiche sociali valdostane, ma sulle politiche di sviluppo nella loro interezza di questo "Pays d'Aoste", come lo chiamiamo, per cui non posso che condividere quanti hanno affermato che questo documento ci permette di riflettere.
Auspico che quest'aula dalla fase di riflessione - anche molto approfondita, sotto certi aspetti, che è stata fatta oggi ma, da un altro aspetto, superficiale - passi a dati concreti, ed è qui che sta il ruolo centrale del Consiglio regionale. Non lo dico provocatoriamente, lo dico perché vi credo, perché credo nel ruolo del Consigliere regionale che deve fare da pungolo propositivo nei confronti del Governo regionale. Se fossi seduto da quella parte, cosa che non escludo di fare e auspico, vi assicuro che avrei molti spunti! Gli spunti però vanno tradotti poi in atti amministrativi e legislativi e, sotto questo punto di vista, devo confessare che dal "forum" sulle famiglie mi aspettavo atti propositivi, che purtroppo non ho visto, come non ho visto un emendamento al disegno di legge, non ho visto proposte di atti amministrativi concreti. Ho invece assistito all'enunciazione di molti buoni principi, che tali sono rimasti!
Sotto l'aspetto dell'impostazione generale, condivido l'affermazione di chi dice che non è vero che qui si fa tutto, non è questo il taglio che si è voluto dare; anzi, qui si fa una fotografia dell'esistente con delle affermazioni che possono essere contestabili e contestate, questo non vi è ombra di dubbio, sono affermazioni che derivano da un lavoro di équipe che è stato assemblato, lavoro che viene espresso dai singoli professionisti. I professionisti del "Pangolo", dal loro punto di vista, ritengono di fare quelle affermazioni per confutarle pretendendo che chi le confuta abbia elementi ulteriori e almeno equivalenti per dire il contrario!
Io so, perché ho partecipato con loro in un interessantissimo incontro nelle scuole medie gestito dai professionisti del "Pangolo", vi assicuro che le domande dei ragazzini delle medie non sono per niente banali, c'è anche chi chiede se è vero che masturbarsi fa diventare ciechi; abbiamo interpretato questa domanda come una domanda provocatoria del ragazzino rispetto alla psicologa che gli stava di fronte. Vi assicuro che i ragazzini sono tutt'altro che innocenti! È altrettanto vero che i ragazzini hanno un'assoluta presunzione di conoscenza della sessualità, perché di sessualità principalmente si parla, che viene regolarmente smentita dai fatti perché le ragazzine minorenni incinte sono ancora troppe rispetto al livello di informazione che viene dato loro.
Questa relazione dice che rimane ancora molto da fare, Consigliera Squarzino, e rimane da fare probabilmente facendo un cambio di rotta rispetto ad alcune impostazioni che abbiamo dato finora, viaggiando un po' a vista, perché si tratta di questo: finora abbiamo navigato a vista, oggi abbiamo una rotta da seguire o più rotte da seguire, quale rotta seguire dipende dalla politica in senso alto, dalle scelte politiche che facciamo in questo contesto. La prossima campagna elettorale dovrebbe servire a parlare di questi temi seriamente, perché su questi temi si gioca il futuro della Valle d'Aosta.
Rispetto ad alcune domande tecniche che sono state poste, mi preme far presente che le consulenze esterne rispetto all'Osservatorio epidemiologico ci saranno sempre, Consigliera Squarzino; noi stiamo cercando di costruire in Valle d'Aosta un medico specializzato in epidemiologia che è una rarità; mi confermava il prof. Costa che non se ne trovano facilmente e quelli specializzati scelgono ambiti più remunerati, come il privato, ma le consulenze esterne dovranno continuare ad esserci, altrimenti qui si rimane tagliati fuori. Gli Osservatori epidemiologici delle altre regioni, che sono molto più complessi e con molte risorse umane, hanno tutti convenzioni con le università italiane perché bisogna fare non solo valutazioni tecniche, statistiche, ma bisogna fare dell'epidemiologia sul campo, bisogna fare della ricerca, e la ricerca deve essere fatta con pluriprofessionalità ed équipes che sono assolutamente formate sotto questo punto di vista. Ciò non toglie che la nostra struttura deve essere potenziata e deve essere utilizzata da tutta la struttura regionale e dalle istituzioni pubbliche e private della Valle d'Aosta.
Prendo atto e ringrazio tutti coloro che hanno affermato che la Relazione è molto interessante; preciso che, rispetto al sociale, è stato emanato da pochissimo un embrione di osservatorio per le politiche sociali: i frutti li vedremo fra qualche anno, perché dovrà interagire con la componente epidemiologica dell'Osservatorio per farne un tutto integrato e funzionante. Molto c'è da fare, molti aspetti sono da sviluppare; il Consigliere Piccolo ha fatto un elenco di tutta una serie di deficienze in senso tecnico del sistema; io sono dell'idea che il piano sociosanitario, che ha una valenza per gli anni 2002-2004, ha tanti e tali obiettivi da raggiungere e tanti e tali finanziamenti, risorse finanziarie e umane da mettere in campo, che i suoi effetti li vedremo non prima di cinque o dieci anni, perché tutte le strutture che stiamo realizzando e le organizzazioni che stiamo mettendo a punto, avranno una ricaduta sul territorio nel medio e nel lungo periodo, e non nel breve, per tutta una serie di motivazioni.
Ringrazio la Consigliera Charles per le parole che ha usato, quando ha definito il rapporto un "rapporto onesto ed esaustivo che non crea dei tabù"; è vero, abbiamo voluto semplicemente fotografare la realtà, senza enfasi, senza nascondere le "pecche", ma mettendo in campo tutte le informazioni che potevano e possono essere spese. Mi soffermo sulla lunga e interessante analisi del Consigliere Marguerettaz rispetto alla famiglia vista sotto più aspetti. Devo innanzitutto dire che non avevamo e non abbiamo l'ambizione di presentare un'indagine sociologica sulla Valle d'Aosta, non lo è; la relazione sociosanitaria è semplicemente una relazione sociosanitaria, ma non è un'indagine sociologica, cosa che possiamo fare e, se non fossimo a fine legislatura, potremmo pensarci, ma rinviamo l'argomento alla prossima legislatura. È un argomento interessantissimo, però se facciamo un'indagine sociologica concentrando l'attenzione sull'aspetto della famiglia o su altri temi, dobbiamo fare attenzione di far calare gli studiosi e i ricercatori sulla realtà della Valle, che è molto differenziata rispetto a realtà anche vicine. Si avvicina, sotto certi punti di vista, a realtà di montagna, abbiamo visto il raffronto con la Regione Trentino Alto Adige, che ha molte similitudini, ma che non può essere sovrapposta tale e quale, per cui sì, ma ponendo dei paletti ben precisi.
Sulla famiglia in generale devo dire che non concordo sul taglio che ha dato il Consigliere Marguerettaz, perché ironizzare su due righe contenute alle pagine 123 e 127 della Relazione mi pare un po' banale, perché lì si dice che "i mutamenti che stanno avvenendo nei modi di formazione e di organizzazione della famiglia non consentono più di pensare ad una famiglia di tipo tradizionale" ma, continua "con una rigida divisione dei ruoli fra sessi e una solidarietà estesa e prolungata fra le generazioni, che consentivano una minore necessità di intervento da parte degli enti pubblici", e così riprende la pagina 127. Non si vuole, qui, puntare l'attenzione sulla famiglia tradizionale "uguale" famiglia fondata sul matrimonio, o famiglia non tradizionale "uguale" famiglia di fatto; non è questo il ragionamento che viene fatto qui!
Il ragionamento che viene fatto è quello che sottintende tutta la Relazione sanitaria e che ho cercato di citare nelle premesse, e cioè che non esiste più quella solidarietà fra vicini di casa o fra villaggi che consente di aiutare un diversamente abile, e penso a mio zio che ha ottant'anni e che ha vissuto sempre nel villaggio di nascita, senza mai essere stato affidato ai servizi sociali. È un malato psichico grave ed è sempre stato gestito dal villaggio, amorevolmente dalla mamma, prima, e poi dalla zia, che si è sacrificata per assisterlo, ma poi dal villaggio… perché nel momento in cui questo mio zio si avvicinava ad un bar e tutti sapevano che, essendo un malato psichico, se gli avessero offerto un bicchiere di vino avrebbe dato in escandescenze, vi assicuro che tutto il villaggio lo accompagnava al bar, gli offriva il bicchiere di latte o l'aranciata, ma gli negava il bicchiere di vino! Questa è la Valle d'Aosta, a questo vorrei che si tornasse!
Il resto è fumo, il resto è filosofia, il resto è strumentalizzazione perché non possiamo dimenticare che se parliamo di politiche sociali, Consigliere Marguerettaz, c'è la costituzione a monte, c'è la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ci sono fior di documenti che vanno al di là del ragionamento della famiglia fondata sul matrimonio o della famiglia di fatto, c'è un obbligo costituzionale di dare assistenza a tutti, agli apolidi, ai bissessuali, a tutti coloro che chiedono di rispondere ai loro bisogni e questo, chiunque sia l'Assessore ai servizi sociali in Valle d'Aosta, non potrebbe non farlo!
La nostra legge regionale, che non è stata ancora emendata e che è stata portata ad esempio in molte realtà italiane ed estere - me ne vanto di questo, perché viene portata ad esempio in consessi europei - dice, al comma 1 dell'articolo 1, che "la Regione riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con riferimento alla costituzione". All'articolo 2, dice che "la Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge,…" - che non è una legge che riguarda solo la famiglia sotto l'aspetto economico e assistenziale, ma è una legge che prende in considerazione tutte le politiche familiari - "… riconosce inoltre come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nella educazione dei minori".
Se tornassimo indietro rispetto a questo concetto, le assicuro, Consigliere Marguerettaz, che faremmo un passo indietro enorme, perché quando parliamo di famiglia basata sul mutuo aiuto, la consideriamo come formazione sociale primaria - che è altra cosa rispetto alla famiglia - anche la realtà, diffusissima e sempre più comune nelle nostre realtà, di due anziani che convivono per mutuo aiuto. Nessuno può permettersi di contestare questo e nessuno lo ha contestato, mi permetto di dissentire rispetto all'affermazione che lei ha fatto! Il "forum" della famiglia è stato molto costruttivo: c'è stato chi ha ribadito che famiglia è solo quella fondata sul matrimonio, ma il punto comune di riflessione, e che il Vescovo ha condiviso, è che famiglia è comunque là dove vi è un figlio. Questo è scritto, ma questo non è falso, come ha dichiarato lei; questo è agli atti del "forum" della famiglia…
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
… il punto di contatto fra mondo laico e mondo clericale è stato che famiglia è là dove vi è un figlio. Per cui non travisiamo i fatti sull'omosessualità, perché è stato escluso in quella sede - e lo ribadisco in questa sede - che il Governo regionale non riconosce la famiglia basata sull'omosessualità. Per cui non giochiamo su questi aspetti, perché tutte le politiche regionali, non solo le politiche sociali - ultimamente l'Assessore Vallet lo ha espresso molto bene - le politiche sulla famiglia - anche per il contributo che lei stesso ha fornito - favoriscono la famiglia basata sul matrimonio, non vi è ombra di dubbio! Sicuramente non rispondo, perché la domanda è provocatoria, cosa si promette o si discute in altri ruoli di tipo politico partitico, perché non è questa la sede per farlo! Noi manteniamo questa posizione, siamo disponibili a portare i correttivi che si rendano necessari per migliorare questa impostazione che è certa e che ci è stata riconosciuta da più parti.
Concludo dicendo che sono soddisfatto del dibattito che si è svolto, mi aspetto ulteriori osservazioni, pur nel momento contingente - siamo a fine legislatura -, ma vi invito a proporre, perché ogni pagina di questo documento è una pagina che può essere letta sotto più aspetti, dall'interruzione volontaria di gravidanza, al tasso di fecondità, a tanti altri argomenti che sono stati toccati e che sono il vero dramma della società valdostana.
È vero, il tasso di fecondità è di 1,2, ma non vorrei essere presuntuoso nel dire che dal 1997 al 1998 c'è stato un aumento di circa 200 nascite in Valle; non è merito della legge sulla famiglia perché direi una falsità, però eravamo scesi a 900 nati all'anno e ora siamo risaliti a 1.100. Di questi, andrebbe approfondito, molti sono di famiglie immigrate, che hanno più di 4-5 figli, ed è pur vero che la società valdostana - ma direi la società italiana - con questo tasso di fecondità è destinata a sparire nell'arco di trent'anni. Fra trent'anni esisterà, spero, la comunità europea che sarà una comunità multietnica e, da questo punto di vista, certe barriere ideologiche devono essere sconfitte.
Noi dobbiamo prendere atto che stiamo andando verso una comunità multietnica e dobbiamo anche conformare le nostre politiche di integrazione sociale. Ripeto, questo è un aspetto su cui la Valle d'Aosta non ha mai lesinato, perché di tutto si può dire contro la Valle d'Aosta, ma che non abbia mai tentato di fare discriminazione e che non abbia mai discriminato nessuno, questo è un dato di fatto incontrovertibile!
Président Je soumets au vote l'objet n° 37:
Conseillers présents: 27
Votants: 19
Pour: 19
Abstentions: 8 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.