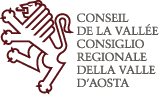Oggetto del Consiglio n. 2305 del 28 luglio 2016 - Resoconto
OGGETTO N. 2305/XIV - Discussione generale sul disegno di legge: "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
Rosset (Presidente) - Proseguiamo con il punto 14.04 all'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il consigliere Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz (PD-SIN.VDA) - Intervengo in qualità di relatore di questo disegno di legge.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la Regione dispone di potestà legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale e di potestà legislativa concorrente in materia di istruzione materna, elementare e media. Gli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto dettano, inoltre, specifiche disposizioni in materia di particolarismo linguistico.
Fra le principali specificità della scuola valdostana, si ricorda inoltre che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, il personale dirigente e docente delle scuole della Valle d'Aosta appartiene ai ruoli regionali e le spese del relativo trattamento economico sono a carico del bilancio della Regione, mentre lo stato giuridico e il trattamento economico sono gli stessi del corrispondente personale appartenente ai ruoli statali.
La competenza in materia di determinazione degli organici è in capo alla Regione, alla quale spetta, in base alla loro consistenza e alla disponibilità di posti vacanti, decidere l'entità delle assunzioni in ruolo. Con la legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), sono state definite le modalità per dare concreta attuazione all'articolo 40 dello Statuto speciale, relativamente alle materie da insegnare in lingua francese e agli adattamenti dei programmi di insegnamento nazionali, oggi "Indicazioni nazionali del curricolo", alle necessità locali.
Il legislatore statale, con legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ha introdotto una riforma di ampio respiro dell'ordinamento scolastico, soprattutto sotto il profilo organizzativo e gestionale. Le sopra richiamate specificità regionali hanno costituito il presupposto per la sottoscrizione, il 25 luglio 2015, ad Aosta, di un apposito protocollo d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, ai fini del recepimento, da parte della Regione, dei principi contenuti nella legge 107/2015 e nei successivi decreti attuativi oggetto di delega legislativa. Al suddetto protocollo d'intesa è seguito il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), nel quale, in considerazione della peculiarità dell'ordinamento scolastico regionale e degli adattamenti alle necessità locali, si è stabilito innanzitutto che la Regione individui, con propria legge, le modalità e i tempi di applicazione dei principi della legge 107, prevedendo, inoltre: l'applicazione da parte della Regione delle disposizioni della legge 107/2015 riguardante lo stato giuridico ed economico del personale dirigente, docente ed educativo, compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali; il mantenimento e la valorizzazione da parte della Regione, nell'ambito del proprio sistema di istruzione, delle specificità e dell'unicità del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia, in quanto funzionale alla precoce alfabetizzazione bi-plurilingue dei bambini; in considerazione del sistema bi-plurilingue della Regione, lo svolgimento nelle istituzioni scolastiche regionali, in aggiunta alle prove Invalsi di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, di una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese e l'introduzione, a partire dalla scuola primaria, dell'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche; il completamento, infine, dell'iter di approvazione di nuovi adattamenti dei programmi di insegnamento nazionali (Indicazioni nazionali del curricolo) entro l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017.
La Giunta regionale, con deliberazione del 29 gennaio 2016, n. 93, ha approvato le linee di indirizzo per l'armonizzazione con l'ordinamento scolastico regionale dei principi contenuti nella legge 107/2015, precisando che le misure di attuazione della medesima si applicheranno integralmente in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 2017/2018. Ciò non ha impedito di attuare alcune misure previste dalla stessa legge 107/2015 già dal corrente anno scolastico, ovvero l'erogazione dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, l'attuazione del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), l'avvio delle attività di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, la previsione di un piano di formazione generalizzato destinato al personale docente di tutti i gradi di scuola e funzionale, tra l'altro, al potenziamento delle competenze linguistiche in inglese, nonché la valorizzazione del merito del personale docente.
Il disegno di legge detta disposizioni finalizzate al completamento del processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, come previsto dalla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche) e, come meglio evidenziato in premessa, intende recepire e adattare i principi della legge 107/2015 al particolare ordinamento scolastico regionale.
Il disegno di legge si compone di 27 articoli. Mi soffermerò di seguito su alcuni punti che, in qualità di relatore, ritengo qualificanti e utili a chiarire l'impianto normativo nel suo complesso. Il disegno di legge recepisce parte delle proposte elaborate dal gruppo tecnico di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta regionale 93/2016. Gli scostamenti dalle suddette proposte sono intervenuti a seguito di attente valutazioni di carattere politico e di un ampio confronto con le rappresentanze sociali.
Il delicato lavoro di armonizzazione della legge statale 107/2015 con l'ordinamento scolastico regionale ha tenuto in conto, salvaguardandole in parte, le peculiarità del nostro sistema scolastico regionale, ritenute funzionali allo specifico modello di scuola valdostano, integrate con indubitabili migliorie introdotte dalla normativa statale, quali, ad esempio, il bonus di 500 euro per l'autoformazione. Si è, infatti, ritenuto di mantenere il meccanismo di reclutamento degli insegnanti su base annuale, assicurando la conservazione della titolarità del posto presso un'istituzione scolastica da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Il disegno di legge pone poi particolare attenzione alla comunità educante complessivamente intesa, valorizzando il ruolo degli organi collegiali scolastici e delle rappresentanze degli studenti e delle famiglie nella definizione dell'azione educativa, il tutto nella cornice degli indirizzi fissati dal dirigente scolastico, il quale resta garante del buon funzionamento dell'istituzione scolastica. A seguito di un serrato dibattito con gli attori del mondo della scuola, si è ritenuto di non irrigidire l'articolazione delle lezioni su cinque giorni, in difformità alle previsioni inizialmente introdotte con la citata deliberazione della Giunta regionale 93/2016 e nell'articolato, anche nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni e delle esigenze dei diversi territori. Ugualmente, si è valutata la necessità, nella scuola media, di mantenere i dodici posti aggiuntivi e i relativi finanziamenti, assegnati per l'integrazione degli alunni stranieri e per il potenziamento dell'offerta formativa. Tutto ciò, sicuramente a beneficio dell'intera classe e non solo degli studenti stranieri.
È da rilevare che il sistema delle sostituzioni del personale assente, contrariamente a quanto previsto dalla legge statale, rimane quello vigente. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di sostituire - e questa è una novità - il personale assente, fin dal primo giorno, se lo stesso è impegnato in attività di formazione e aggiornamento a carattere bi-plurilingue. È stata recepita - credo di poterlo dire senza tema di smentita - col favore di tutti i soggetti auditi, l'obbligatorietà introdotta con la legge nazionale, della formazione continua, a garanzia della qualità dell'offerta formativa erogata. A tale proposito, nell'ambito dei piani di formazione, troverà spazio il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, essendo tali competenze funzionali e trasversali a tutte le discipline. Gli insegnanti, inoltre, potranno utilizzare il bonus annuale di 500 euro, previsto per l'autoformazione, anche per il rafforzamento delle proprie competenze informatiche.
Nella piena consapevolezza che nessuno debba rimanere indietro o sia privato delle più ampie opportunità formative, il Legislatore pone, tra le finalità del disegno di legge, che proprio in quanto finalità informano l'articolato, particolare attenzione agli studenti con fragilità di apprendimento. A tale proposito, accogliendo gli opportuni suggerimenti delle organizzazioni sindacali e di altri soggetti auditi, con il coinvolgimento dell'Università della Valle d'Aosta, saranno attivati tirocini formativi, cosiddetti attivi (TFA), dedicati specificamente al sostegno degli studenti disabili, in modo da coprire il fabbisogno di personale specializzato in questo settore. Ciò verrà formalizzato - lo anticipo - con un ordine del giorno che presenteremo come maggioranza e che, oltre ad impegnare la Giunta e l'Assessore all'istruzione a valutare con le organizzazioni sindacali scolastiche la definizione di un futuro piano di assunzione nella scuola, nei limiti del fabbisogno di personale docente, impegna gli stessi a concordare, entro la fine dell'anno, con l'Università della Valle d'Aosta, l'attivazione di un tirocinio formativo attivo sul sostegno, a condizioni economiche favorevoli per gli interessati, per dare risposte e alternative sul piano occupazionale al personale docente.
Dal punto di vista del potenziamento dell'offerta formativa, saranno attribuiti complessivamente 36 posti aggiuntivi alle istituzioni scolastiche di secondo grado, completando il processo di potenziamento delle risorse umane a disposizione, già intrapreso in passato per gli altri gradi di scuola. Si è fortemente voluto il potenziamento delle discipline scientifiche prevedendo, nella scuola media, un modulo aggiuntivo di matematica.
Per quanto riguarda, invece, il potenziamento delle competenze linguistiche, gli adattamenti delle indicazioni nazionali alla realtà locale - più volte richiamati nell'articolato - hanno ricevuto, venerdì scorso, il parere favorevole della commissione mista Regione-MIUR e vedranno completato il loro iter di approvazione entro il mese di agosto prossimo venturo, così come previsto dall'articolo 6 della norma di attuazione approvata da questo Consiglio nell'autunno scorso. È importante, pertanto, che anche la legge in esame concluda il suo iter quest'oggi in Aula, al fine di dispiegare i suoi effetti in parallelo con gli adattamenti dei programmi. Crediamo che il Legislatore regionale abbia posto concretamente le basi per l'apertura del proprio sistema educativo bilingue al plurilinguismo, con particolare attenzione all'apprendimento della lingua inglese, strumento fondamentale per i nostri giovani, per renderli competitivi nel mondo del lavoro. Si tratta ovviamente di un processo graduale che investirà progressivamente tutti i livelli scolastici, con l'ambizione di giungere, tra qualche anno, a un ordinamento scolastico realmente trilingue.
Per raggiungere gli obiettivi formativi individuati come prioritari dall'articolo 3 del disegno di legge, anche al fine di motivare e di dare il giusto riconoscimento ai docenti che dispongono di competenze ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle normalmente richieste per l'esercizio della funzione docente, il disegno di legge prevede che possano essere utilizzati, nell'ambito degli istituti comprensivi, in attività di insegnamento di potenziamento, insegnanti appartenenti a gradi diversi di istruzione, nell'ottica di fornire ai nostri ragazzi ulteriori chance formative.
Nell'intento di configurare la scuola come un vero centro di aggregazione, anche al di fuori dell'orario scolastico, il disegno di legge prevede, per la prima volta espressamente, che nei periodi di sospensione dell'attività didattica i locali degli istituti scolastici possano essere utilizzati per attività ricreative, culturali, artistiche e sportive, d'intesa anche con gli enti locali, come peraltro già avviene abbastanza frequentemente. Un più razionale utilizzo delle strutture scolastiche anche nel periodo estivo consente di realizzare delle economie di scala per la collettività e di offrire ai nostri giovani opportunità di socializzazione, senz'altro utili ai fini della costruzione della loro personalità, del loro sviluppo psicofisico, adempiendo al bisogno di custodia e attenzione auspicato dalle famiglie dei nostri ragazzi, ponendoli così al riparo da possibili episodi di devianza giovanile. Per quanto riguarda la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, al fine di alleggerire il monte ore di alternanza stabilito dalla legge nazionale 107/2015, che lo prevede per il solo triennio superiore, abbiamo previsto che le ore di alternanza possano essere svolte già dal biennio della scuola secondaria di secondo grado e per tutto lo sviluppo del quinquennio.
Per rendere praticabile quanto contenuto nel disegno di legge e a dimostrazione dell'attenzione riservata dal Legislatore regionale al settore scolastico, l'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge ammonta a più di 6,5 milioni di euro, senza contare gli ulteriori fondi che già vengono attribuiti dall'Amministrazione alle istituzioni scolastiche per la dotazione ordinaria, la dotazione perequativa e il fondo di istituto.
Ne approfitto, infine, per ringraziare tutti coloro che in queste settimane si sono spesi per scrivere, modificare, adattare, analizzare il testo che oggi vi presentiamo. Un particolare ringraziamento lo voglio fare al sovrintendente agli studi e ai dirigenti dell'Assessorato, che non hanno mai fatto mancare il loro puntuale supporto.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore Rini, ne ha facoltà.
Rini (UV) - Vorrei iniziare questo intervento in maniera forse inusuale, partendo da quella parte di discorso che di solito viene riservata alla fine, ma lo faccio in maniera convinta. Inizio dai ringraziamenti, allacciandomi a quanto ha molto bene espresso il collega Guichardaz, perché oggi siamo qua a presentarvi questo risultato, per noi importante, frutto di un percorso lungo, difficile e spesso in salita, ma che oggi ci consente di presentarvi un testo di legge importante e che va a incidere su uno dei settori capitali per la nostra regione. Quindi mi sento innanzitutto di ringraziare il relatore Jean-Pierre Guichardaz, non solo per la relazione puntuale, ma anche per il lavoro e il supporto che mi ha dato e che ci ha dato in questi mesi. Grazie al Presidente della V Commissione, Bertschy e a tutti i commissari: ci tengo a sottolineare tutti, componenti delle forze di maggioranza e di opposizione, per aver accettato di lavorare in maniera serrata nell'ultimo mese; io, di questo, ve ne sono particolarmente grata. Grazie alle forze di maggioranza per aver collaborato in maniera non passiva, ma particolarmente attiva, portando e apportando delle modifiche al testo iniziale, che si sono rivelate sostanziali e sicuramente migliorative dell'idea di partenza. Grazie al Presidente, al Governo regionale e grazie alle forze sindacali che rappresentano coloro che quotidianamente operano con impegno e serietà nel mondo della scuola. Grazie, perché con loro il confronto è sempre stato proficuo, talvolta acceso, ma sempre pacato e soprattutto produttivo. Anch'io ci tengo a ringraziare le strutture dell'assessorato, perché con tanta serietà e impegno, ormai da due anni, con me portano avanti questa sfida che oggi presentiamo alla comunità valdostana. Grazie al sovrintendente, il dottor Gentile; grazie a Clarissa Gregori e grazie a tutte le strutture dell'assessorato.
Non ritornerò sulla descrizione puntuale dell'articolato, sulle previsioni di questa norme, poiché credo che lo abbia fatto in maniera più che esaustiva e puntuale il collega Guichardaz. Mi concentrerò piuttosto su qualche considerazione di ordine generale e su qualche breve passaggio, per raccontare alle nostre concittadine e ai nostri concittadini il percorso che ci ha portato oggi qui alla presentazione di questo disegno di legge.
Oggi si conclude un percorso lungo, iniziato due anni fa, quando il Governo nazionale ha depositato la cosiddetta bozza di lavoro che già allora portava il nome "buona scuola". Quel documento è diventato itinerante sul territorio con una serie di incontri e anche nella nostra regione abbiamo accolto rappresentanti del Ministero statale, del MIUR, che hanno avuto l'occasione di confrontarsi direttamente con il mondo della scuola nel suo complesso. Da subito il mondo della scuola ha espresso delle perplessità sulle previsioni contenute in quella che allora era solo una bozza di ipotesi di lavoro futuro. Con attenzione abbiamo cercato di capire quali sarebbero state le ripercussioni di queste previsioni, che probabilmente in altre realtà possono anche essere applicate, applicabili e anche produttive. Da subito ci siamo preoccupati per l'impatto che certe previsioni avrebbero avuto su un territorio così piccolo, su una territorialità così particolare come quella della nostra regione.
Ci siamo attivati per riuscire ad arginare l'immediata applicabilità di questa norma, esercitando la nostra potestà normativa, il nostro buon esercizio dell'autonomia e, con un proficuo rapporto di collaborazione con il Ministero e con il Ministro Giannini in particolare, siamo riusciti ad arrivare alla firma di quel famoso protocollo d'intesa. Qualcuno inizialmente ha messo in discussione la validità giuridica e la consistenza degli effetti nel futuro di questo protocollo d'intesa. Invece dobbiamo riconoscere che il Governo centrale è stato di parola e al protocollo d'intesa ha fatto seguire una norma di attuazione approvata in tempi rapidissimi: solo due mesi. Quella norma di attuazione è stata capitale per noi, perché ci ha consentito la non applicazione diretta di quel testo di legge, che è sotto gli occhi di tutti cosa stia scatenando a livello nazionale, e ci ha consentito di crearci uno spazio di azione, un ambito di manovra e ci ha dato la possibilità di legiferare in maniera differente. Ecco quindi che abbiamo istituito un gruppo tecnico, che ringrazio, coordinato e presieduto dal sovrintendente agli studi, che ha cercato di elaborare e ci ha fornito una bozza di articolato, che poi la politica ha deciso in parte di accogliere e in parte di stravolgere.
Oggi arriviamo qua, in Aula, con questo disegno di legge che ha subito una forte modificazione rispetto al testo originario che ci è stato consegnato dal gruppo tecnico, questo grazie al lavoro delle forze politiche di maggioranza, ma grazie anche al lavoro della V Commissione. Io vorrei ricordare che in V Commissione sono state fatte diverse audizioni e abbiamo ascoltato coloro che operano nel mondo della scuola a diverso titolo e in diversa misura. Forse non sempre siamo bravi a trasmetterlo, ma credetemi quando dico che le loro preoccupazioni sono anche le nostre. Purtroppo, siamo ben consci che non sempre, soprattutto quando si decide di intraprendere la strada non facile delle riforme, in particolare in un settore come quello scolastico, pur mettendoci tutto l'impegno, non sempre si riesce ad accontentare tutti, non sempre riusciamo a risolvere caso per caso. Ma il nostro dovere è quello di porre al centro lo studente e una delle criticità del testo statale era di dimenticare, talvolta, che la prima ratio che deve fondare la base stessa di una riforma scolastica è proprio lo studente, i ragazzi e il loro futuro.
Con il disegno di legge che oggi vi presentiamo, è stata esercitata la potestà legislativa regionale in materia di istruzione. Mai come in questo periodo storico, che ormai dura da diversi anni, dove diventa più che mai fondamentale riaffermare questa potestà legislativa, diviene cruciale riuscire a portare avanti questo esercizio e farlo tanto più in un settore come quello scolastico. Esercitare la potestà legislativa regionale significa interpretare il ruolo di garante delle peculiarità di un sistema scolastico, ma vuole dire anche fare delle scelte a beneficio dell'intera comunità scolastica, tenendo conto delle sue esigenze e delle sue specificità.
Il collega Guichardaz ricordava un esempio piccolo, ma grande allo stesso tempo, dell'importanza di questo esercizio e della differenza con cui ci collochiamo in maniera diversa rispetto alla legge statale. Noi abbiamo voluto espressamente ricordare quel tassellino così importante dell'istruzione, che è la scuola dell'infanzia: il primo approccio che i nostri bambini hanno con il mondo della scuola. A livello statale è stato dimenticato questo tassello, che per noi è fondamentale e che negli anni, grazie a chi opera nel settore, è diventato un fiore all'occhiello, preso a esempio su tutto il territorio nazionale, proprio per il modello pedagogico delle nostre scuole dell'infanzia. Quindi in questo testo abbiamo voluto richiamare questa nostra specificità.
Il decisore politico, purtroppo, non è svincolato totalmente dai limiti di ordine giuridico nell'esercizio della sua potestà legislativa. Nel settore scolastico questi vincoli sono rappresentati dalle norme generali sull'istruzione, che sono di esclusiva competenza statale, e dalle norme sullo stato giuridico che sono, per i docenti regionali, gli stessi del corrispondente personale statale. Questo va ricordato, perché ci sono tanti suggerimenti che ci sono stati proposti, che avremmo voluto poter cogliere e inserire in questo testo di norma, ma purtroppo non lo possiamo fare, perché lo stato giuridico dell'insegnanti è materia di competenza esclusiva statale.
Qui apro e chiudo una parentesi, perché il discorso è lungo e sicuramente ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Spesso ci confrontiamo con realtà a noi simili per territorio, penso al Trentino Alto Adige, dove lo stato giuridico degli insegnanti è competenza regionale. In passato si è parlato di regionalizzazione e qualche mese fa abbiamo approvato in quest'Aula un testo che ci impegna a riaprire la riflessione su questo argomento. Nel caso di una regionalizzazione potremmo decidere e avremmo spazi di azione diversi. Pongo questo come elemento di riflessione ulteriore e credo sia giusto farlo oggi, perché purtroppo a tanti suggerimenti avremmo voluto dire di sì e avremmo voluto legiferare in maniera diversa, ma non lo abbiamo potuto fare.
Questo è un disegno di legge che ha un unico obiettivo: porre al centro del nostro operato il futuro dei nostri figli, di tutti gli studenti e i giovani valdostani. Dobbiamo cercare di rafforzare i tanti punti di eccellenza del sistema scolastico valdostano. Citavo prima l'esempio della scuola dell'infanzia, ma non solo. Le nostre scuole, le piccole scuole di montagna, ma anche i grandi poli scolastici del capoluogo, sono spesso esempio di eccellenza su tanti settori, però dobbiamo avere il coraggio di saper cogliere le nuove sfide. Io ho detto spesso che noi sogniamo di avere dei giovani che abbiano delle radici forti, ben radicate nel nostro territorio, nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, ma che abbiano anche dei rami forti, protesi verso l'esterno, verso tutte quelle opportunità che l'Europa e il mondo ci offre.
Bisogna avere il coraggio - non uso questa parola a caso - di continuare a sostenere e a investire in un sistema che ha dimostrato la sua validità. Mi riferisco alla scelta - che non vorrei passasse in secondo piano - di discostarci radicalmente e totalmente dal sistema nazionale che la riforma ha imposto. Mi riferisco al sistema di reclutamento degli insegnanti: abbiamo scelto politicamente la non applicazione dell'ambito, con la conseguente decadenza della chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Non lo abbiamo fatto per penalizzare qualcuno o per mancanza di fiducia nell'operato dei dirigenti scolastici, perché siamo pienamente consapevoli e consci della centralità del ruolo del dirigente scolastico e di quello che quotidianamente portano avanti: grazie alla loro capacità e alla loro professionalità riescono a rendere più o meno performante un polo scolastico rispetto a un altro. Lo abbiamo fatto per la ragione che ricordavo all'inizio: abbiamo cercato di capire quale sarebbe stato l'effetto e l'impatto che una previsione del genere avrebbe avuto su un territorio come il nostro, un territorio piccolo e di prossimità. Questo ha spaventato non solo il corpo docente, ma anche l'apparato politico, per cui abbiamo deciso di discostarci. Io vorrei sottolineare questo fatto, che è la scelta centrale del recepimento della riforma: lo abbiamo fatto discostandoci dal modello statale e non solo. La Provincia Autonoma di Trento viene da un dibattito molto acceso e aspro su questo argomento: loro hanno deciso, a differenza nostra, di applicare l'ambito. Sapete meglio di me qual è stato il risultato sul territorio, quale sia la preoccupazione del corpo docente rispetto a una previsione di questo tipo. Anche a livello statale vedremo quale sarà poi l'effettiva applicabilità, tenendo conto che proprio su questo tema c'è in itinere una proposta referendaria per abrogare questa previsione.
Bisogna avere il coraggio di portare avanti un sistema che ha funzionato, che è il nostro. Noi crediamo che, per il reclutamento degli insegnanti, il nostro sistema sia valido, anche se non neghiamo che, sulla carta, quella proposta nazionale poteva avere sicuramente dei valori aggiunti, perché la meritocrazia sicuramente è un aspetto positivo. D'altro canto, dobbiamo anche avere il coraggio di saper cogliere le nuove sfide. Non dobbiamo aver paura di guardare avanti e di apportare quei cambiamenti che possono migliorare un sistema, anche se il nostro è un sistema di eccellenza.
Prima sono state ricordate alcune delle sfide che abbiamo deciso di accettare per i nostri ragazzi: quella delle lingue. Ne abbiamo parlato tanto e vorrei spendere anch'io due parole sul percorso degli adattamenti, anche se non è oggetto stringente della discussione odierna, ma sicuramente si inserisce appieno in questo percorso. Tante altre sfide, come quella dell'informatica, sulla quale molto è stato detto. Sono scelte che potrebbero sembrare voler sminuire questo settore, invece noi crediamo che la digitalizzazione - più che l'informatica - debba diventare trasversale e coinvolgere tutti, tutte le materie, tutti i settori della scuola. Qualche anno fa andava di moda parlare di 2.0 e anche la scuola è entrata a pieno titolo in questa dimensione. Noi ci crediamo, lo vogliamo fare e abbiamo esplicitato questa volontà con la previsione di risorse concrete - perché poi le belle idee senza le risorse non vanno avanti - con dei mezzi economici a disposizione della formazione non solo linguistica, ma anche informatica, scientifica, matematica. Sono quei settori dove dobbiamo investire, non perché lo diciamo noi, non perché lo dice il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ma perché lo chiede il mondo del lavoro, lo chiede quel mondo con cui i nostri giovani dovranno confrontarsi.
Io credo che tanto sia stato detto proprio su queste scelte che abbiamo portato avanti. Due parole vorrei dedicarle anche a un altro settore che noi riteniamo importante. Ci è dispiaciuto quando, sicuramente per una carenza di informazione nostra, è potuto sembrare che ci fosse una mancanza di volontà di investimento nella scuola secondaria di primo grado, in quella fascia d'età in cui i nostri giovani sono più fragili, più delicati. Tanto è stato fatto, tanto si è investito in questa fascia scolastica e oggi credo che possiamo avere la forza, dati alla mano, di dire che lo si è fatto a ragion veduta e a buona ragione; continueremo a investirci.
L'innalzamento delle ore frontali deriva da una volontà di riporre equità tra i vari ordini di scuola. Equità tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, ridistribuendo le risorse e andando a rafforzare la scuola secondaria di secondo grado, senza penalizzare nessuno, con la volontà di continuare a credere e a investire. Siamo tornati indietro su alcune previsioni, proprio ascoltando il mondo scolastico. Per esempio, la questione dei cinque giorni, sulla quale diversi dirigenti scolastici e insegnanti ci hanno rappresentato come, in maniera particolare sulla parte della formazione liceale, diventava di difficile applicazione, seppure questa avesse come unica ratio la volontà di riuscire a organizzare meglio da una parte i servizi collaterali al mondo scolastico e dall'altra anche l'organizzazione familiare, perché nella riforma della scuola sono coinvolte anche le famiglie, che devono tornare a essere partecipi di questo percorso che dobbiamo fare insieme.
Parlavo della centralità degli studenti, ma anche il corpo docente è stato oggetto di particolare attenzione, già durante l'anno scolastico appena concluso. Non dimentichiamo che da un'idea rigida di partenza di aspettare, fermarci, guardare, analizzare e poi decidere cosa applicare e cosa no della legge 107 statale, abbiamo invece deciso di fare un'altra scelta e abbiamo percorso un'altra strada. Abbiamo spacchettato le previsioni, colto le parti migliori, quelle migliorative per il corpo docente stesso e le abbiamo rese immediatamente applicabili. Questo, non dimentichiamolo, ha una ripercussione anche economica: in un momento storico in cui conosciamo bene quale sia la situazione finanziaria, certamente non solo della Regione, ma una situazione generale di austerità, avere la forza e la volontà di compiere e portare avanti certe scelte, crediamo che abbia un certo tipo di significato, ovvero dimostrare che crediamo e che vogliamo investire in questo settore.
Abbiamo deciso l'immediata erogazione del bonus dei 500 euro per l'autoformazione. In questo disegno di legge si parla più volte di formazione e lo si fa perché noi crediamo profondamente in questo settore. Questo è un punto condiviso con tutti ed è un passaggio molto positivo. Chi opera nella scuola ha voglia di formarsi, a condizioni che devono essere giuste, eque, riconosciute, tutelate, valorizzate; ha voglia di formarsi, per porre le sue professionalità sempre accresciute, sempre migliori, sempre perfezionate, sempre al passo con i tempi. Abbiamo ragazzi che ormai viaggiano veloci, che ci superano - chi ha dei figli può testimoniarlo - quindi bisogna tenersi al passo, e i primi a chiederlo sono proprio i docenti. Con questo testo di legge abbiamo cercato di venire incontro a tale esigenza: da una parte formarsi e dall'altra valutarsi. Dobbiamo cercare di smetterla di vedere la valutazione con un'accezione negativa: la valutazione deve essere positiva, deve spingerci a fare meglio, a capire dove abbiamo sbagliato e dove possiamo fare di più. Questa è la ratio delle clausole valutative nelle norme. Con il collega Bertin, nella scorsa legislatura, avevamo portato avanti un percorso proprio sulle clausole valutative. Qui l'autovalutazione entra e diventa parte integrante del sistema scolastico: non si valutano più solo gli studenti, ma si valutano i docenti, si valutano i dirigenti scolastici, per crescere tutti insieme, per fare prendere il volo davvero a tutto il mondo scolastico nel suo complesso.
Il collega Guichardaz ha ricordato il contenuto di un ordine del giorno che presenteremo, con due punti che per noi sono fondamentali, il primo condiviso e concordato con le forze sindacali. Non abbiamo inserito nel testo di legge un piano di assunzioni straordinario e vi spiego perché non abbiamo voluto farlo. Parlare di qualcosa di straordinario vorrebbe dire che non abbiamo fatto qualcosa di ordinario. Nella Regione Valle d'Aosta si è proceduto con la puntuale assunzione annuale dei docenti per i posti vacanti. Questo ha creato una situazione completamente diversa rispetto a quella del corpo docente nazionale. Fortunatamente non abbiamo le criticità presenti sul resto del territorio nazionale. È vero, però, che esistono e permangono delle situazioni di precariato che noi vogliamo veramente cercare di prendere in carico e di risolvere negli anni. Con questo ordine del giorno ci prendiamo l'impegno puntuale di arrivare a un accordo con le forze sindacali entro la fine dell'autunno, in merito alla prospettiva nel campo delle assunzioni stesse. Questo è un punto fondamentale per noi ed è un modo di dare risposte concrete. Vogliamo assicurare al corpo docente che si continuerà sulla linea portata avanti negli ultimi decenni, quella delle puntuali assunzioni su cattedre libere. Ovviamente i piani straordinari, non avendo quelle cattedre libere, non potevamo proporli.
Nell'ordine del giorno abbiamo inserito e codificato un altro aspetto, perché preferiamo essere chiari in questo passaggio, visto che abbiamo la grande opportunità di mettere mano in questo settore e vogliamo farlo nella sua completezza. Siamo consapevoli che ci saranno, in seguito a certe decisioni, delle situazioni di criticità per degli insegnanti, per coloro che negli anni hanno speso tempo, soldi e impegno per formarsi in certe direzioni, ma che oggi, perché il mondo cambia e cambia anche il mondo scolastico, si trovano a dover fare dei percorsi diversi. Penso, per esempio, al caso dell'insegnamento della tecnologia. Così come non abbiamo mai voluto penalizzare nessuno, non abbiamo voluto sfavorire i dirigenti scolastici e tanto meno gli insegnanti di tecnologia. Siamo consci dell'importanza di quella, come di altre materie. Siamo altrettanto consci, però, che era importante livellare nuovamente quel sistema di monte ore scolastico presente sul territorio nazionale. I nostri ragazzi - sono di recente pubblicazione i dati delle prove Invalsi - soprattutto nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (questo deriva forzatamente da una formazione precedente a quell'anno di studio in sé) sono carenti nelle discipline scientifico-matematiche. Pertanto abbiamo cercato di fare un investimento, non solo per le prove Invalsi, ma per quella organicità di ragionamento con cui abbiamo portato avanti la riforma, con il recepimento del testo della legge 107 e gli adattamenti, cercando di far dialogare questi due settori. Abbiamo inserito l'insegnamento, tramite metodologia CLIL in lingua inglese, della materia scientifica. Quindi abbiamo cercato di recuperare quell'ora, implementando proprio l'insegnamento delle scienze, per dare concretezza, ancora una volta, a quel percorso che abbiamo scritto sulla carta, perché c'è bisogno di ore per portare avanti questo percorso.
Ci saranno degli insegnanti che forzatamente si troveranno nella situazione di essersi formati e, proprio per la riduzione di un modulo orario di questa disciplina, a dover fare delle scelte occupazionali diverse. Il Presidente della Regione ha richiesto all'Università della Valle d'Aosta l'attivazione immediata di un percorso di tirocinio formativo, a condizioni economiche agevolate - abbiamo ascoltato tutti la voce di chi ha investito e sappiamo anche quanto economicamente sia impattante la scelta di questo percorso formativo - istituendo immediatamente dei corsi di formazione in particolare modo sul sostegno, dove siamo carenti di posti. Nell'ultimo bando di concorso non avevamo abbastanza persone pronte a entrare in ruolo proprio sul sostegno: lì ci sarà una risposta occupazionale per coloro che dovranno fare delle scelte diverse.
Come si può evincere dalla disposizione finanziaria, il disegno di legge impegna una cifra di circa 6 milioni 700 mila euro nel triennio. In tempi di risorse sicuramente contratte, credo sia un segno tangibile dell'importanza che questa Assemblea riserva al mondo della scuola. La sfida che ci aspetta non è sicuramente facile, lo sappiamo bene. Ma crediamo davvero di non aver lesinato energie per giungere oggi a questo che vuole essere davvero un risultato condiviso. Noi pensiamo davvero - lo diciamo con umiltà - di aver percorso tale strada proprio in questa direzione.
Concludo con un'osservazione sul percorso degli adattamenti. La scorsa settimana una commissione mista, formata da rappresentanti del Ministero, ha votato e ha approvato il testo degli adattamenti. Ci hanno chiesto perché non abbiamo aspettato. Non lo abbiamo fatto per quei 2200 bambini che avrebbero perso, ancora una volta, l'opportunità di formarsi, di fare il loro percorso e di accrescere le loro capacità linguistiche in inglese. Sappiamo cosa chiede il mondo, lo sappiamo tutti e non possiamo nasconderci. Lo abbiamo fatto per loro, ma lo abbiamo fatto tutti insieme e soprattutto con tutti quei docenti che ci hanno dato il loro supporto in questo percorso, che ci hanno chiesto di andare avanti e che ci hanno detto di esserci con le loro capacità, con la professionalità e l'impegno che hanno messo in questi anni. Noi li dobbiamo ringraziare, perché sarà proprio grazie a questi docenti, formati e competenti, che dal mese di settembre potremo partire e dare l'opportunità a questi 2200 bambini di iniziare un nuovo percorso di formazione. Non sappiamo se sarà la possibilità della loro vita, ma sarà sicuramente una possibilità in più che daremo a questi ragazzi. Noi di questo siamo fieri e in questo percorso crediamo profondamente. Una Regione autonoma, che basa la sua autonomia sul bilinguismo in primis, sul rafforzamento della nostra lingua del cuore, il francese, ma anche il francoprovenzale, però che non si chiede in sé stessa, che sa guardare altrove, che non si nasconde e che coglie la sfida di insegnare e di dare tutte quelle capacità alla nostra scuola.
Noi abbiamo chiamato questo percorso la "nostra scuola", non la "buona scuola", perché noi crediamo che la nostra sia già una buona scuola, tant'è che questo recepimento di riforma tiene e conserva l'ossatura del nostro sistema, apportando solo quelle piccole modificazioni, quelle piccole migliorie che crediamo possano dare un nuovo sviluppo, un nuovo slancio alla nostra scuola valdostana.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Certan, ne ha facoltà.
Certan (ALPE) - Nous avons écouté très attentivement soit le rapporteur Guichardaz, soit l'assesseur Rini pour leurs présentations. Je crois que la tâche de légiférer d'une assemblée, telle que le Conseil régional, est toujours une grande responsabilité, dans tous les secteurs et dans toutes les lois, mais la responsabilité de légiférer en matière d'éducation et d'instruction est encore plus grande. Elle rentre directement dans la formation des nouvelles personnes, des nouveaux citoyens ; elle rentre directement dans le cœur de nos enfants, qui deviendront des hommes et des femmes.
Dans mon intervention, je partirai d'une constatation que le directeur didactique Jean Pezzoli - directeur de grand charme, enseignant, pédagogue et exquis connaisseur de l'école valdôtaine - faisait par rapport aux langues, mais qu'à mon avis nous pouvons bien adapter à tout l'apprentissage. Il écrivait : "Ce sont des problèmes - ceux de l'apprentissage des langues, mais je dirais de l'apprentissage en général - qui demandent des approfondissements poussés, l'apport de sciences différentes, de la psychologie à la linguistique, de l'anthropologie à la pédagogie, à la sociologie. Ce sont des problèmes qui réclament aussi des décisions appropriées". Vous avez raison, Madame l'assesseur : des décisions courageuses sur le plan politique, institutionnel et de l'organisation scolaire. Quand on parle d'école, on parle de la coparticipation de toute la société : je crois que nous sommes d'accord sur cela. Ce n'est pas qu'on fait des lois pour soi-même et quand on parle d'école on doit partir de la coparticipation de toute la société. Pour faire ça et pour ne pas rater, il faut prendre du temps. Quelquefois pour ne pas rater e pour ne pas perdre du temps, pour ne pas faire perdre du temps à nos élèves, il faut leur dédier du temps.
Nous savons que comme tous les autres gouvernements, même le Gouvernement Renzi a voulu sa propre réforme de l'école. Je ne reviens pas sur les ombres et les lumières des principes de cette réforme, dont nous avons déjà parlé maintes fois, car les principes inspirateurs de la "buona scuola" étaient partageables. Maintenant que la loi est faite, on se demande si on nous a donné des principes différents ou qu'est-ce qu'il est arrivé entre le choix des principes et la reforme après. Ce qui est clair est que la Vallée d'Aoste, malgré toutes ses spécificités, c'est retrouvée à avoir la nécessité de changer le rythme de sa marche. Nous soutenons le fait que l'école valdôtaine, bien avec ses excellences, ses atouts et ses bonnes pratiques, avait besoin de changer de vitesse ; cette idée nous la partageons avec vous. Pour trop de temps on a vécu sur la conviction selon laquelle l'école valdôtaine suffisait à soi-même et la responsabilité de cette conviction, qui a renfermé l'école valdôtaine en soi, n'est pas à remettre aux enseignants, car il y a des responsabilités qui vont au-delà des enseignants mêmes. Malgré la demande de formation forte et continuelle, pour beaucoup d'années - cela pour un choix politique - on a bien retenu que la formation n'était plus obligatoire, plus nécessaire et on a laissé tout au choix des enseignants, qui étaient ensevelis dans d'autres charges aussi, dans d'autres engagements aussi. Pour beaucoup d'années on a pensé qu'il était suffisant de se pencher sur l'enseignement facultatif du franco-provençal pour parler d'éducation linguistique bilingue et plurilingue. Aucun contrôle direct sur ce que les écoles faisaient et là la responsabilité n'est encore pas à remettre uniquement aux enseignants.
À cette absence s'est ajouté le mauvais choix de fermer et démanteler une structure telle celle de l'IRRSAE e de l'IRRE, l'un des meilleurs centres de recherche et de formation en pédagogie et didactique, reconnu au niveau européen, qui était pour l'école valdôtaine (mais pas seulement) un grand point de repère, telle de l'eau dans un désert, c'est-à-dire fondamentale. Je parcours un petit peu l'histoire, parce que souvent les reformes ne naissent pas du rien, elles ont des racines et il faut quand même les adapter au territoire. On a employé des grandes ressources pour faire souvent de l'entretien culturel et pas de l'instruction. Cela a été un choix politique, celui de renfermer l'école valdôtaine dans une tour d'ivoire, en pensant qu'elle suffisait à soi-même.
ALPE déjà dans la précédente législature s'était penché sur cet argument. Même s'il semble que des décennies sont passées, seulement il y a quelques années ALPE avait dénoncé cet aplatissement du système culturel de l'instruction valdôtaine, qui petit à petit était en train de détruire et ruiner l'un des plus innovateurs systèmes d'instruction, parce que tel était le système de l'instruction et de la formation linguistique de la Vallée d'Aoste.
Quello che ho ripercorso è lo stato dell'arte, peraltro confermato dai rapporti del Conseil d'Europe, accessibili a tutta la popolazione, che già nel 2007 parlava di eccellenze a macchia di leopardo, della necessità urgente di formazione e di confronto all'interno del sistema scolastico e con i docenti. In questo clima di grande sete di formazione e di stimoli nuovi in cui versava la scuola valdostana, flagellata, come tutte le suole italiane, da continue riforme e riformine che decadevano insieme ai loro ministri prima ancora di essere applicate (ma che in questi anni sono state calate nella scuola e spesso è stato chiesto alla scuola stessa di adeguare alcuni passaggi), in questo clima di grande sete è normale che la riforma Renzi della cosiddetta "buona scuola" abbia trovato terreno fertile, perché apparentemente frizzante, eclettica, scattante e di grande fascino innovatore. La "buona scuola", che parlava tante lingue, è apparsa la soluzione per tutti, il giusto compromesso per correre verso il futuro, per risolvere il problema del precariato, per rinnovare e adeguare la formazione linguistica e le competenze degli alunni ai parametri europei. Non possiamo dimenticare che non solo la Valle d'Aosta in alcune lingue non raggiunge i parametri europei, ma anche tutta la scuola italiana è molto indietro. Il nostro gruppo ALPE l'ha considerato un'occasione importante l'avere siglato un'intesa con il Ministro nel 2015, per permettere alla nostra Regione, in virtù delle nostre prerogative statutarie, di ancorare una legge con dei principi interessanti a un territorio come la Valle d'Aosta, con le sue caratteristiche e le sue peculiarità sia geografiche che storiche. Abbiamo votato favorevolmente anche la norma di attuazione che recepiva questa intesa: un atto dovuto che ha recepito velocemente l'intesa. Noi abbiamo creduto che potesse essere un primo passo per poter veramente dare un'altra marcia alla nostra scuola.
Purtroppo, tutto il percorso che noi abbiamo condiviso con la maggioranza finisce qui. Tutto il resto è stato semplicemente un susseguirsi di scelte politiche, come ha detto lei, Assessore, prese en petit groupe. Lei ha ascoltato tante persone, è vero, tanti petits groupes, spesso della maggioranza, con un percorso spesso caratterizzato da forzature e da passaggi più o meno condivisi. E siamo arrivati ad adesso. Abbiamo investito anche noi tante energie, ma anche tante aspettative, così come tutto il mondo scolastico, per questo passaggio legislativo che ha delle ricadute molto pratiche nel lavoro quotidiano. Alla fine ne è risultata, assessore Rini, una riforma di Ferragosto, perché probabilmente - ce l'ha anticipato lei - la legge verrà votata in questi giorni e nel giro di un mese gli adattamenti saranno resi applicativi con una delibera di Giunta, quindi tutto potrà partire.
Lei ha parlato spesso di coinvolgimento di tutti gli operatori del settore. Per il nostro gruppo coinvolgere non vuol dire semplicemente sentire, ma saper ascoltare. Non vuol dire sentire e poi dare uno zuccherino o dei pezzettini a ciascuno, per accontentare un po' tutti, ma alla fine fare - come l'abbiamo definito - uno spezzatino. Magari è anche uno spezzatino di ottima qualità, però è stato spezzettato un sistema che non ha nessun valore se viene preso a pezzetti. Vediamo in questo un metodo ormai consolidato da questa maggioranza: quello di fare finta di condividere. La parola condividere credo che dovremo ridefinirla sul vocabolario, perché in Valle d'Aosta condividere e coinvolgere non hanno lo stesso significato che altrove. Riconosciamo alcuni aspetti positivi e riteniamo che non necessariamente i pezzettini con cui ha cucinato questa legge fossero di cattiva qualità, ma il problema è che ha usato ingredienti che spesso non vanno neppure insieme.
Certo che ci sono aspetti positivi e possiamo ribadirli. La decisione di salvaguardare il sistema della scuola d'infanzia riteniamo sia un passaggio importante e non scontato. Sarebbe stato massacrante smantellarlo, ma visto che al peggio non c'è mai fine, lo riteniamo un valore veramente importante. La formazione obbligatoria e la sostituzione degli insegnanti per fare aggiornamento sono passaggi comunque importanti, altrimenti i docenti si ritroverebbero a fare aggiornamento sempre e solo la sera. Il principio dell'alternanza scuola/lavoro, che viene recepito in modo soft, ma speriamo che si riuscirà ad applicarlo. Però, ci saremmo aspettati una scelta un po' più coraggiosa sull'inserimento dell'istruzione e della formazione professionale in questa legge: poteva essere davvero una prerogativa del nostro sistema valdostano, visto che abbiamo una competenza primaria. Poteva essere un aspetto importantissimo, che avrebbe dato originalità alla nostra legge, invece non viene citato e questo ci lascia un po' perplessi.
C'è finalmente un tentativo di razionalizzare l'utilizzo degli spazi scolastici nei periodi di sospensione. Ricordo che tutti gli Enti locali e tutti i Comuni sul territorio l'hanno sempre fatto e hanno sempre cercato di razionalizzare i propri spazi, non solo nei periodi estivi, ma anche nei periodi di sospensione.
Possiamo andare a cercare altri aspetti e sicuramente negli emendamenti troveremo alcuni passaggi che verranno recepiti all'ultimo momento, ma amplieranno, a nostro avviso, quello spezzettamento e quel puzzle fatto con pezzi di scatole diverse e che quindi non si parlano fra di loro. C'è stato un ampio confronto, ma non un'ampia condivisione. È una legge che non ha una struttura, a parte lo slogan, che in certi momenti diventa quasi ossessivo, del principio di insegnamento bi-plurilingue.
È una legge insipida, che non è ancorata e che non parla con il territorio e soprattutto non rappresenta le istanze degli operatori del settore. Mi dispiace doverla contraddire, Assessore, ma noi non condividiamo quanto lei ha detto, poiché assolutamente non rappresenta le istanze che hanno portato gli operatori del settore. Non solo gli insegnanti: abbiamo interpellato specialisti che operano nella scuola, logopedisti, genitori, dirigenti, sindacati e li abbiamo ascoltati in Commissione tutti insieme. Non possiamo usare i suoi toni trionfalistici, neanche per quanto riguarda il sostegno a quei casi più delicati e che necessitano di più attenzioni. Partirà una formazione con l'Università: siamo contenti e favorevoli a questo, ma intanto potevamo garantire una continuità che non ci sarà.
Riteniamo che nella legge ci fosse la possibilità del potenziamento, dando in alcuni casi un sostegno in più a tutta la scuola di base. Lei, Assessore, ha parlato di un potenziamento linguistico attraverso le adaptations, ma noi pensiamo che, purtroppo, si tratti solo di un grosso slogan e che in questo momento non abbia nessuna applicazione concreta. Soprattutto non vediamo l'efficacia di questa scelta e riteniamo sia un potenziamento fittizio.
C'è un aspetto grave che riteniamo sia più preoccupante. Quando abbiamo sollevato alcune perplessità sull'inserimento in tutte le classi prime, di tutti gli ordini e gradi della scuola, è stata fatta una marcia indietro ed è stato scelto il compromesso di utilizzare otto o dieci moduli nelle classi prime. Sarà una scelta ancora più inefficace, perché chiaramente otto o dieci moduli in un anno scolastico saranno poco incisivi, cioè saranno uno slogan. Voi la interpretate come una gradualità, ma per noi questa è un'occasione persa.
Il disegno di legge che ci viene presentato oggi - probabilmente sarà legge per l'anno scolastico 2017/2018 e questo è positivo, perché il mondo della scuola avrà un anno di tempo per prenderne atto - parla burocratese, non è ancorato al nostro territorio e soprattutto non è collegato ai lavori delle commissioni per le adaptations. Tutto il mondo insegnante sa come ha avuto origine: sono partiti dei gruppi che avevano un'indicazione e che hanno lavorato, ma dal mese di gennaio c'è stata tutta una serie di anticipi di delibere e di scelte che andavano in senso contrario alle indicazioni e agli indirizzi dati ai gruppi di lavoro. Questo ci è stato detto non solo in Commissione, ma anche dal mondo insegnante. Noi ringraziamo i gruppi di lavoro per le adaptations, gli insegnanti e gli ispettori, che sappiamo avere sicuramente operato cercando di fare il migliore lavoro possibile, ma il problema sono le condizioni nelle quali si lavora. Noi riteniamo che queste adaptations avrebbero avuto bisogno ancora di tempo, per essere concrete e applicabili in un modo efficiente. Poi, se le vogliamo mettere solo sulla carta, vanno bene così, Assessore, ma noi non possiamo avere questi toni trionfali. Partecipiamo anche noi ai ringraziamenti a tutto il mondo che ha collaborato e che ha dedicato tanto tempo, ma ci rimane il rammarico che molti di questi si sono sentiti davvero denigrati nel loro ruolo, perché spesso hanno parlato al vento e le loro preoccupazioni sono anche le nostre. I dirigenti scolastici sono venuti a parlarci con intenzioni molto diverse da quelle che ognuno di noi si aspettava. Hanno parlato di applicabilità, hanno parlato di poter dare gambe, attraverso delle scelte anche coraggiose, a quanto veniva chiesto loro dal PTOF (Piano triennale offerta formativa); erano d'accordo a migliorare l'offerta formativa, ma se poi non gli vengono dati gli strumenti, non lo possono fare. È un po' come chiedere a qualcuno di volare e poi tarpargli le ali. Non parlo della chiamata diretta, ma di tutta un'altra serie di passaggi che assolutamente i dirigenti scolastici ci hanno portato.
Vorrei fare un passaggio sull'essere garante delle peculiarità della Valle d'Aosta, che vuol dire esercitare le proprie potestà legislative. A nostro avviso, questo significa rendere una legge applicabile e aderente al territorio, farla parlare con il territorio: questo è essere garanti delle nostre peculiarità.
Lei ha parlato dei vincoli giuridici e di un eventuale tavolo per la regionalizzazione. Non vorrei che si confondesse il fatto di avere dei vincoli giuridici di tipo legislativo nazionali, che dobbiamo rispettare, con la necessità urgente di avere la regionalizzazione. Mi sembra sia un binomio che questa maggioranza sta portando avanti in modo un po' ossessivo. E non vorrei che fosse un alibi - l'ennesimo! - per far passare sopra la testa di tutti gli operatori del settore, anche questa scelta, sulla quale siamo d'accordo che dobbiamo parlare, riunirci e fare delle riflessioni, ma non vorrei che anche su questo si forzasse la mano. A nostro avviso, questi vincoli giuridici potevano essere davvero la chiave con la quale parlare in modo diverso allo Stato e al Ministro. Noi, nell'intesa pensavamo che potesse essere possibile essere garanti delle nostre peculiarità anche riguardo a questo, anche riguardo agli organici, anche riguardo al reclutamento degli insegnanti. Per questa riforma avremmo voluto dire anche noi dei sì, tanti sì. Purtroppo, spesso, per dire tanti sì e per far crescere bisogna anche dire tanti no. Non credo che questa riforma possa, come dice lei Assessore, far épanouir notre territoire.
Avete preso la responsabilità di decidere in fretta, in modo superficiale, in modo frettoloso e la scuola - glielo assicuro, conoscendo bene l'ambiente scolastico - si farà in quattro per rendere quanto deciso in questa sede il più applicabile e il più efficiente possibile, perché il corpo insegnante è sicuramente composto da persone molto responsabili. Ma quello che manca completamente in questa legge ed è quasi assente nel testo delle adaptations è la parte didattica e pedagogica, che è quella che, a nostro avviso, darebbe più risposte agli studenti. Assessore, lei ha detto di avere messo al centro gli studenti: li abbiamo messi talmente al centro, che non ne abbiamo quasi mai parlato.
Infine, le sfide che avete accettato per il futuro e che, anche noi, riteniamo essere tali. Avete parlato delle lingue, di tecnologia e di digitalizzazione: erano anche i principi ispiratori della "buona scuola", erano principi assolutamente sostenibili. È anche vero che senza risorse le belle idee non vanno avanti.
Chiedo, Presidente, di prendere qualche minuto dal prossimo intervento, per favore.
Presidente - Prego.
Certan (ALPE) - Peccato che un settore fragile come quello della scuola secondaria di primo grado - un ambito che è fondamentale e fragile, perché è in un momento dell'età evolutiva del ragazzo importantissimo - che doveva essere sostenuto, invece voi l'avete raso al suolo, togliendo quello che la Valle d'Aosta aveva di peculiare. Era l'unica cosa che nella scuola secondaria di primo grado stava funzionando e iniziava a portare dei frutti, perché gli insegnanti di tecnologia e di informatica si erano organizzati in modo da poter essere di sostegno e di aiuto per i progetti nella scuola, ma voi avete raso al suolo. Era l'unica peculiarità che potevate e dovevate mantenere, invece a nulla sono valse le prese di posizione, la grande pazienza e professionalità con la quale i docenti, con il cuore in mano, vi hanno spiegato le cose. Siete stati sordi a qualsiasi proposta, ma in compenso siete andati a potenziare la scuola secondaria: ottimo e riteniamo che fosse veramente un passaggio importante, ma noi diciamo che il potenziamento andava fatto - e noi proponiamo di farlo attraverso degli emendamenti che abbiamo proposto - per tutta la scuola di base.
Per quanto riguarda la valutazione, se c'è una categoria che non ha mai avuto paura di essere valutata (anche perché era obbligata), quella è la classe insegnante, la quale è sempre stata valutata dai genitori e dalla società. Siamo d'accordo che la valutazione è necessaria, ma per essere efficace deve rispondere a criteri di praticità e soprattutto di utilità. Nella scuola non esistono le cose inutili. Le cose inutili si possono scrivere, ma nella scuola non sono efficaci, altrimenti, invece di essere d'aiuto, si fa perdere tempo agli studenti. E a degli studenti in crescita non è leale far perdere tempo.
Per quanto riguarda la metodologia CLIL di scienze, se avevamo dei dubbi, il suo passaggio oggi ci ha davvero preoccupato e adesso abbiamo la certezza. Ci ha fatto un miscuglio fra le competenze nell'ambito scientifico, che paiono essere un po' deboli nella scuola secondaria di primo grado, e ci dice che per questo siamo andati a potenziarle attraverso ore di scienze in lingua inglese. Mi sembra che ci sia una confusione di fondo, che spero si riesca a spiegare. È vero che la sfida non è facile, ma per gli insegnanti, con questo disegno di legge che si vuole approvare oggi, la sfida si complicherà ancora di più: per gli insegnanti, per i dirigenti e anche per i genitori.
Non abbiamo lesinato energie neppure noi. Non possiamo avere oggi toni trionfalistici come quelli che usa lei, Assessore. Questi toni li riteniamo essere frutto e indice di grande debolezza. Oggi approviamo e deliberiamo un testo che la politica ha voluto, restando sorda a tutti gli inviti che sono stati fatti o comunque all'invito principale, che era quello di avviare un dibattito nel mese di settembre, da concludere tra settembre e ottobre, partendo comunque con quella che lei ama definire una sperimentazione, un nuovo corso che deve venire, perché sappiamo cosa vuole il mondo. Anche noi sappiamo cosa vuole il mondo scolastico e non è quello che oggi approviamo. Noi oggi siamo profondamente delusi di dover votare contro una legge che avremmo voluto, invece, condivisa con tutta la società valdostana.
Dalle ore 10:13 assume la presidenza il vicepresidente Marco Viérin.
Viérin M. (Presidente) - Ha chiesto la parola il consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (SA) - La formazione e la scuola sono da sempre un fiore all'occhiello della Valle d'Aosta. Anche in tempi duri e difficili abbiamo creato modelli come les écoles des hameaux, imitati poi dai transfrontalieri. Di fronte a una riforma che ha creato molto fermento nel mondo della scuola, pur procedendo all'armonizzazione della legge 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, attraverso l'accoglimento, in parte, delle modifiche apportate a livello nazionale, abbiamo ritenuto opportuno salvaguardare e valorizzare il sistema scolastico valdostano, difendendo e conservando la sua particolarità. Per questo oggi ci troviamo a discutere una legge che abbiamo chiamato la "nostra scuola", una legge che vuole modernizzare il sistema formativo valdostano e, allo stesso tempo, riportare - e in questo adeguarsi ai tempi - anche le caratteristiche del nostro particolarismo.
Siamo arrivati al testo definitivo attraverso discussioni, proteste, ma soprattutto incontri, perché abbiamo voluto ascoltare in V Commissione - e anche in altre occasioni - la voce di chi nella scuola vive e lavora ogni giorno. Abbiamo ascoltato e analizzato il parere e la voce dei dirigenti scolastici, facenti parte dell'Associazione nazionale presidi, il comitato "SOS école", i sindacati di categoria, i referenti valdostani dell'Associazione Logopedisti Italiani e l'Associazione Italiana Dislessia. Se da una parte questo disegno di legge è approdato in aula in tempi abbastanza rapidi, come ci è stato rinfacciato a più riprese, a onore del vero il dibattito che ha preceduto l'articolato oggi in discussione risale all'anno scorso, allorché ebbero luogo sul territorio valdostano degli appositi dibattiti pubblici dedicati al tema della "buona scuola".
L'articolato che oggi è sottoposto all'esame dell'Aula consiliare è pertanto il frutto di un confronto e di un dialogo serrato e animato con tutte le parti interessate, funzionale a recepire alcuni suggerimenti, al fine di migliorarne la stesura finale. La proposta nazionale della legge 107, detta "buona scuola", non ci ha mai convinti del tutto. Alcuni aspetti ci appartenevano già, mentre altri erano troppo complessi per un territorio come il nostro, piccolo e soprattutto autonomo. Grazie alla specifica norma di attuazione, conseguente alla proficua collaborazione tra l'assessore Rini e il ministro Giannini, sfociata nel luglio del 2015 con la firma di un protocollo d'intesa, abbiamo cercato un equilibrio, senza trincerarci dietro tutti no o sbandierare tutti sì, entrambi poco credibili. Ecco allora la nostra proposta legislativa, la "nostra scuola", che ha provveduto persino a correggere alcune dimenticanze della norma nazionale, come la scuola dell'infanzia, dimenticata dalla 107, invece molto considerata nella nostra legge, tanto che si sottolinea come, tra le finalità, ci sia quella di valorizzare le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia, in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.
Abbiamo sottolineato l'attenzione al plurilinguismo, su cui, oltre al francese, stiamo lavorando già da anni. Dirigenti e docenti appartengono ai ruoli regionali, così come gli insegnamenti nazionali o le indicazioni nazionali del curricolo, devono essere adattati alle necessità locali. Su questo abbiamo lavorato, scoprendo a ogni riunione la bontà del sistema di istruzione valdostano, tante volte lungimirante nelle proprie scelte. Abbiamo già aggiunto le prove Invalsi e abbiamo già affiancato al francese - lingua paritaria - anche l'inglese, fin dalla scuola primaria, con modalità CLIL. Ora avremo anche lo strumento legislativo per curare ulteriormente la formazione dei docenti.
Con il presente disegno di legge vengono indicate le disposizioni che porteranno al completamento del processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, come previsto dalla legge regionale 26 luglio 2000 n. 19 (Autonomia delle strutture scolastiche) adattando i principi della legge n. 107/2015 al particolare ordinamento scolastico regionale. Il relatore, nel suo preciso ed esaustivo intervento ha già evidenziato i contenuti degli articoli che compongono il testo di legge. Tra l'altro, vorrei sottolineare l'importanza di aver sancito in legge la scelta politica effettuata l'anno scorso in merito al polo scolastico unico. Infatti, con l'articolo 26, è autorizzata a partire per l'anno scolastico 2017/2018 la revisione del piano di dimensionamento dell'istruzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, con sede a Verrès e a Pont-Saint-Martin, e la conseguente istituzione mediante aggregazione di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e professionale, con sede principale a Verrès. Grazie alla realizzazione del polo unico sarà assicurata la continuità del percorso di studi per i giovani del territorio della bassa Valle, creando pari opportunità di accesso all'istruzione superiore a tutta la comunità e risolvendo anche il problema relativo alla frammentazione della dirigenza e dell'istruzione scolastica.
Come membro della V Commissione consiliare, mi corre l'obbligo di sottolineare l'attenzione che l'assessore Rini, il sovrintendente agli studi Gentile e il dirigente Gregori, hanno prestato alla realizzazione del disegno di legge, accogliendo i numerosi suggerimenti provenienti dagli auditi, a condizione che non fossero in contraddizione con l'impianto normativo complessivo, o fossero frutto di una diversa visione dell'argomento affrontato. Conseguentemente, l'Assessore ha presentato in Commissione consiliare undici emendamenti, che sono il frutto del confronto con le organizzazioni sindacali scolastiche e del proficuo dibattito scaturito anche grazie alle audizioni in V Commissione. Permettetemi quindi, anche a costo di ripetere cose già dette, di richiamare alcuni di questi emendamenti. In primo luogo, nelle finalità del disegno di legge, si è posta l'attenzione anche agli studenti con bisogni educativi speciali, tema che sta molto a cuore al movimento Stella Alpina. La scuola è un diritto per tutti, soprattutto per coloro che incontrano maggiore difficoltà per il raggiungimento del successo formativo. In tale direzione va sottolineata anche l'attenzione nei confronti degli studenti disabili, attraverso l'attivazione futura di tirocini formativi attivi, dedicati specificamente al loro sostegno. Si è poi formalizzato il fatto che i piani di miglioramento di istruzione scolastica, previsti dal rapporto di autovalutazione, trovino idonea collocazione nel piano dell'offerta formativa. Infatti, un rapporto di autovalutazione ha un senso se, dallo stesso, conseguono azioni migliorative che vanno a colmare le criticità rilevate.
Per quanto riguarda la disciplina della sostituzione del personale assente, non è stata riprodotta in modo restrittivo, come previsto dalla legge 107. Al contrario, oltre a non discostarsi dalla disciplina oggi vigente, si è prevista la sostituzione, sin dal primo giorno, per il personale impegnato in attività formative, legate al particolarismo linguistico regionale. Nell'ottica del pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è stata lasciata alle stesse la decisione se articolare le lezioni su cinque o sei giorni. Questa scelta, alla luce anche delle considerazioni e delle richieste esplicitate in merito da tutte le organizzazioni sindacali, dall'Associazione Presidi, dal comitato "SOS école", sembra essere anche più rispettosa dei carichi di lavoro dei diversi indirizzi di studio. L'inglese, l'educazione motoria e la musica sono stati oggetto di particolare attenzione nella scuola primaria, grazie anche alla previsione che il dirigente scolastico possa utilizzare, per il loro insegnamento, docenti di altri gradi di istruzione con specifiche competenze. È stata poi estesa la possibilità di spendere l'importo di 500 euro, previsto per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, non solo in Italia, ma anche all'estero, al fine di favorire così l'attività di autoformazione che vada nel senso del bi-plurilinguismo che caratterizza il nostro ordinamento scolastico.
Queste ultime mie considerazioni sono finalizzare a evidenziare un aspetto che purtroppo è diventata una regola di vita nella società attuale. Ormai vi è la tendenza a porre sempre in evidenza ciò che non va bene o ciò che si sarebbe potuto fare in modo diverso, dimenticando, invece, di apprezzare e di evidenziare lo sforzo fatto, anche se a volte non esaustivo, per addivenire, come in questo caso, a un testo di legge più vicino alle esigenze e alle sensibilità del mondo scolastico valdostano, tenuto conto che nel resto d'Italia si applicherà tout court la riforma cosiddetta della "buona scuola".
Ogni riforma è di per sé complessa, comporta dibattiti e discussioni e genera sempre del malcontento, in quanto non può accontentare tutte le parti. Un conto sono, però, le critiche costruttive, che se in un primo momento magari non vengono prese in considerazione, tuttavia permettono di rifletterci sopra per poi eventualmente intervenire successivamente, un altro sono le critiche e le prese di posizione dure, finalizzate solo a non cambiare nulla per il quieto vivere, mantenendo lo status quo senza guardare al futuro.
Noi abbiamo cercato di affrontare tale riforma con l'obiettivo di continuare a investire nella specificità e nell'unicità del modello scolastico regionale, di mantenere e valorizzare le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia, di mantenere il sistema attuale di reclutamento dei docenti che ha sempre dato buoni risultati, di rafforzare le competenze degli studenti nelle materie scientifiche, linguistiche e informatiche, di potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva, di alfabetizzazione all'arte e alla musica, di sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di tutela del diritto allo studio per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica, di dare stabilità, solidità e lungimiranza alla programmazione scolastica, di avere una scuola performante investendo sulla formazione dei docenti, di creare un meccanismo di valutazione del sistema scuola. Per queste motivazioni voteremo questo disegno di legge, che tiene conto delle positive peculiarità del nostro sistema scolastico, salvaguardando modelli organizzativi didattici da tempo collaudati, ma introducendo, nel contempo, alcune significative novità che guardano al futuro, sempre nell'ottica di un miglioramento costante del nostro modello scolastico in un momento, come quello attuale, di cambiamento e di sperimentazione.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Cognetta, ne ha facoltà.
Cognetta (M5S) - Ho ascoltano con attenzione gli interventi dei colleghi e dell'Assessore. Volevo fare un preambolo rispetto alla discussione di questo disegno di legge. Mi ha fatto molto piacere che l'Assessore abbia ringraziato tutti coloro che hanno partecipato ai lavori. Non so se si riferisse anche a me, perché anch'io ho partecipato: qualora si riferisse anche a me, la ringrazio per i ringraziamenti. Io ho seguito con attenzione i lavori preparatori e sinceramente tutta questa condivisione non l'ho vista. Magari è perché io non riesco a vedere in maniera corretta le cose, però mi pare che non è che tutti fossero proprio così contenti e convinti di essere stati ascoltati e presi in considerazione. Tant'è che ci sono dichiarazioni che, invece, vanno in senso opposto, con sindacati che hanno detto chiaramente che non erano d'accordo e che volevano arrivare a settembre per discutere questo disegno di legge; stesso discorso vale per il comitato e per i rappresentanti dei dirigenti scolastici.
Lei non ha fatto un discorso approfondito sulle norme, perché avremo modo di discutere durante l'articolato. La presentazione fatta dal collega Guichardaz è stato un volo radente sulle cose più importanti e mi ha fatto anche piacere che lei abbia detto che abbiamo preso una parte delle cose buone e le altre le abbiamo lasciate. Dovremmo solo metterci d'accordo su quali sono le cose buone che abbiamo preso e su quali sono le cose cattive che abbiamo lasciato. Comunque, avremo modo di parlarne.
Ho capito perché non è voluta andare a settembre e non è certo per la questione dei 2200 bambini a cui diamo una chance meravigliosa. È perché in Trentino c'è stato un dibattito aspro e acceso, che noi abbiamo volutamente e accuratamente evitato: lo facciamo d'estate, così risolviamo i nostri problemi. Lei, quando vuole, sa copiare e lo sa fare anche bene.
Ha anche aggiunto che gli studenti, rispetto a come eravamo noi, sono più veloci, quindi dobbiamo modificare la scuola in questo senso, cercando di andare incontro a questi ragazzi che hanno delle competenze o comunque un tipo di intelligenza diversa da quella che avevamo noi. Mi rendo conto che in questa riforma non si fa nessun accenno a questo e non vedo dove lei sia riuscita a mettere l'accento rispetto alla risoluzione di questo problema. Tant'è che la dispersione scolastica continua a esserci ed è sempre molto importante. Poi, più avanti, dirò quali sono state le indicazioni - le conosce anche lei, ma gliele spiegherò di nuovo - rispetto a come i ragazzi vedono la scuola, perché c'è stato uno studio approfondito fatto dalla nostra Università, che fa vedere che, in effetti, la scuola per i ragazzi non è che sia proprio il massimo e non va incontro del tutto a ciò che vorrebbero fare.
Una cosa bellissima è come risolviamo il problema dei precari che non riusciranno a entrare nella scuola: gli facciamo un bel corso a pagamento, li trasformiamo in qualcos'altro e speriamo che trovino lavoro. È un bel modo di risolvere il problema! Però il prezzo è agevolato: non pagheranno la tariffa piena e gli faremo un po' di sconto. D'altronde, per trovare lavoro è anche giusto pagare qualcosa oggi come oggi: vista la scarsezza di lavoro che c'è, mi sembra il minimo. Speriamo che sia l'ultima volta che pagano, perché ogni volta che vanno a fare un corso questi signori, poverini, devono pagare e poi, alla fine, si ritrovano sempre in mezzo a una strada, da precari. Ma apprezzo lo sforzo, veramente: avete fatto uno sforzo enorme per cercare di risolvere questo problema, con il quale pagando un corso, in parte, riusciamo a riqualificarli.
Sui 2200 bambini ho già detto che probabilmente questo è il modo migliore per cercare di dargli un futuro, perché prima non ce l'avevano, mentre adesso con le adaptations e con i dieci moduli, o quel numero di moduli che pensa di mettere in campo, probabilmente riusciranno a fare qualcosa. La cosa più bella è il titolo che gli ha dato: lei l'ha chiamata la "nostra scuola". Io l'avrei chiamata la scuola di tutti, perché la "nostra" o la "vostra" non è che con la scuola funzioni tanto. Se fosse stata la scuola di tutti, probabilmente sarebbe stato un nome più azzeccato, secondo il mio modesto punto di vista. Ma è la "nostra scuola", cioè la sua e come tale se la può tenere.
Adesso vorrei fare un breve excursus di che cosa è stata la scuola nel corso delle ultime centinaia d'anni all'interno della società. Se non sappiamo da dove siamo partiti, come facciamo poi a vedere cosa dovremmo fare per migliorare questa questione? Partiamo dal Medioevo, che non è così distante. Nel Medioevo l'istruzione e la scolarizzazione in Italia erano interamente fornite dalla Chiesa. In particolare, non esistevano le scuole laiche e c'erano solo scuole tenute dal clero. Erano divise in tre tipi: parrocchiali, vescovili e dell'Ordine benedettino. Le scuole parrocchiali davano un'istruzione limitata, ma era l'unica che fosse accessibile a una piccola parte della popolazione, in quanto si preferiva far lavorare i propri figli, anziché mandarli a studiare. Questa è una cosa che è ritornata spesso, negli anni, anche in Valle d'Aosta, non so se ve la ricordate. Ricordo, quando ero ragazzo, che nel mio gruppo di amici, abbastanza numeroso, eravamo solo in due ad andare alle superiori, mentre tutti gli altri, finite le medie, erano andati a lavorare. Quindi c'è qualche assonanza con il Medioevo. Il fine delle scuole religiose era essenzialmente la preparazione del clero, o meglio, di una parte minoritaria del clero. Alcune delle scuole vescovili, però, ammettevano come studenti anche alcuni laici. Il livello medio di istruzione era comunque molto basso, anche tra i nobili. Anche questa è una cosa che si ripete: non sempre quelli che oggi detengono il potere hanno un livello di istruzione elevatissimo. Ma questo non è importante e per fortuna abbiamo superato le lotte di classe. Il livello medio di istruzione era molto basso e quindi c'era una diffusione dell'analfabetismo. Oggi come oggi, un altro dei problemi che non vengono affrontati è l'analfabetismo di ritorno. Quando io conseguo un titolo di studio, ma poi non esercito più, non faccio più allenamento rispetto alle cose che ho imparato, normalmente le dimentico e il mio livello di istruzione, anche se apparentemente sulla carta è di un certo tipo, in realtà si abbassa: più passano gli anni e più perdo conoscenza. Questo abbassamento si chiama analfabetismo di ritorno. Succede spesso e lo vediamo quando, ad esempio, quello che viene scritto sui giornali non viene compreso; quando discorsi come quello che sto facendo, a volte, non sono capiti dalla popolazione media che ci ascolta, perché anche se parlo un italiano normale il senso di alcune parole si perde.
Alcune famiglie assumevano religiosi come precettori privati per i propri figli, cosa che accade anche oggi: le famiglie più facoltose possono assumere dei docenti per materie specifiche, o anche per far seguire in maniera privatistica ai propri figli l'istruzione. La scuola inizia a cambiare nel XII secolo e si trasforma nel corso del secolo successivo. Nell'ambito delle scuole religiose, mentre le scuole parrocchiali tendono a sparire, per l'insegnamento superiore i Benedettini vengono affiancati da altri ordini, come i Dominicani. Una parte di questo è restato, perché non vorrei dimenticare tutta la parte della scuola che, ancora oggi, viene fatta dagli ordini religiosi, primo tra tutti i Salesiani, che conosciamo anche sul nostro territorio. Lo Stato diventa sensibile a questo fenomeno e assiste a uno sviluppo abbastanza rapido di scuole laiche tra i diversi livelli. Nasce quindi la scuola primaria, la secondaria e l'università. Partono delle scuole sia private che comunali. Nelle scuole comunali, in particolare, venivano ammessi solo degli allievi che pagavano delle quote - era la scuola privata di oggi - e il maestro integrava il suo stipendio con le quote che in parte gli dava il Comune e in altre parti venivano date dagli allievi. Quando erano molti e si superavano i 75 allievi, il docente poteva assumere un ripetitore: una persona che ripeteva esattamente ciò che veniva detto e gli doveva dare una parte del compenso, quindi è come se assumesse lui un dipendente.
Poi, si passa a una sorta di specializzazione e nascono due tipi di insegnamenti: la scuola dell'abaco e la scuola della grammatica. Nella prima si parla di numeri, di tecniche di calcolo, quindi è una parte più tecnica. La seconda, invece, si basa tutto sullo studio degli autori classici. È un po' la differenza che c'è oggi tra i licei e gli istituti tecnici. Gli studenti che frequentavano le scuole dell'abaco erano poco più della metà del totale. Le scuole d'abaco e quelle di grammatica esistevano sia nella forma privata che in quella comunale. Alcuni Comuni istituirono altri tipi di scuole, ad esempio scuole di giurisprudenza, quindi cominciarono proprio delle specializzazioni ulteriori.
Infine, nell'XI secolo sorse l'università e la prima fu quella di Bologna. Anche questa è una nota importante, perché vuol dire che noi sulla scuola abbiamo sicuramente un certo tipo di storia molto importante.
Finita questa fase, si passa al Rinascimento in cui il sistema scolastico rimane più o meno quello dell'inizio, ma si diffonde sicuramente la scuola normale e si impara a leggere e scrivere. Si comincia ad andare a scuola anche dopo i dieci anni, perché all'inizio si andava a scuola solo fino a quella età. La cosa importante è che l'analfabetismo comincia a scomparire. Anche su questo dovremmo ragionare, assessore Rini, perché noi, con la logica che abbiamo oggi di valutare le competenze attraverso le prove Invalsi, ci siamo accorti che questo tipo di verifiche non valutano in maniera corretta le competenze. Quindi rischiamo di lavorare, di mettere dei marcatori, di fare un lavoro molto approfondito su quella che dovrebbe essere la scuola e poi, alla fine, di non andare a misurare le cose in maniera corretta. Anche nel Rinascimento si erano preoccupati di questo e, in effetti, nelle scuole di grammatica cominciano a modificare profondamente i programmi, perché si rendevano conto che non bastava ciò che veniva fatto in quel momento. In particolare, furono eliminati dei programmi e altri acquistarono di importanza. Per esempio, accanto ai poeti, alcuni dei quali erano già letti, furono introdotti i prosatori di epoca classica: Cicerone, ma anche Cesare, Sallustio e Valerio Massimo. Furono portati nelle scuole, perché si cominciò a capire che bisognava dare un grado di cultura superiore. Poi, sempre nel Rinascimento, nascono le scuole umanistiche di livello superiore. La cosa più importante che succede in questo periodo è la famosa "Casa giocosa" fondata e diretta da Vittorino da Feltre e ciò che accade in altre Repubbliche, quale la scuola San Marco, dove insegnarono Giorgio da Trebisonda, Giorgio Valla e Marco Musarra.
Andiamo avanti e passiamo a ciò che accade con la riforma della scuola cattolica. Verso la fine del '400 comincia a farsi largo la scuola della dottrina cristiana, che oggi è vista come l'ora di religione. Ora, giustamente, vengono fatti una serie di passaggi per riformare la scuola e, in particolare, assume importanza storica la riforma cattolica dei Gesuiti e anche di altri ordini religiosi. Siamo nel 1550/1600 circa e i Gesuiti in primis, più tutte le altre scuole, cominciano ad avere una struttura più vicina a ciò che accade oggi, perché la scuola viene divisa tra elementare e superiore, anche se non è proprio così diretto il collegamento, nel senso che ci sono due livelli di insegnamento: il primo è quello di base, ma al secondo accedevi solo se avevi un'importanza economica alle spalle di un certo tipo. La permanenza nelle classi dipendeva dal valore delle tue conoscenze, quindi a seconda del livello in cui stavi, potevi restare in una classe anziché andare nell'altra. Oggi si è persa un po' questa cosa, Assessore, perché tendiamo a promuovere tutti sempre e comunque: questo, secondo me, è uno dei grossi problemi della scuola che, anche in questo caso, non viene affrontato. Anziché fermare chi magari non è arrivato a un certo livello di conoscenza, cerchiamo comunque di mandarlo avanti, abbassando il livello complessivo delle conoscenze di tutti. All'epoca, invece, si fermavano i ragazzi che non riuscivano ad arrivare a un certo livello e, nelle due configurazioni, si finiva o a 10/11 anni o a 16/17 anni.
Tutto questo va avanti fino al '700, quando le scuole pubbliche, finalmente, sono promosse e controllate dallo Stato e cominciano a diventare qualcosa di molto vicino a noi. Lo Stato italiano che cominciò questa cosa fu il Regno di Sardegna. In particolare, una serie di riforme sono state attuate da Vittorio Amedeo II di Savoia. Tra il 1717 e il 1727 vengono istituite diverse scuole laiche statali. Questo è altrettanto importante, perché noi ragioniamo sul fatto di essere stati dei precursori, ma abbiamo dimenticato questa cosa. È un peccato quello che succede nella storia: sei avanti e poi pian pianino ti fai superare dagli altri e, alla fine, rimani indietro. Vittorio Amedeo II di Savoia, tra il 1717 e il 1727, prepara una riforma generale e fa una cosa molto importante: espelle i Gesuiti da molti Stati, quindi anche dalla scuola, facendola diventare una scuola laica, che è una cosa che ci portiamo ancora oggi in parte e che, per quanto mi riguarda, condivido appieno.
Nel Ducato di Parma e Piacenza, Ferdinando I di Parma organizza una scuola pubblica laica e poi, sia a Piacenza, sia nel piacentino, sia in altre zone d'Italia, queste scuole cominciano a crescere e a diffondersi. Nel Granducato di Toscana la riforma scolastica è stata iniziata da Pietro Leopoldo I. Rimangono istituti religiosi solo nello Stato Pontificio. Quindi la Chiesa, alla fine, viene messa da parte e inizia la scuola laica.
Il vero punto di svolta fu la Rivoluzione francese, che ha visto anche noi, come Valle d'Aosta, protagonisti di questa cosa. Si afferma una nuova concezione di scuola, completamente diversa, perché finalmente l'istruzione viene concepita come pubblica, obbligatoria, gratuita e soprattutto possono accedervi sia maschi che femmine, finalmente. Nella scuola francese viene bandito qualunque insegnamento religioso: sappiamo che la Rivoluzione francese non è che amasse molto quel tipo di impronta, però fa crescere delle capacità professionali specifiche e soprattutto mette dei contenuti verificabili e dei metodi razionali per la formazione civile. Questo modello viene esportato in Italia, nelle Repubbliche giacobine, poi nel Regno d'Italia e nel Regno di Napoli: vengono create tutte queste scuole, ma in Italia si fa una leggera differenza e si introduce anche il catechismo.
In questo periodo vengono istituiti anche i primi licei e sono introdotti con una legge del 4 settembre 1802. Nascono i primi ginnasi, copiati dal modello austriaco, e viene istituito un piano di istruzione generale. Siamo nel 1808 e nel Regno d'Italia c'è un liceo in ogni capoluogo o dipartimento e un ginnasio in ogni Comune con più di diecimila abitanti. Questi collegi che vengono creati portano a migliorare il corso di studi.
Arriviamo all'Unità d'Italia. Finalmente parte la legislazione e vengono dati degli ordinamenti. La prima del Regno d'Italia fu la legge Casati del 1859, che sostanzialmente ricalcava la cultura politica dei liberali piemontesi. Dopo la scuola elementare l'insegnamento si divideva in due ginnasi, tutti e due a pagamento, e poi in una scuola tecnica. Era la parte più vicina a noi, quella che di fatto definisce le scuole di avviamento da quelle di cultura più approfondita. L'applicazione di quella legge formale e sostanziale, fatta all'interno del Regno d'Italia, scatena un dibattito, perché si capisce che ci sono classi diverse a seconda di chi frequentava le differenti scuole. In questo dibattito si fa largo il pensiero di Francesco De Sanctis e di Pasquale Villari, i quali discutevano del fatto che nel Mezzogiorno c'erano dei problemi di tipo culturale che non venivano affrontati e risolti attraverso la scuola, perché restava un gruppo di persone ridotto con un'istruzione e con la capacità economica di andare avanti, rispetto a un'enorme massa di persone ignoranti che non riusciva a progredire. Anche questa è una cosa che ritorna, perché sta succedendo la stessa cosa in Italia, da un po' di tempo a questa parte. Quello che dovrebbe essere l'ascensore sociale, che potrebbe permettere a tutti, con l'istruzione, di salire nella scala dei livelli che ci sono all'interno della società, di fatto è bloccato, perché la scuola superiore, soprattutto quella universitaria, visti i costi e visto com'è organizzata, non permette più questo. Succede sempre più spesso che ci siano persone che conseguono una laurea, ma che poi non fanno il lavoro che dovrebbero svolgere, perché non sono direttamente competenti rispetto alla laurea che hanno fatto, o perché semplicemente non hanno scelto uno studio correlato alla richiesta del mercato.
Nel 1871 nascono i primi programmi scolastici, che includevano tutta una serie di materie fondamentali. Le riforme, allora, erano basate sui programmi scolastici, cioè si diceva che cosa bisognava insegnare e come. Passiamo poi al 1877 con la legge Coppino, portata avanti da quella che allora era la sinistra storica, che porta le elementari a cinque anni e introduce l'obbligo scolastico del primo triennio delle elementari, quindi finalmente la scuola diventa dell'obbligo. Nel primo '900 si iniziano a vedere gli effetti positivi di questo obbligo scolastico, perché pian pianino si comincia a diffondere un po' di istruzione - anche se bassa - in maniera più estesa. Per esempio, compare il primo fenomeno di disoccupazione intellettuale. La borghesia dell'epoca iniziava a temere lo sconvolgimento dello status quo sociale e quindi cercava di bloccare questa cosa tentando di modificare i programmi. Quello che succede, in questo caso, è che parte una nuova legge (la legge Orlando), che innanzitutto prolunga l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età e crea un corso cosiddetto "popolare". Si andava a scuola fino alla sesta elementare e si dava una diffusione della cultura di base a tutti, ma soprattutto anche ai più poveri si potevano dare dei supporti per andare a scuola. Si prevedeva anche l'equalizzazione della retribuzione degli insegnanti della scuola elementare, perché prima gli insegnanti venivano pagati a seconda dei Comuni in cui lavoravano.
Dopo la legge Daneo-Credaro passiamo a quella che ha segnato, nella storia, il passaggio più importante: la riforma Gentile del 1923. È il periodo del primo Governo Mussolini e il filosofo Giovanni Gentile, che era un'espressione degli ambienti cattolici, crea la riforma della scuola. Questa prevedeva cinque anni di scuola elementare uguale per tutti; aveva una differenziazione di tre più due anni ed era preceduta da tre anni di scuola materna e da gradi successivi. I gradi successivi potevano essere il liceo classico di tre anni, o quattro per il liceo scientifico, oppure andare all'istituto tecnico o magistrale. A questo punto le scuole seguono due canali: quello del liceo e quello degli istituti più importanti. La riforma Gentile porta l'obbligo scolastico a 14 anni, una condizione che ormai abbiamo anche noi. Questa riforma va avanti e mantiene l'ordinamento scolastico per moltissimi anni.
Nel 1939, con Giuseppe Bottai accade un'altra riforma della scuola, ma il tutto viene bloccato dalla guerra. Dopo il secondo conflitto mondiale si ricomincia a parlare di scuola, in particolare viene scritto l'articolo 34 della Costituzione e viene stabilito che la scuola è gratuita, pubblica e obbligatoria per almeno otto anni. Il sistema scolastico quindi diventa quinquennale più i tre anni delle superiori e diventa obbligatorio anche l'insegnamento del latino.
Le diverse riforme della scuola vanno avanti, fino ad arrivare a quella che è stata, negli anni recenti, la più impattante, almeno da un punto di vista mediatico: la riforma Moratti. Viene fatta durante il periodo Berlusconi e Letizia Moratti, nominata Ministra della Pubblica istruzione, presenta una proposta di riforma radicale, che viene combattuta sia all'interno della scuola che fuori, perché non era affatto condivisa. Poi, arriva il Governo Prodi che fa una serie di altre modifiche, per esempio sull'esame di maturità, piuttosto che sul diritto all'istruzione a 16 anni, e così via. Anche qui ci sono una serie di scontri e arriviamo, infine, alla riforma Gelmini del 2008, che sostanzialmente introduce una serie di modifiche che - anche queste - hanno modificato e complicato ancora di più. Fino ad arrivare a ciò che ha fatto il Governo Renzi con la legge 107 di cui abbiamo parlato fino a questo momento e di cui parla il nostro disegno di legge, anzi il vostro.
Tutto questo, di fatto, segna la storia di come siamo arrivati alla situazione attuale. Questo disegno di legge, che l'Assessore, il relatore e tutti gli esponenti di maggioranza hanno magnificato, non tocca la parte più importante: non riguarda ciò che dovrebbe essere insegnato nelle scuole, come andrebbe insegnato, come si dovrebbe valutare il livello degli allievi e non solo dei docenti. Non ci si pone come obiettivo che cosa dovremmo o vorremmo ottenere. Purtroppo, tutto questo è stato fatto perché da un lato il Governo nazionale ci ha imposto un certo tipo di percorso: se non l'avessimo fatto, ci saremmo presi la legge 107 così com'è e questo sarebbe stato sicuramente un danno, visto che a me piace ancora meno di quello che si sta facendo in quest'Aula. Dall'altra parte, ritengo che avremmo potuto fare molto, molto, molto di più ed è questo il punto. Probabilmente, con un piccolo sforzo da parte dell'Assessore nel rimandare un pochino questa discussione, avremmo potuto migliorare sensibilmente ciò che volete approvare. È stato detto in passato, sempre in quest'Aula, che ci sarebbe stato tutto il tempo per riuscire a sistemare questa legge, cosa che invece, con il blitz di luglio, non è stato fatto.
Io spero che nel prosieguo della discussione riusciremo a sistemare qualcosa. Io ho presentato qualche emendamento per riuscire a far capire che probabilmente questo modo di operare della maggioranza non è corretto, nel senso che non va nella direzione che vorrei, cioè di una discussione seria e proficua, ma fatta con gli attori importanti intorno al tavolo e non quando questi non ci sono.
Dalle ore 11:00 assume la presidenza il presidente Rosset.
Rosset (Presidente) - Ha chiesto la parola il consigliere Fabbri, ne ha facoltà.
Fabbri (UVP) - Io non partirò dalla scuola peripatetica di Aristotele o dall'Accademia di Atene di Platone, perché altrimenti andremmo troppo per le lunghe. Però, vorrei ricordare, per inciso, una particolarità della scuola valdostana, anzi della cultura della società valdostana: les écoles des hameaux, che hanno fatto in modo che la Regione Valle d'Aosta fosse il fiore all'occhiello della cultura nel Regno sabaudo, proprio grazie all'attenzione particolarissima che i nostri progenitori hanno avuto per la cultura e per lo sviluppo dei loro figli.
Oggi giunge alla fase dell'approvazione il disegno di legge 90, con il quale si applica anche nella nostra regione la legge 107, a un anno dall'accordo stipulato con il Governo centrale. Tale legge è il frutto di un lavoro dapprima tecnico e, in un secondo tempo, di un approccio politico di ascolto e di recepimento delle istanze e dei suggerimenti che sono venuti da coloro che operano e lavorano nella scuola, tramite soprattutto i loro rappresentanti, ma anche i loro portavoce. Un lavoro stringente e, se vogliamo, condotto soprattutto nell'ultima fase con una tempistica incalzante, ma che non ha escluso nessun rappresentante del mondo coinvolto. Infatti, l'articolato è il frutto di una condivisione e di un recepimento delle istanze significate dai rappresentanti del mondo della scuola, certamente cercando di sentire e recepire più quello che veniva suggerito dagli insegnanti, che quello che emergeva dai fruitori della scuola. Questa è una critica che ho sentito ripetutamente negli ultimi tempi, però vorrei esprimere un'opinione che mi sta particolarmente a cuore: dando luogo a una maggiore professionalità, se è possibile, a una maggiore formazione degli insegnanti, la ricaduta avverrà sicuramente sui nostri ragazzi che riceveranno questa maggiore professionalità.
È parso agli estensori che i tempi per l'avvio dei nuovi adattamenti dovessero coincidere con l'approvazione di questa legge. Non a tutti è sembrato opportuno negare un seppur minimo rinvio di questa tempistica, che poi però, ad analisi approfondita, non avrebbe potuto incidere sulla situazione che si era creata. Non è mio compito, in questa breve esposizione, entrare nell'articolato che è già stato illustrato molto bene dal collega Guichardaz, ma vorrei ribadire che questa legge ha ottenuto degli scopi molto importanti. Il primo è quello di salvaguardare un aspetto essenziale della nostra autonomia, soprattutto in un settore vitale e fondante della società valdostana. Un secondo scopo è quello di mantenere ciò che di veramente eccellente vi è nella nostra scuola, recependo gli aspetti di miglioramento e di potenziamento dell'offerta. Penso al mantenimento attuale del reclutamento degli insegnanti, che è una delle caratteristiche fondanti di questo adattamento della 107 alla nostra scuola. Penso al potenziamento degli insegnanti, di quelli dedicati all'istruzione scientifica sia nella scuola media inferiore che nella scuola superiore, al potenziamento dell'uso dell'informatica come strumento multidisciplinare e non tanto come uso della strumentazione, con cui i ragazzi già sono particolarmente efficienti.
Il riconoscimento dell'autonomia scolastica. Abbiamo visto come abbiamo recepito quella modifica dei cinque giorni dell'insegnamento, così come l'attuazione dei piani triennali, con una maggiore organizzazione del piano formativo e la formazione del corpo docente, una formazione che è resa obbligatoria. E quest'ultimo, a mio avviso, è un punto estremamente importante. Lo dico perché anche nel mio settore professionale, da quando la formazione è diventata obbligatoria, abbiamo premiato quelli che si impegnano rispetto a coloro che invece non lo fanno: essendoci un obbligo, tutti dovranno essere formati.
L'attenzione è anche per coloro che, purtroppo, da questa riforma verranno penalizzati, individuando un sistema per poter venire loro incontro e cercare di essere riammessi rapidamente nel sistema scolastico. Non era rinviabile un'accelerazione nell'attrarre una forte implementazione dell'insegnamento della lingua inglese, che ormai tutti reputano dover essere un atout spendibile da tutti i ragazzi, non solo da quelli che hanno le famiglie più attente a questa esigenza.
Il giudizio che noi abbiamo è, dunque, sostanzialmente positivo. Certo, non è pensabile di esaurire la riforma di un sistema, così complesso e fondamentale come quello scolastico, con una sola e definitiva legge. Mutuando un po' i termini cantieristici, mi piace l'immagine del cantiere aperto e dell'avanzamento degli stati di lavoro, che siano adattabili, anche in questo caso. Quindi siamo in attesa e pronti a recepire quelli che saranno gli inevitabili miglioramenti a tale provvedimento, che nel corso del tempo sicuramente verranno trovati.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Roscio, ne ha facoltà.
Roscio (ALPE) - Dicevo tra me e me che su un tema decisamente complesso e articolato come questo, se non pensassi a tutto l'iter in Commissione, ma ascoltassi soltanto le parole dell'assessore Rini, quasi quasi voterei a favore di questa legge. Bisogna darle atto e riconoscerle una certa abilità nel raccontare e nell'argomentare. Poi, però, ho ripensato a quello che è successo, soprattutto al percorso in Commissione che ha avuto questo disegno di legge.
Si dice di un lungo percorso e di un lungo confronto, ma io vorrei ricordare che questo disegno di legge è stato scaricato dalla Giunta il 5 luglio, è arrivato in Commissione per la prima audizione il 13 luglio e oggi siamo il 28, quindi la parabola di questo provvedimento si è conclusa in quindici giorni. Prima, in Commissione non è arrivato nulla e per noi, come Commissari, il tempo in cui abbiamo potuto audire in maniera del tutto trasparente si è limitato a quindici giorni. Poi, cosa succeda nelle imperscrutabili stanze dell'assessorato o della presidenza, noi non possiamo saperlo. Io posso sapere solo quello che ho visto in prima persona. Poi, Presidente, se vuole mi racconta, così facciamo chiarezza.
Per quello che abbiamo avuto modo noi di audire, abbiamo ascoltato diversi rappresentanti del mondo della scuola, che hanno portato diversi punti di vista, chi più particolari, ma tutti, credo senza eccezione, hanno sottolineato il fatto che il metodo della concertazione loro non l'hanno visto. In alcuni comunicati stampa, uno del 15 e un altro del 26, si dice che "si stigmatizza ripetutamente il modus operandi del Governo centrale... si chiede l'esercizio della democrazia che richiede pazienza, capacità di confronto e concertazione". Queste sono parole scritte dai sindacati o dai rappresentanti dei dirigenti, quindi mi sembra che tutta questa attenzione e questo coinvolgimento per le richieste non vi sia stato.
Non c'era neanche una necessità che obbligasse ad approvare in tempi così brevi, perché anche le norme d'attuazione non recitano nulla rispetto all'approvazione del disegno di legge, mentre si limitano alla parte degli adattamenti. Quindi la fretta era immotivata e tutti hanno chiesto di avere più tempo per confrontarsi, non per procrastinare inutilmente, ma per cercare di migliorare ulteriormente una norma che comunque contiene degli aspetti positivi e che noi non siamo qua a criticare in toto. Ma l'intento degli operatori della scuola era di migliorarla ulteriormente e si sarebbe potuto tranquillamente procrastinare di pochi mesi.
Il mondo della scuola, così come ci è stato anche rappresentato dal collega Cognetta nel suo lungo excursus, è un mondo complesso, anche solo perché la fascia dei "clienti" cui deve dare le proprie attenzioni va dall'infanzia all'età adulta, quindi gli interventi devono essere fatti con estrema delicatezza e vanno condivisi il più possibile. Le pene potrebbero essere due: si rivelano dei buoni intenti condivisibili, ma poi in pratica nulla segue, oppure si assimila mal volentieri delle cose che, alla fine, ricadono in maniera negativa proprio sugli studenti, vale a dire su coloro che invece si vorrebbe aiutare maggiormente nel loro percorso. Leggendo l'articolo 1, come possiamo non essere d'accordo sugli intenti? Ormai abbiamo seguito tutta una serie di disegni di legge, per i quali sugli intenti siamo quasi sempre d'accordo, ma poi spesso non vediamo il rispetto di quegli stessi intenti.
Riflettendo sulle parole che avrei usato oggi, per cercare di spiegare a chi ci ascolta le motivazioni per cui noi non siamo d'accordo con questo disegno di legge, ho voluto sintetizzare tre filoni. Il primo è il metodo, sul quale abbiamo già detto qualcosa, il secondo sono i contenuti e il terzo sono le conseguenze. Sul metodo, l'Assessore - cito testuali parole - dice: "pur mettendoci tutto l'impegno, non riusciamo ad accontentare tutti". Forse non sarà semplice, ma per quanto ci riguarda lo scopo non era quello di accontentare tutti. In un'audizione qualcuno ha detto che si è seguito un metodo per cui si sono sentite le parti in causa in maniera separata, cercando di dare una qualcosina a tutti, tentando poi di accontentare maggiormente la parte più rappresentativa, quella che era più pesante. Dal nostro punto di vista, lo scopo era di mettere tutti contemporaneamente intorno a un tavolo, in modo che tutti portassero le loro esigenze, affinché si uscisse con una sintesi. Questo, a nostro avviso, sarebbe stato un esempio di buona politica, che invece non si è voluta seguire. Ci sembra che il metodo seguito sia stato quello del divide et impera.
Oggi siamo arrivati a una conclusione, ma il fatto di aver voluto seguire questo metodo ha innanzitutto costretto la Commissione a lavorare su dei testi del disegno di legge che venivano continuamente cambiati in corso d'opera. Questo è stato evidente, perché a ogni riunione si parlava di qualcosa, ma poi arrivava qualcuno che ci diceva che quel qualcosa non c'era più. Questo è successo per la questione dei cinque giorni, la settimana corta, per la quale in un primo momento si era introdotta con coraggio una novità importante, ma poi si è ritornati indietro. Giusto o sbagliato? È una cosa su cui ancora oggi famiglie e scuola si dividono, per cui forse questa era una motivazione ulteriore per aspettare, proprio per cercare di trovare una sintesi su quei famosi cinque giorni. Invece questo disegno di legge lascia irrisolto il problema e quindi succederà che nel mondo della scuola ognuno andrà per gli affari suoi: chi deciderà di fare la settimana corta e chi deciderà di farla lunga. Però, con tutto il problema sociale che c'è dietro - i trasporti, le altre attività, le conciliazioni con le famiglie - questo era un aspetto che, secondo noi, andava approfondito maggiormente. Così come andava approfondita maggiormente tutta la questione legata alla continuità didattica, della quale si è parlato in Commissione, in modo da cercare di trovare delle modalità per darla soprattutto ai soggetti in difficoltà, consentendo un migliore percorso. Il fatto di non cambiare annualmente i docenti, consente un miglioramento per gli studenti, ma ci è stato detto dal sovrintendente che questo andava a cozzare contro la mobilità.
Presidente, lei può fare i sui commenti, ma per quello che ho visto io qui, quando c'è la determinazione politica di andare in una certa direzione, quasi sempre la volontà prevale sull'impossibilità; invece, quando non si vuole andare in una certa direzione, diventa impossibile.
C'è tutta una parte legata al potenziamento, su cui noi torneremo dopo con i nostri emendamenti. Va benissimo che l'Assessore dica che faremo il potenziamento della scuola secondaria superiore, ma contemporaneamente dice anche che oggi noi la "buona scuola" ce l'abbiamo già, tanto che possiamo permetterci di andare a togliere dei pezzettini della scuola che già esiste, a favore dell'area di secondo grado. Questo avviene perché l'articolo 11, se non ricordo male, va a togliere delle risorse e a depotenziare di fatto la scuola media. Questo è un dato di fatto, nonostante quello che dice il relatore, perché le condizioni di questa legge, rispetto al passato, sono peggiorative. Oltretutto - forse sarebbe un motivo di rispetto nei confronti dei cittadini - su questo tema c'era una petizione sostenuta da migliaia di cittadini valdostani, che chiedeva di soffermarsi un attimo e di aspettare, mantenendo certe prerogative della scuola attuale.
La politica ha fatto altre scelte, ma dal nostro punto di vista - lo abbiamo detto in Commissione - prima di procedere con questo disegno di legge che supera e dà implicitamente una risposta a tutti coloro che avevano fatto una richiesta diversa, era doveroso anzitutto dare una risposta. Noi ci chiediamo che senso abbia andare adesso, a babbo morto, a dare una risposta a posteriori. La risposta la daremo già implicitamente oggi, domani o quando la maggioranza deciderà di votare questo disegno di legge, perché i numeri ce li avete, ma sarà un esempio di brutta politica, dal nostro punto di vista. La risposta andava data prima e solo dopo bisognava avere il coraggio di dire che, nonostante le altre richieste, voi decidevate di andare avanti, argomentando le vostre idee.
Ci sono alcune conseguenze contenute in questo disegno di legge. Come ha detto l'Assessore, noi spacchettiamo la legge 107 e la adattiamo nel modo migliore, ma il problema è che avendo lasciato irrisolte alcune questioni e non recependone altre, che erano comunque una parte importante del provvedimento nazionale, rischiamo di avere una proposta di legge non pienamente condivisa in questo Consiglio, ma soprattutto nemmeno al di fuori, quindi una legge che non ha la forza per essere valutata dal Governo nazionale, perché non è sostenuta alle spalle da un'ampia condivisione. Siccome è mal digerita dalla collettività che si occupa di educazione, rischia di fallire nei contenuti. Saranno dei buoni proclami, dei buoni intenti, ma alla fine, all'atto pratico, si rischia di vanificare, così come avevamo già espresso per gli adattamenti: se non vi è la condivisione, si possono avere tutti gli intenti buoni di questo mondo, ma all'atto pratico questa riforma si risolverà con il nulla. Questo è un rischio che noi vediamo come serio. Noi non ci siamo trovati d'accordo soprattutto con i metodi utilizzati, perché mancando la base di confronto e di ragionamento, viene meno tutto il resto.
Ci sono delle cose positive nel disegno di legge, che noi tenteremo di correggere con i nostri emendamenti di merito. La cosa che noi avremmo ritenuto più opportuno sarebbe stata quella di posticipare, per avere un confronto più ampio e per poter migliorare ancora, proprio in virtù di quella autonomia di cui spesso noi parliamo e che andrebbe portata avanti come la forza di una collettività di fronte a quello che avviene in Italia.
Noi presenteremo anche un ordine del giorno, oltre agli emendamenti, per discutere dell'ampliamento e del potenziamento in tutti i gradi di scuola.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Marquis, ne ha facoltà.
Marquis (SA) - Nella società che sta cambiando, il ruolo della scuola oggi è molto più importante di quello che aveva ieri e sicuramente domani lo sarà ancora di più, ma soprattutto per la delicatezza che ricopre, per i soggetti a cui offre dei servizi, che sono i giovani, che devono essere immessi nel mondo della vita, nel mondo produttivo, che devono crearsi un progetto di vita. La scuola plasma questi ragazzi attraverso un percorso di crescita e di formazione, non solo sotto il profilo dell'istruzione, ma anche relazionale nell'ambito della società attuale.
In questi anni c'è stata parecchia discussione, anche accesa, a livello politico sul ruolo che deve avere la scuola, sulla trasformazione che deve subire per corrispondere alle esigenze attuali della società e soprattutto per le esigenze che si ipotizza ci possano essere nei prossimi anni, quindi anche dei ragionamenti sul medio/lungo periodo. È stata parecchio sottolineata la responsabilità dell'inadeguatezza della scuola italiana, rispetto al ritardo della competitività del Paese, perché da analisi che sono state fatte è emerso che abbiamo dei tassi di laureati più bassi che in altre realtà europee e abbiamo problematiche come quelle dell'abbandono scolastico, che ci devono preoccupare. In questo ambito si sono fatte parecchie discussioni, che spesso e volentieri sono anche mosse da questioni di carattere ideologico, non solo nel merito nei contenuti, ma anche sulla forma di erogazione di questi servizi: si parla di scuola pubblica, scuola privata o di coesistenza di tutt'e due. Ci sono posizioni parecchio diverse che si sono consolidate.
Il risultato di tutte queste discussioni è stato che il Governo nazionale ha approvato la legge 107, che vuole attualizzare la scuola rispetto alle attese di modernizzazione. Come succede spesso in Italia quando qualcuno propone qualcosa, dopo cinque minuti si forma un comitato del no, al quale dopo seguirà un comitato del sì. È inevitabile che si creino delle posizioni diverse, questa è la forza della democrazia, ma credo sia anche il limite che caratterizza i problemi gestionali della politica italiana, questo eccesso di burocratizzazione, questo eccesso di compartecipazione a dei tavoli che, a volte, rischia di far perdere di vista l'obiettivo generale, perdendosi in discussioni di carattere più formale che sostanziale. L'Italia è un Paese in cui c'è parecchia resistenza al cambiamento e questo dobbiamo riconoscerlo, che non aiuta in questi casi.
A seguito dell'emanazione della 107, che è stata poi anche oggetto di quesiti referendari, nell'ambito delle prerogative riconosciute alla Valle d'Aosta - riguardo all'autonomia del settore scolastico, abbiamo competenza primaria nell'istruzione professionale e concorrente per le scuole d'infanzia, elementari e medie - è stato avviato un confronto produttivo con lo Stato, che ha portato alla norma di attuazione e ci consente oggi di recepire quelle che sono ritenute dalla maggioranza le migliori opportunità che offre la 107, quindi con un assorbimento selettivo e non totale dei contenuti in essa trattati. Sicuramente i principi sono positivi e con l'adattamento alla nostra particolarità valdostana potranno consentire alla scuola di avere degli strumenti su cui poggiare poi, nell'ambito dell'attuazione, dei percorsi che dovranno concretizzarsi, per dare dei risultati adeguati alle aspettative che ha la società valdostana. Credo che questo sia importante sottolinearlo, com'è importante ricordare che, al di là dei principi, i buoni risultati dipendono anche da come si applicano le riforme, perché queste individuano un principio, che poi deve essere assoggettato a tutta una serie di percorsi che possono valorizzare la riforma o addirittura evidenziarne dei lati negativi. Credo che la scuola valdostana abbia una grande tradizione di positività, che parte già dai primi anni del '900 con le scuole di villaggio: una grossa diffusione dell'offerta scolastica e dei servizi sul territorio, che ha portato a diffondere la cultura nella nostra realtà territoriale, non facile da gestire. Nel processo di adattamento occorre anche tener conto delle nostre peculiarità geografiche e territoriali, con le quali bisogna mediare per riuscire a garantire dei servizi che possano essere dati e che sono richiesti in funzione della prossimità territoriale.
Una scuola che deve essere il più possibile inclusiva, dare risposte a coloro che presentano maggiore fragilità e credo che anche sotto questo profilo qualcosa sia stato fatto, chiaramente nei limiti delle difficoltà che derivano dalla legislazione nazionale, perché ci sono delle situazioni che allo stato attuale sono oggettivamente insufficienti. Qui mi riferisco al discorso della continuità didattica, soprattutto per ciò che concerne gli insegnanti di sostegno. Lo stato giuridico che è previsto dalla normativa italiana non consente di dare questa continuità. Io auspico che nel percorso che dovrà essere individuato da qui in avanti - la regionalizzazione del corpo docente potrebbe essere un'ipotesi - si possa riuscire a dare delle risposte positive a queste esigenze. Nel frattempo credo che tutto si possa giocare sul discorso della formazione, perché i grandi processi di adattamento alle esigenze di una società che cambia impongono anche l'adeguamento dell'offerta formativa. L'offerta passa attraverso la somministrazione di un servizio da parte del corpo docente, quindi credo che vadano portati avanti dei programmi e dei progetti di formazione, che possano corrispondere alle esigenze del mondo attuale. Andare nella direzione dell'alfabetizzazione plurilingue credo sia una grande opportunità da seguire oggi, perché sempre più sono le relazioni a livello globale che sono richieste per chi si approccia al mondo del lavoro, così come sono richieste le formazioni di carattere scientifico e la transizione all'economia digitale: sono tutte problematiche che una volta non esistevano e a cui oggi occorre dare delle risposte.
Credo che i principi introdotti nella riforma che viene oggi all'esame del Consiglio siano buoni, però bisognerà vedere come evolverà questo cantiere, per poter garantire i risultati che ci attendiamo. Credo sia un percorso che si possa portare avanti con serenità, con il confronto, così com'è stato fatto finora, con tutti i portatori di interesse. Io ho partecipato nell'ambito della Commissione e devo dire che abbiamo potuto audire anche posizioni diverse, che però, come in ogni cosa, riferiscono chiaramente a delle visioni di tipo ideologico. Questa è la proposta condivisa dalla maggioranza che è stata portata all'attenzione dell'Aula e credo che bisogna attivarsi per dare corpo ai contenuti e cercare di portarli a termine nel migliore modo possibile, nell'interesse dei ragazzi e della comunità valdostana.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz (PD-SIN.VDA) - Ho ascoltato con attenzione, in particolare il bell'intervento del collega Cognetta, il quale - devo dire - è uno dei pochi capace di fare ostruzionismo dicendo comunque delle cose interessanti. Io, di questo, devo rendergliene merito e glielo devo riconoscere, perché questo refresh sulla storia della scuola in Italia, dal Medioevo fino a oggi, è comunque utile per contestualizzare ciò che stiamo facendo. Quindi la ringrazio e sorvolo sull'analisi storica, che credo potrebbe anche avere ulteriori approfondimenti. Poi, magari, ci possiamo anche ritrovare per fare qualche seminario o qualche articolato ragionamento sulle questioni storiche e sugli effetti delle riforme negli anni, perché la storia è utile se serve a capire dove siamo e chi siamo.
Sulle considerazioni a margine che il collega Cognetta ha fatto sul prima e sul dopo, che hanno fatto anche gli altri colleghi che sono intervenuti, qualcosa mi sento di dirla. Può darsi che siano stati serrati, però è vero che i tempi del confronto sono sempre insufficienti per definizione. Se non si dessero dei limiti al confronto, le leggi non si potrebbero fare. Quindi il legislatore, che è colui che ha la responsabilità politica, che paga anche per le decisioni che assume e per le modalità con cui lo fa, è colui che a un certo momento decide di dare dei termini. Se noi facessimo per ogni legge degli infiniti dibattiti, probabilmente ci arrotoleremmo nel dibattito stesso e, alla fine, non si concluderebbe l'iter di effettuazione di una legge. Il collega Cognetta, comunque, è persona ragionevole e queste cose le sa benissimo.
Bisogna però dire che non è così vero che non è stato fatto un dibattito sul tema della riforma e delle riforme. Io arrivo da una famiglia di insegnanti, mia moglie è insegnante e ha fatto la tesi di laurea sulle riforme che si sono succedute negli anni. Quello sulle riforme è un dibattito permanente e la formazione continua degli insegnanti è quella sulle riforme. A proposito della cosiddetta "buona scuola", premetto che io ho pure manifestato contro alcuni suoi eccessi e sono sceso in piazza contro il famoso "dirigente sceriffo". Non ho nessun problema a dire che io ero totalmente in disaccordo rispetto a una decisione imperativa, che sovvertiva completamente l'idea dell'autonomia didattica, della capacità del singolo docente di essere, anche lui, attore dell'offerta formativa. Sulla "buona scuola" è stato fatto un grande dibattito a livello nazionale, è stato aperto il cosiddetto "cantiere", sono state raccolte centinaia di migliaia di suggerimenti, si è cambiata la versione in maniera consistente. La 107 oggi è una legge che ad alcuni può piacere, ma a me non ha mai appassionato in maniera così forte, tant'è che nel nostro lavoro e nella nostra riflessione circa il recepimento di questa normativa, molte cose sono state non disattese, ma non sono state accolte, o sono state adeguate alla realtà regionale, proprio perché ritenevamo che il nostro collaudato modello valdostano fosse comunque da preservare.
Noi siamo partiti da subito con l'idea che il nostro modello presenta dei margini di miglioramento, ma che negli anni ha soddisfatto le aspettative, credo, della classe docente e dei dirigenti. Capisco i dirigenti che oggi, magari, rispetto a un lavoro che alcuni di loro hanno fatto nelle commissioni, possano dire che non c'è stato coraggio, che non c'è stata condivisione. Io ricordo che il presidente dei dirigenti ha steso l'articolato e non può dire che sul tema non ci sia stata una condivisione, sebbene sia la stessa persona che è venuta a rappresentare i dirigenti in Commissione, parlando di mancanza di condivisione: è una persona che ha lavorato dei mesi su un articolato. Poi, capisco che siccome gli abbiamo smontato l'articolato - rispetto a delle aspettative legittime dei dirigenti, abbiamo fatto non delle marce indietro, ma abbiamo assunto delle decisioni di carattere politico - posso capire che ci sia un disaccordo. Però, non si può dire che su queste tematiche non ci sia stata una riflessione, né sul livello nazionale, né su quello che qua da noi è stata battezzata la "nostra scuola".
Accolgo simpaticamente il suggerimento del collega Cognetta. A mio parere può andare bene anche la "scuola di tutti" e non mi sento di dire che questa è la nostra riforma. Con tutti i difetti che può avere questa riforma, lo spirito con cui noi abbiamo operato nel lavoro in Commissione e nelle sedi politiche, è quello non di fare la riforma Rini o di metterci un cappello, ma di creare un cambiamento che, con tutte le fragilità umane di valutazione che possiamo avere, sia una riforma che di sicuro non è rivolta all'autosoddisfazione. Come sappiamo, tutte le riforme della scuola generalmente sono la tomba di chi ci si avventura. Quindi l'esigenza di fare una riforma partecipata di sicuro non l'abbiamo assunta con quell'idea, un po' masochistica, che avventurarsi nella palude delle riforme sia la cosa migliore da fare politicamente. Era necessario farla, perché a livello nazionale vi è una riforma - criticata, non criticata; l'ho criticata anch'io - che incombe e che è la legge 107. Esiste un impegno politico che noi abbiamo assunto con il ministro Giannini un anno fa, che dà ampio spazio al legislatore regionale, ma se voi leggete il contenuto di quell'impegno politico, vedrete che era molto più limitativo rispetto alla riforma che abbiamo poi confezionato. C'è un impegno politico forte, che esiste anche sugli adattamenti, che non sono cose svincolate, perché è comodo dire che ci devono essere tavoli diversi, tranne poi richiamare alla sintesi. Quando si parla di scuola, la riforma deve essere il più possibile omnicomprensiva. Il nostro sforzo era quello di cercare di fare un testo unitario, che contenesse anche il riferimento agli adattamenti, che nella norma statutaria hanno, come limite, l'inizio del nuovo anno scolastico, cioè il primo di settembre.
Riguardo poi alla concertazione e alla condivisione in sede locale, se ne parla da molto tempo. Abbiamo assistito ai dibattiti, io ho fatto le manifestazioni contro la "buona scuola" e non mi ricordo se ho pure firmato per il referendum contro i dirigenti, perché noi consiglieri regionali siamo anche cittadini, quindi siamo liberi di ragionare, svincolati anche da discipline che, a volte, possono dare fastidio. Abbiamo fatto assemblee, assistito ai dibattiti di chi rappresenta il mondo della scuola, anche di chi rappresenta delle istanze particolaristiche. Il comitato "SOS école", per esempio, è un'aggregazione che rappresenta la scuola media. Noi abbiamo sentito i sindacati, che rappresentano le istanze più ampie e che oggi - può piacere o no - sono coloro che rappresentano le maestranze, i lavoratori e che, in qualche modo, si pongono come legittimi rappresentanti, ma abbiamo sentito anche i comitati, abbiamo sentito anche i logopedisti, gli operatori che lavorano tutti i giorni e i genitori che rappresentano le associazioni che si spendono tutti i giorni per risolvere le fragilità di apprendimento.
È vero, ci si poteva, probabilmente, confrontare di più, però, per quello che posso dire io, il percorso che è stato fatto ha dato degli elementi, a mio parere, sufficienti per elaborare una buona legge e che - lo dico qui - è una legge condivisa. È una legge che ha raccolto moltissimi suggerimenti, tant'è che le ultime considerazioni di alcune sigle sindacali si sono soffermate più sul metodo che sul merito e sui contenuti. Io ho fatto il sindacalista per quindici anni e so benissimo che anche il metodo è importante, anche la condivisione e la concertazione, ma so altrettanto bene che si arriva a un certo punto in cui bisogna fare sintesi e anche le organizzazioni sindacali, anche chi rappresenta le istanze, a un certo punto sa che deve fare sintesi. Poi, fa parte del ruolo, fa parte del gioco delle parti il richiamare una maggior condivisione.
Il collega Roscio parla di mancanza di metodo e di concertazione: non l'ha detto esplicitamente, ma penso che intendesse una sorta di stati generali della scuola, o qualcosa che mettesse intorno a un tavolo tutte le istanze. Potrebbe essere un percorso sicuramente utile, anche per il prosieguo. Io, però, nella mia vita precedente di sindacalista, ho partecipato a parecchi stati generali: cito solo la conferenza socio-sanitaria, il patto per lo sviluppo e altri contesti in cui ci si confrontava e che, purtroppo, sono miseramente affondati, perché la sintesi non è mai riuscita ad arrivare a termine. Io sono il primo a dire che dobbiamo organizzare dei tavoli, dei contesti di discussione, ma rispetto a certe tematiche, come sono quelle dell'elaborazione e del recepimento di una legge, i tavoli, le conferenze, gli stati generali, eccetera, rischiano di creare degli stop, per cui qualcuno, a un certo punto, interrompe e dice: basta, adesso interveniamo noi. Questo è un richiamo chiaro che voglio fare.
La Provincia autonoma di Bolzano, in maniera molto simile alla nostra legge, ha salvaguardato molte prerogative; la Provincia di Trento ha recepito quasi integralmente la legge nazionale, con i sollevamenti - lì sì - da parte della classe docente. Oggi noi non vediamo i docenti qui in Aula, non perché sono in vacanza, ma perché evidentemente anche loro hanno capito che questa riforma va nella direzione di cercare di raccogliere i suggerimenti e le istanze soprattutto della classe docente. Noi siamo arrivati per ultimi rispetto alle Regioni alle quali facciamo riferimento, con una legge che però è originale; è una legge che io sono convinto, così come altre che abbiamo fatto in quest'Aula, verrà presa a riferimento. Sarà oggetto di discussione e io sono convinto che anche al Ministero, probabilmente, analizzeranno la legge e i discostamenti rispetto a certi intendimenti e a certe idee che avevano.
Il collega Marquis dice che è una legge che manca di coraggio in alcune cose, così come i dirigenti parlano di mancanza di coraggio. A mio parere, invece, è una legge coraggiosa, proprio perché intende affermare una nostra peculiarità: il modello valdostano. Io ritengo che questa sia una legge coraggiosa e non è una legge di sfida, perché comunque raccoglie alcune migliorie indubitabili della legge nazionale. Si danno per scontati i 500 euro di bonus per l'autoformazione, ma non era così scontato. Non è così scontato prendere il bello delle cose e assumersi la responsabilità di lasciare ciò che non ci piace. Noi, con questa legge, con tutte le imperfezioni che ci possono essere dietro a delle decisioni umane, abbiamo cercato di cogliere gli aspetti positivi. E non sono solo i 500 euro annuali di bonus, che comunque comportano un'idea di investimento permanente nella scuola; abbiamo accolto anche l'idea della formazione continua a permanente, che non era così scontata. Fino ad ora, la formazione, ormai da qualche anno, era facoltativa e non dico che venisse scoraggiata, ma sicuramente non veniva incoraggiata in questa maniera. Qua noi mettiamo dei gran soldi sul percorso di formazione. Poi, su come viene fatta la formazione, abbiamo anche modificato la legge, accogliendo i giusti suggerimenti, per esempio, della collega Certan, relativamente al fatto che in Valle d'Aosta esistono degli enti che possono dare formazione, essendo più vicini al territorio e alle nostre esigenze, come gli enti accreditati direttamente dalla Regione; è stata introdotta la possibilità di fare formazione linguistica all'estero. Abbiamo raccolto delle istanze e delle richieste che ci sono state fatte, che noi pensiamo di aver riportato su carta.
È un testo criticabile: va bene. Si poteva fare di più: va bene. Tenete conto che in un momento di restrizione economica, in cui si tende a ridurre trasversalmente i finanziamenti su tutti gli ambiti, si è voluto dare un segnale in questo senso, probabilmente privando risorse ad altri ambiti, ma si è voluto dare il segnale addirittura di potenziare l'aspetto economico del finanziamento sulla scuola, proprio nell'idea di investire per il futuro. Può essere un'ingenuità, può essere tutto quello che vogliamo, ma non mi pare che ci sia stata, da parte della politica, una disattenzione. Potevamo, tout court, recepire la 107 e dire che era colpa di Renzi, che era colpa del Governo nazionale. Non l'abbiamo fatto. Abbiamo deciso di metterci in gioco anche noi che facciamo riferimento al partito nazionale, di "sfidare" con delle motivazioni e portando comunque degli argomenti.
Io voglio dire una cosa che spesso ricorda il collega Donzel. La Valle d'Aosta ha una realtà di copertura di organici straordinaria: è una realtà sulla quale noi non abbiamo inciso in nessuna maniera. Al dì là dell'ora di educazione tecnica, si sono mantenuti dodici posti per l'integrazione degli alunni stranieri, nella convinzione non solo che l'alunno straniero va comunque accolto e inserito, ma nella consapevolezza che quando si hanno delle persone che hanno delle difficoltà linguistiche, è tutta la classe che rischia di rimanere indietro. Si è deciso di mantenere questo finanziamento: 400 mila euro. Si è deciso, attraverso un ordine del giorno, di aprire un percorso sul sostegno, dimostrando con ciò l'attenzione che si ha per le persone più fragili. Credo che nessuna regione d'Italia abbia un numero di insegnanti di sostegno per bambino come la Valle d'Aosta, di educatori di supporto.
Esiste un'attenzione da parte della politica. Poi, capisco, collega Cognetta, il gioco delle parti e l'ostruzionismo, capisco che ci siano dei discorsi che possono essere portati avanti, perché ho fatto opposizione anch'io. Non voglio definirla una riforma, perché è una legge di recepimento di alcune situazioni ed è la conferma di altre situazioni. Noi con questa legge non abbiamo riformato tanto, abbiamo riformato in meglio ciò che noi, come legislatori, abbiamo ritenuto valesse la pena di riformare, ma mantenendo un modello, al quale abbiamo aggiunto qualcosa, con l'ambizione di creare una scuola digitale e una scuola plurilingue. Poi, può essere discusso anche questo - io non me ne intendo di metodi CLIL e non capisco nulla di informatica - ma il nostro spirito è di modernizzare la scuola, mantenendo però un modello che non ho mai sentito criticare, né da un insegnante né da un dirigente.
Vengo da una famiglia di insegnanti e non ho mai sentito una critica rispetto al sistema del reclutamento. Io ho due figlie, una va a scuola cinque giorni alla settimana e l'altra sei, pur essendo nella stessa istituzione. Sarebbe comodo averle il sabato e la domenica a casa e probabilmente il ragionamento iniziale era più rivolto alle esigenze dei genitori. Noi, invece, abbiamo sentito le organizzazioni sindacali e non ce n'è una che non abbia espresso delle critiche; questo anche per dire che le organizzazioni sindacali non sono solo lì a difendere i lavoratori. Con le organizzazioni che noi abbiamo sentito - lo devo dire, perché arrivo dall'ambito sindacale della funzione pubblica, il quale era molto confederale ed era sensibile anche alle esigenze degli utenti - c'è stato un confronto che non è stato di tipo difensivo. Non si è voluto difendere a tutti i costi e le critiche, che sono venute da altri ambiti, dalle organizzazioni sindacali non sono arrivate. C'è stata una totale comprensione delle motivazioni e dell'obiettivo di questa legge.
Il mantenimento del sistema delle sostituzioni. Noi abbiamo mantenuto un sistema che era stato completamente smantellato dalla legge 107. Lo abbiamo mantenuto nella stessa scuola, nello stesso Comune. Andate a guardarvi la 107: se avessimo accettato di recepirla tout court, sarebbe stato un sistema di sostituzioni nell'ambito, addirittura, di scuole di diverso grado. Io sono convinto che un tale sistema di sostituzione, che io ho contestato nella "buona scuola", non sarebbe andato a beneficio nemmeno degli studenti! Perché la possibilità di sostituire sull'intero territorio d'ambito, cioè sulla stessa regione, e di mobilitare gli insegnanti, non crea solo demotivazione e incertezza nella classe insegnante, ma crea instabilità anche negli studenti, e questo va detto.
Così come non abbiamo accettato il rischio di una scuola classista, dove i docenti scelgono dove andare - è l'incrocio dell'offerta con la domanda - e i dirigenti li accolgono. Ma chi accolgono i dirigenti, secondo voi? Pensate che i dirigenti dei licei non facciano dei ragionamenti del tipo: io mi prendo gli insegnanti, magari più bravi, più preparati e con maggiore esperienza? E poi, chi rimane dietro, dove va a finire? Va a finire in quelle scuole dove generalmente gli insegnanti non chiedono di andare a lavorare? Non è un sistema classista questo?
Noi abbiamo fatto un ragionamento: riteniamo che tutti gli ordini di scuola, tutte le istituzioni, quelle professionali e liceali, debbano avere la stessa qualità. Poi, hanno approcci diversi e nessuno dice il contrario, ma la qualità deve essere uguale. La dignità che si dà alla formazione professionale, al liceo o ad altri gradi di scuola, deve essere la stessa. Noi siamo andati in quella direzione e ragionando in quella direzione abbiamo fatto il nostro articolo di legge, che presuppone il mantenimento di quel tipo di reclutamento: sarà imperfetto, però è garanzia di una scuola egualitaria, una scuola che va nella direzione di favorire tutti nello stesso modo.
Concludo sulla questione degli adattamenti. È stato criticato anche il lavoro che ha fatto la Commissione sugli adattamenti e anch'io l'ho criticato. Io ringrazio chi ha lavorato su questo e chi ha lavorato sul precedente articolato, perché vi assicuro che è stato fatto un lavoro magistrale su questa tematica e nessuno ha perso del tempo. Però noi abbiamo ritenuto che andasse salvaguardato il principio della gradualità, perché la classe docente ha manifestato il disagio di intraprendere un percorso, che potrebbe essere immaginato di cambiamento radicale rispetto all'insegnamento, per esempio, delle lingue straniere, soprattutto dell'inglese. Anche qua, abbiamo raccolto le giuste sollecitazioni e ci siamo messi intorno a un tavolo con tutti i colleghi; non è che l'ha fatto la maggioranza questo lavoro. Ci siamo confrontati con i docenti e ci siamo resi conto - credo che tutti se ne rendano conto nella classe docente, ma anche nella comunità educante più complessiva - che l'apprendimento della lingua è un arricchimento, ma non deve essere un apprendimento svogliato. Prima di tutto devono essere convinti i docenti, devono essere preparati, non devono andare lì, come diceva qualcuno in audizione, con il patema di essere superati dagli studenti, di insegnare delle cose perché le si deve insegnare. Noi abbiamo recepito gli adattamenti, però con gradualità, con un'apertura anche di tipo volontaristico (il potenziamento della lingua inglese, il potenziamento attraverso i percorsi di autoformazione), nella convinzione che nel giro di qualche anno - gli anni che ci vorranno - arriveremo a una scuola valdostana moderna, di cui saremo orgogliosi. A me fa piacere di avere il privilegio oggi di essere qua nel mio ruolo di legislatore e di aver partecipato non a una riforma, ma a una svolta positiva a favore non di PD, Union Valdôtaine, Stella Alpina, Movimento Cinque Stelle e altri, ma a favore della nostra regione. Se noi non siamo in grado - e questo vale anche per altri argomenti - di proporre un modello originale nella scuola, nella formazione, nell'approccio al lavoro e in tutti gli altri ambiti di cui ci occupiamo, noi rischiamo di affondare, perché siamo piccoli. Se si è piccoli, o si creano delle novità, si creano dei prodotti di nicchia, com'è la nostra scuola, o siamo destinati a essere inglobati, a essere fagocitati. Mi piacerebbe che non avvenisse questa cosa.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Cognetta per il secondo intervento, ne ha facoltà.
Cognetta (M5S) - Alla luce dell'ultimo intervento del collega Guichardaz vorrei fare qualche chiarimento generale, così ci capiamo sul perché vengono fatte certe scelte e sul perché si decide di fare un certo tipo di azione politica in quest'Aula.
Io non difendo nessuna posizione preconcetta di nessuno, né dei sindacati, né del comitato "SOS école", né di tutti quelli che sono venuti all'interno della Commissione o ne sono rimasti fuori. Di conseguenza, in questo momento, non sto facendo una presa di posizione a favore o contro determinate scelte prese in questo disegno di legge. La mia è un'azione contro l'Assessore che ci ha portato una legge nel giro di quindici giorni, pur avendo detto in precedenza che ci sarebbe stato tutto il tempo per discutere.
Lei, collega Guichardaz, fa parte di una maggioranza cospicua: siete in ventisette in questo momento. Io faccio parte di un'opposizione un po' meno cospicua, perché siamo in otto. Però, trovo molto fastidioso che si dica in Aula prima una cosa e poi se ne faccia un'altra. È una cosa che non riesco ad accettare. Capisco che in politica si può fare tutto e il contrario di tutto e la politica è l'arte di giustificare qualunque cosa, ma a me non interessa. A me interessa che quando si dice che c'è il tempo per fare un certo tipo di lavoro, poi lo si lasci quel tempo, non che si faccia finta di lasciarlo.
Lei ha cercato di difendere ciò che è stato fatto, portando un punto di vista interno al provvedimento. Io non sto facendo questo per ciò che è scritto. In parte mi va anche bene. Non mi va bene come si è comportato l'assessore Rini con me. Poi, degli altri non lo so, ma con me, di sicuro, non si è comportato in maniera corretta, perché prima ha detto che avrebbe fatto una certa cosa e poi ne ha fatta un'altra. E questo non mi va bene. Io ho pochi strumenti legislativi a disposizione, uno di questi è presentare emendamenti. Ahimè, se voi ne conoscete altri, per fare in modo di far emergere tutta la mia contrarietà a questo modo di agire, me li dite e io li applicherò molto volentieri. Io ho trovato questo. Mi consenta anche questa possibilità. È prevista dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, che non ho scritto io e quando sono arrivato era già così. Io lo sto semplicemente mettendo in atto. In maniera un po' drastica? Sicuramente. In maniera assolutamente inutile? Probabilmente. Però, c'è qualcosa che deve capire il Governo e l'assessore Rini: che è giusto porre un termine a un dibattito, è giustissimo, ma questo dibattito è durato quindici giorni. Fa ridere come tempo.
Vogliamo parlare della proposta di legge 72, che ha girato in Commissione un anno e mezzo? Ne vogliamo parlare o lasciamo stare? Vogliamo parlare della legge sull'agibilità, che è arrivata in Commissione e poi in quella sede si è deciso di rimandarla per approfondimenti? Nulla da dire. Abbiamo fatto le audizioni, abbiamo visto che c'erano degli approfondimenti da fare e, giustamente, il Governo ha rimandato. Quello che ho chiesto nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di ieri era di trasferire questo provvedimento al primo Consiglio di settembre. Non ho detto sine die, non ho detto di fare una commissione delle commissioni e poi vediamo quando parlarne. Io ho detto semplicemente di spostarlo al primo Consiglio di settembre. Non ho chiesto la luna. Non ho messo in campo chissà quale ragionamento per dire che non si doveva fare questa cosa. Assolutamente no.
Consigliere Guichardaz, lei cerca di difendere il contenuto e ha cercato anche di difendere l'operato della Rini, perché ha detto delle parole, rispetto all'operato dell'Assessore, che sono condivisibili. Ha detto che probabilmente se ci fosse stato un minimo di concertazione in più, non sarebbe stato male. Io le ho sentite dire da lei queste parole, ma non dall'Assessore. Se l'Assessore prende atto del fatto che ha commesso un errore e che ha gestito questa cosa come un blitz, forse potremmo cominciare ad aprire un altro tipo di ragionamento, altrimenti stiamo qua finché le gambe, la gola e la voglia ci sorregge. Sarò anche l'ultimo dei consiglieri dell'ultimo partito di opposizione, però, purtroppo per voi, sono Consigliere anch'io. Quando questo modo di operare non vi piacerà, cambierete il regolamento: c'è una commissione fatta apposta. Sarei curioso di vedere cosa metterete: un limite agli emendamenti? un limite agli ordini del giorno? Dovrete valutare bene, perché adesso state in maggioranza, poi magari chissà, quindi io ci penserei bene prima di fare certe scelte.
Ripeto che io non sto difendendo nessuno. Sto difendendo semplicemente il mio ruolo di Consigliere e il fatto che volevo esprimere un ragionamento più approfondito su questo disegno di legge, nei tempi che ci si era dati, cioè dicendo che non c'era fretta. Poi, che l'abbiano detto anche i sindacati, che l'abbiano detto anche gli altri, mi aiuta a dire. Ma è questo che è mancato, consigliere Guichardaz. E non sono soltanto io che lamento questa cosa, lo hanno fatto anche altri. Questo che è un aggiustamento di quella che è la legge nazionale, va approfondita in maniera molto più specifica di quanto è stato fatto fino a questo momento. Perché quando uno si pone in testa di risolvere le cose in fretta e furia, commette degli errori.
Sulla questione dei cinque giorni, poi tornati a sei, il giorno prima ho visto una Commissione nella quale sembrava che avessimo risolto il problema dei trasporti, limitandoci a cinque giorni e il giorno dopo si è tornati a sei. Mi è venuto un dubbio in testa su come sia stato possibile, ma poi ho capito. Si sono scritte delle cose pensando solo a una parte e poi, giustamente, si è visto che c'erano delle controindicazioni rispetto a quanto scritto e si è fatta anche l'altra. È giusto. Ma allora, sa di quante altre cose potremmo parlare qui dentro? E soprattutto, che cosa cambia farlo a settembre? Sinceramente, che cosa cambia? L'abbiamo già detto: non c'è nessuno che ci corre dietro, non è obbligatorio.
Io mi rendo conto che questo modo di operare svilisce il ruolo del consigliere regionale e probabilmente è controproducente, ma non mi interessa, perché a me interessa essere rispettato e questo lo metto sopra qualunque cosa. Non mi importa ciò che dicono gli altri e ciò che viene detto fuori. Io sono qui, ho un ruolo, cerco di svolgerlo nel massimo rispetto di tutti (non lo faccio sempre, perché ogni tanto magari mi girano anche a me e chiedo scusa per quando succede), però un'operazione preordinata e programmata, fatta in questa maniera, non è simpatica, per non dire altro. E questo non mi va giù.
Io mi sto rivolgendo a lei, perché lei si è rivolto a me, quindi le parlo come assessore in pectore, questa volta dell'istruzione e non della sanità, però cerco di parlare a lei per far capire a qualcun altro. Il focus del discorso, per me, è questo. Adesso ne parleremo per i prossimi giorni e così vediamo se viene capito. Perché questa è semplicemente una riga: uno fa una cosa, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci e poi, a un certo punto, tira una riga e dice che da quel punto in poi non si va. Dopo tre anni posso dire che da questo punto in poi non si va, secondo me. Posso, dopo tre anni? Vorrei che questo Governo non si comportasse più in questa maniera, che le cose fossero condivise, che le cose fossero realmente rispettate quando si prende un certo tipo di strada e che fosse capita la posizione di tutti. Questo vorrei che si capisse.
È chiaro che il muro contro muro non fa capire questo, però non posso neanche subire sempre in silenzio, o facendo gli interventi da cinque minuti, cercando di sopperire con la capacità oratoria, o con la presa in giro. Non va bene sempre. Adesso, invece, metto in campo il regolamento. Il regolamento dice questo e io faccio questo. Che gli emendamenti non siano scritti in maniera corretta, non mi può interessare di meno. Sono stati accettati e questo è l'importante. Purtroppo, si guarda la forma e non la sostanza. È un'altra regola che non ho fatto io. Ci è voluto del lavoro per farlo, non è stato così semplice. Ci vuole comunque del lavoro, essendo anche da solo e non avendo dipendenti o altre persone. Ho la fortuna di essere un informatico e questo sicuramente mi ha agevolato molto: sul mio lavoro sono discretamente capace. Però, è un messaggio quello che sto mandando e non lo devono capire in tanti, lo deve capire solo chi sta seduto lì, e basta. A tutti gli altri questo messaggio interessa relativamente. Non so se sono stato chiaro rispetto alla posizione e rispetto a come cerco di portare avanti il mio lavoro in quest'Aula.
Presidente - Ha chiesto la parola la consigliera Certan. Le ricordo che lei ha già usufruito dei due interventi.
Certan (ALPE) - Non ho usufruito di tutto il tempo. Non c'è problema, farò una dichiarazione di voto.
Presidente - Sì, ha fatto i due interventi, unendo il secondo intervento al primo. L'ha dichiarato lei, non lo dico io.
Certan (ALPE) - No, non ho fatto il secondo intervento, ho preso dei minuti alla fine del primo, come molti altri. Ma non fa niente, Presidente, non si preoccupi. Ci sarà la dichiarazione di voto.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Marquis, ne ha facoltà.
Marquis (SA) - Chiederei una sospensione per una riunione di maggioranza.
Presidente - Sospensione consentita.
La seduta è sospesa alle ore 12:40 e riprende alle ore 12:58.
Presidente - Cari colleghi, vista l'ora, credo che possiamo sospendere i lavori mattutini. Riprenderemo alle ore 15:30.
La seduta termina alle ore 12:59.