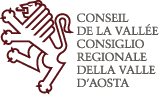Oggetto del Consiglio n. 1807 del 24 gennaio 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1807/XI Approvazione definitiva del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99. (Approvazione di ordine del giorno)
Deliberazione Il Consiglio
Richiamati:
- il regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);
- il regolamento CE n. 1750/99 modificato dal regolamento CE n. 2075/2000 recanti disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99;
- il regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il regolamento CE n. 2603/99 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio nel quale si stabilisce che il termine a decorrere dal quale le spese sono ammissibili è il 1° gennaio 2000 ovvero la data di presentazione alla Commissione se il piano è stato presentato dopo il 1° gennaio 2000, ossia il 3 gennaio 2000 per il Piano della Regione Valle d’Aosta;
- la legge nazionale n. 183/87 - art. 5 - che istituisce un fondo di rotazione per favorire l’accesso ai fondi strutturali europei;
- la Decisione della Commissione Europea 1999/659/CE dell’8 settembre 1999 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;
- la deliberazione del CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999 recante ripartizione indicativa per Regioni e Province autonome degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per l’attuazione dei Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99 nella fase di programmazione 2000-2006;
Richiamata in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 4958 del 30 dicembre 1999 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257 e 1750 del 1999 e del suo inoltro ai competenti organi comunitari e statali" ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1137/XI del 9 febbraio 2000;
Considerato che il predetto Piano è stato oggetto di trattative con l'Unione Europea;
Considerato altresì che con la Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2903 def del 29 settembre 2000, notificata alla repubblica italiana in pari data, è stato approvato definitivamente il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della regione Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006, per quanto riguarda la parte generale del Piano e le misure cofinanziate dall’UE e dallo Stato italiano ad eccezione dell’azione III.3.3 "Tutela del patrimonio bovino valdostano", nell’ambito della misura III.3, Misure agroambientali, visto che tale azione non soddisfa al momento le condizioni di cui al punto 9 dell’allegato al regolamento CE n. 1750/99, poiché sono ancora in fase di definizione da parte della Commissione Europea i criteri di dimostrazione del pericolo di estinzione degli animali domestici;
Vista la necessità, pertanto, di riapprovare il Piano di sviluppo rurale secondo le modifiche dettate e/o concordate con l'Unione Europea;
Constatato che il Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta prevede interventi in ambito agricolo, forestale e rurale per una spesa complessiva per il periodo di programmazione 2000-2006 stimata in 623.164.171 euro di cui 509.237.193 euro a valere su risorse pubbliche cofinanziate dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
Richiamato l’articolo 41 del regolamento CE n. 1260/99 il quale stabilisce che i Piani devono essere accompagnati da una valutazione ex ante che è parte integrante dei Piani stessi;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 20 settembre 1999 con la quale si affidava l’incarico della valutazione ex ante del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta all’INEA e che tale valutazione è stata consegnata ai competenti uffici;
Considerato altresì che le misure del Piano configuratesi come "Aiuti di Stato" sono state notificate secondo la procedura prevista per tali aiuti con nota del 28 giugno 2000 e successive integrazioni dell’11 agosto 2000, 28 agosto 2000 e 26 ottobre 2000 e che tale parte del Piano è quindi soggetta ad una distinta Decisione della Commissione Europea già informalmente assunta;
Vista l’urgenza di approvare immediatamente il Piano in attesa della formale acquisizione della predetta decisione, in quanto è indispensabile stabilire le relative modalità attuative e le procedure affinché lo stesso possa essere applicabile integralmente a partire dall’anno 2001, come previsto quale durata della programmazione, fermo restando che tali aiuti saranno comunque operativi solamente nel momento in cui verrà acquisita formalmente la Decisione citata della Commissione Europea che ne autorizza l'applicazione;
Considerato che con l’approvazione del Piano di sviluppo rurale da parte dell’Unione Europea le spese relative alle misure cofinanziate sono eligibili a partire dalla data di ricevimento del Piano da parte dell’Unione Europea stessa, vale a dire dal 3 gennaio 2000, e che è opportuno stabilire l’eligibilità delle spese relative agli Aiuti di stato a partire dalla stessa data degli aiuti co-finanziati;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 13 gennaio 2000 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per l’anno 2000/2002, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Agricoltura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare il testo definitivo del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 e la relativa valutazione ex ante, allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante;
2) di rendere operative le misure relative agli "Aiuti di Stato" ad avvenuta acquisizione formale della Decisione della Commissione Europea che li autorizza;
3) di rendere operativa la misura dell’azione III.3.3 "Tutela del patrimonio bovino valdostano", ad avvenuta definizione dei criteri di valutazione del pericolo di estinzione degli animali domestici da parte della Commissione Europea;
4) di stabilire il 3 gennaio 2000 quale data di eligibilità delle spese relative all’intero Piano di sviluppo rurale;
5) di autorizzare la Giunta regionale ad adottare con propri atti le disposizioni attuative delle singole misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;
6) di stabilire che alle domande di aiuto già presentate e giacenti possono essere applicati gli aiuti, ai sensi delle norme finora in vigore oppure ai sensi del presente Piano di sviluppo rurale, qualora ne ricorrano le condizioni e come stabilito in modo più particolareggiato nelle singole disposizioni applicative settoriali.
Allegati
(Omissis)
Président Ce plan a reçu l’avis favorable à la majorité de la IIIème Commission du Conseil.
La parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Le plan de développement rural du Val d’Aoste, approuvé par le Gouvernement régional le 30 décembre 1999, a été immédiatement envoyé au Ministère des politiques agricoles et forestières chargé des rapports officiels avec l’Union européenne. L’acte de notification porte en effet la date du 30 décembre 1999. La Commission européenne en a accusé la réception par lettre du 20 janvier 2000.
Le plan a été ratifié par le Conseil régional le 9 février 2000 et a fait l’objet de deux analyses bien distinctes. L’une référée aux mesures financées en partie ou totalement par l’Union européenne, c’est-à-dire l’aide aux jeunes, le premier démarrage, et à la préretraite, l’indemnité compensatoire, les primes agroenvironnementales et la valorisation de la filière du bois.
L’approbation de cette première partie a eu lieu le 29 septembre 2000 par la décision de la Commission européenne n° 2.903. Je donne lecture de quelques chiffres se référant à ces mesures en particulier, dont la mesure pour les jeunes agriculteurs qui prévoit pour un jeune qui commence son activité dans l’entreprise agricole une prime qui va jusqu’à 25.000 euros, environ 50 millions de lires; pour la programmation de 2000-2006 l’on prévoit un montant de 4.501.000 euros qui correspondent à peu près à 9 milliards de lires; la mesure de la préretraite aussi c’est une mesure intéressante à l’intention des entrepreneurs agricoles ayant au moins l’âge de 55 ans et qui peuvent jouir d’une indemnité de préretraite d’environ 15.000 euros, environs 30 millions par an. On a prévu pour cette mesure dans la programmation de six ans un coût de 1.600.000 euros, environ 3 milliards de lires.
Les interventions dans le secteur de la sylviculture, là aussi pour la programmation de six ans l’on prévoit environ 4,5 milliards de lires, pour l’indemnité compensatoire l’on prévoit pour la programmation de 2000-2006 un chiffre très important de 140 milliards de lires et pour les mesures de l’agroenvironnement pour la programmation de six ans l’on prévoit 73 milliards de lires.
Donc la programmation des mesures cofinancées par l’Union européenne et par l’Etat italien porte sur un total de 230,6 milliards pour les six ans de programmation dont l’intervention de l’Union européenne correspond à 84,759 milliards de lires, c’est le chiffre précis que cette dernière met à disposition de ces mesures pour la programmation 2000-2006. L’autre partie du plan, qui concerne les mesures d’aides d’Etat, qui sont à la charge totale du budget régional, a fait l’objet d’un examen particulier. Plusieurs mesures ont été reformulées, révisées sur la base des observations de la commission que nous avons reçues soit en forme écrite, soit par nombreux coups de téléphone.
Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles avec les fonctionnaires de la commission trois fois et cela pour vous faire comprendre la nature très engageante de cette négociation. Les mesures cassées immédiatement, parce que tâchées d’être des aides au fonctionnement, et qu’on a dû effacer du plan sont: les remboursements des contributions prévidentielles à la charge des entreprises agricoles ayant des dépendants, l’aide accordée aux conducteurs d’alpages n’ayant pas de routes dans les frais de transport en hélicoptère et l’aide aux frais de gestion des coopératives agricoles.
En d’autres cas on a dû réduire le taux d’intervention public, par exemple les aides aux investissements des coopératives, nous avons proposé un taux de 70 pour cent, mais nous avons dû le réduire à 40 pour cent. D’autres actions n’ont pas pu être insérées parce qu’incompatibles avec le traité en matière de politique agricole commune, par exemple la réalisation d’un label Vallée d’Aoste à afficher aux produits régionaux traditionnels. En ce qui concerne les aspects les plus intéressants et positifs du plan, je rappelle l’indemnité compensatoire.
Nous avons réussi à faire comprendre aux services de la Commission européenne la différence qui passe entre l’agriculture de plaine et l’agriculture de montagne, les difficultés auxquelles celle-ci se confronte quant au climat, aux transports, à la rentabilité, ce qui a fait que l’indemnité qui sera octroyée dans notre Région est plus importante que dans d’autres régions. Quelques exemples: pour les cultures fourragères l’on prévoit des primes qui vont jusqu’à un maximum de 600 euros par hectare, c’est-à-dire environ 1,2 million par hectare, pour les cultures spécialisées l’on va jusqu’à 800 euros par hectare, environ 1,6 million par hectare.
Nous avons prévu, dans l'indemnité compensatoire, une indemnité supplémentaire pour les alpages qui ne sont pas fournis de routes d’accès, cela pour tâcher d’aller de quelque façon résoudre le problème du manque de contribution aux frais de transports par hélicoptère et là il y a un maximum d’euros disponibles pour chaque alpage de 2.000 euros, environ 4 millions de lires.
Quant à l’application des méthodes agricoles correctes, ce qu’on appelle "la buona pratica agricola", là aussi nous avons dû négocier pour maintenir le rapport territoire/bestiaux à quatre unions de bétail adulte par hectare pour les vaches de race valdôtaine, étant donné qu’il s’agit d’une petite race qui pratique l’alpage pendant l’été et qui n’est pas à la charge de la ferme principale toute l’année.
Je voudrais encore souligner que le plan prévoit l’octroi d’aides publiques importantes en faveur des propriétaires et des conducteurs d’alpages dans les frais de construction ou de remise en état des bâtiments d’alpages, de maintien des pâturages, de construction ou réfection des aqueducs, des rus, des routes, des installations pour la production et le transport d’énergie électrique dérivant d’une source renouvelable. Les aides ont été autorisées pour les alpages jusqu’à 75 pour cent de la dépense admise. Cela a été possible surtout parce que la Commission a reçu le principe que le maintien des alpages est fondamental pour la conservation du paysage traditionnel.
Sont aussi importantes les aides aux investissements des entreprises agricoles: l’on va de 55 pour cent de la dépense admissible pour les jeunes agriculteurs à 50 pour cent pour les agriculteurs à temps plein, à 45 pour cent pour les autres titulaires.
Quant aux aides aux investissements aux consortiums d’amélioration foncière, nous avons obtenu l’autorisation à octroyer une contribution publique jusqu’à 100 pour cent. Cela a été un résultat exceptionnel en considération du fait que, tout en étant des organismes privés, les consortiums déroulent leur activité envers la collectivité et donc ils ne sont pas à assujettir aux règles de la concurrence. A la faveur des consortiums reconnus il est en outre possible d’octroyer une contribution de 60 pour cent des frais de gestion.
Un travail attentif de nos techniciens a été requis par l’élaboration des primes à l’adoption des méthodes agricoles compatibles avec l’environnement, plus connu comme "agroambiente", surtout quant aux calculs de la perte de revenu des exploitants qui choisissent d’y adhérer. L’on arrive pour les cultures spécialisées jusqu’à un maximum de 900 euros/hectare, environ 1.750 millions/hectare.
Je veux souligner encore quelques aspects innovateurs qui sont nombreux surtout pour ce qui concerne le développement rural dans son ensemble: nous allons de l’installation des services de substitution garantis par les associations de catégorie aux exploitants agricoles ayant besoin d’une aide pour des raisons différentes: maladie, maternité, soins médicaux, formation professionnelle ou autres cas dus à des raisons contingentes ou de force majeure; les cours de formation, viticulture, arboriculture, fabrication de fromage, etc., conduits de façon innovatrice en collaboration avec l’Institut agricole régional, ainsi que la formation en matière de qualité et des cadres affectés à la gestion des entreprises multisectorielles. Ces derniers seront conduits en collaboration avec l’Agence de l’emploi dans le cadre de l’Objectif 3.
Une autre mesure innovatrice est la requalification de l’environnement, les aides à la réfection des mayens et des bâtiments ruraux de valeur à affecter à des activités touristiques, les primes à la qualité et à la certification des produits, les aides à la promotion et à la publicité des filières.
Ce sont une série d'aides, ces dernières, qui iront en faveur surtout des coopératives et qui pourront de quelque façon substituer les contributions dans les frais de gestion de ces importantes institutions. Je rappellerai encore l’assainissement des arbres à fruit et des vignes par des aides à la lutte contre les épidémies phytopathologiques, l’aide à l’achat des terrains à l’intérieur des remaniements fonciers, mais je ne veux pas reprendre l’illustration de toutes les mesures prévues dans le plan, d’ailleurs cela avait déjà été fait de façon détaillée lors de sa présentation à ce Conseil au mois de février dernier. Je tiens à faire quelques considérations d’ordre général.
L’état de santé de notre agriculture est faible face aux difficultés auxquelles l’agriculture en général est en train de se confronter, face aux phénomènes de mondialisation des marchés, face à l’avancée des modernes technologies, aux modifications génétiques, aux graves problèmes de la vache folle, c’est une question à la une ces jours.
Face aux grandes quantités de production en circulation, l’agriculture valdôtaine pourrait même disparaître sans que les marchés ne s’aperçoivent. Même d’une analyse plus limitée à notre réalité de Région, il apparaît que le produit interne brut que notre agriculture produit risque d’être ridicule par rapport aux autres secteurs productifs. Il faut donc trouver des motivations pour assurer un rôle au monde agricole qui ne soit que celui de la production brute qui ne répond qu’aux lois de marché et de la concurrence. Là nous sommes perdants et il n’y aurait qu’à décréter la fin de notre monde agricole.
Mais combien nous avons dû insister pendant les pourparlers avec l’Union européenne de ces mois, pour arriver à démontrer les raisons selon nous indéniables du soutien public à notre agriculture, tout en disposant de données objectives!
Nous sommes une région de montagne, une montagne avec une grande vocation environnementale et touristique, patrimoine de notre communauté, mais aussi patrimoine de l’humanité entière, que nous avons su entretenir et sauvegarder par la présence de l’homme, en particulier par la présence des montagnards qu’ils soient paysans, éleveurs, viticulteurs, mais en même temps artisans, opérateurs touristiques, guides, moniteurs de ski. L’Europe dans ses orientations pour Agenda 2000 a reconnu ce rôle et cette fonction à l’agriculture: l’on y parle de développement durable, de multifonctionnalité de l’agriculture, des valeurs sociales et culturelles du monde rural, du maintien des paysages traditionnels. Il s'agit d’excellents principes que nous partageons, qui s’adaptent entre autres beaucoup mieux à notre réalité plutôt qu’à l’agriculture intensive des plaines.
Toutefois il me semble d’y percevoir une contradiction: ces orientations se heurtent avec les principes de la concurrence, de l’efficacité économique et de la libre circulation des produits, principes au nom desquels l’on prétend mettre tous sur le même plan.
Pris acte de notre situation particulière la Commission européenne exprime ces considérations: "Votre zone est considérée défavorisée.." mais pas zone de montagne "? par conséquent nous vous permettons d’indemniser les handicaps que l’état de zone défavorisée implique par une aide compensatoire; néanmoins cette aide ne peut dépasser un certain plafond et surtout il faut que le bénéficiaire démontre d’être à même de remplir les conditions minimales quant au bien-être des animaux, quant à l’organisation de l’entreprise agricole, quant aux pratiques agricoles".
Et là nous avons obtenu un maximum allant jusqu’à 800 euros/hectare avec une moyenne régionale d’environ 170 euros/hectare. Une autre forme de compensation est liée au rôle environnemental de l’agriculture de montagne. Les mesures d’aide agroenvironnementale vont compenser le travail supplémentaire qu’une agriculture écocompatible comporte; les aides vont jusqu’à un maximum de 900 euros/hectare pour les cultures spécialisées avec des aides bien inférieures pour les alpages et pour les terrains fourragers.
Au-delà de ces mesures tout doit rentrer dans les règles de la concurrence et de la libre circulation des marchandises, par conséquent aucune aide supplémentaire ne peut être prévue pour le fonctionnement des entreprises agricoles.
Comme vous le savez, pour faire face à une partie des handicaps structuraux de nos entreprises, nous avons poussé depuis toujours la coopération, conscients de sa fonction d’unifier les petites réalités productives, de garantir un service social de soutien à tous les producteurs d’une zone.
Les coopératives pour l’Europe ne sont que des entreprises comme les autres, donc assujetties aux mêmes règles qu’une entreprise multinationale. Un système, celui de la coopération, qui a garanti un minimum de revenu à nos paysans, risque d’être énormément pénalisé face à des raisons qui ne sont pas soutenables et que nous n’avons même pas pu discuter.
Une fromagerie coopérative qui ramasse le lait jusqu’aux villages les plus éloignés et transforme une modeste quantité de lait ne peut être mise sur le même plan d’une fromagerie industrielle.
Dans la proposition du plan et dans la longue phase de négociation nous avons tâché de proposer et de défendre tout ce qui était possible de proposer et de défendre. Nous avons obtenu des résultats intéressants, mais dans le contexte qui nous a été imposé.
Toutefois une réflexion politique s’impose: la Vallée d’Aoste, et plus en général la montagne, ne peut pas être mise sur un plan d’égalité avec les zones à vocation agricole tout court. Notre Région en particulier, à qui le Statut d’autonomie a reconnu la compétence primaire dans le secteur agricole, est mortifiée par ce système.
Les régions d’Europe n’ont aucune force politique face à l’Union européenne; l’Etat membre, à travers lequel la Région doit toujours passer pour ses notifications et pour la réception des décisions de la commission, est faible face à la politique agricole européenne et ne défend en aucune façon ses régions de montagne.
Je dirais que les institutions en général sont faibles, sauf voir privilégier les influences des lobby et des puissances économiques.
Le libéralisme total, garanti par le principe de concurrence mal interprété et mal appliqué, ne peut que détruire un système fragile comme le nôtre et un système qui nécessite de garanties de protection pas pour lui-même, mais pour l’intérêt et le service collectif qu’il est à même de fournir.
Nous ne pouvons quand même pas nous soustraire au processus de modernisation du système agricole, nous ne pouvons pas prétendre de nous isoler et de nous placer hors de la logique de l’Europe. L’Europe même est provinciale face à la globalisation et à la mondialisation des marchés; en effet la logique du libre marché et des multinationales semble commencer à préoccuper une partie de l’humanité.
Nous nous trouvons, peut-être malgré nous, à l’avant-garde d’un processus de récupération de produits originels, de bétail qui est en gré de s’autoalimenter dans les prairies, de processus de fabrication de produits tout à fait naturels et potentiellement biologiques. Il faut que nous puissions, sans contraintes, valoriser ces niches de production qui ne peuvent être concurrentielles, mais qui au contraire peuvent représenter un créneau fort intéressant pour commencer à invertir la tendance.
En conclusion ce plan représente un résultat positif si nous considérons les contraintes dans lesquelles nous avons dû agir. Il a le mérite de promouvoir une politique globale du territoire rural de notre région, il nous donne la tranquillité d’opérer ayant obtenu un avis positif généralisé sur toutes les initiatives prévues; nous avons fixé des objectifs précis et tracé un parcours et des aides pour les rejoindre. Le plan je crois qu’il a représenté un grand effort de programmation et même d’une révision radicale de la façon d’intervenir: l’on passe d’une phase de conservation à une phase de développement.
Nos bureaux sont en train de préparer les délibérations d’exécution du plan et pour toutes les mesures dont on a la disponibilité financière l’on sera prêts à démarrer dans le plus bref délai.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Il piano di sviluppo rurale in approvazione rappresenta l’adempimento di quanto previsto dal regolamento CEE n. 1.257 del maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e come tale è un documento dal taglio marcatamente burocratico che ricalca uno schema peraltro già definito. Non vorrei essere frainteso in quanto riconosco il giusto merito ai funzionari dell’Assessorato e agli eventuali consulenti per il lavoro svolto, in particolare per l’intensa ed estenuante attività di negoziazione con gli uffici di Bruxelles né intendo disconoscere che quanto ottenuto con questa impostazione è probabilmente quanto si poteva avere. Che il settore agrario, come tutti gli altri, disponga di una pianificazione è non solo giusto, ma è salutare; in tal senso il piano è quanto mai opportuno.
Meno convincente è il fatto che questa pianificazione sia articolata e rigidamente coerente con una politica agraria imposta dall’Unione europea sulla quale pesano non poche riserve, soprattutto perché le indicazioni presentate quali orientamenti comunitari in materia di agricoltura, enunciati dal Consiglio in data 28 febbraio 2000, si sono rivelate in questa occasione delle vere e proprie norme rigorosamente applicate dalla commissione. Il mutismo politico che caratterizza questo documento potrebbe far pensare ad una preliminare attitudine alla rinuncia della Regione a rivendicare la propria autonomia oppure l’accettazione supina della volontà della commissione.
In realtà la Regione da sola risultava e risulta essere debole in rapporto al modo con il quale la commissione ha agito in questa materia. In questa vicenda pesa molto poi il comportamento di tutte le regioni di montagna che hanno preferito percorrere la strada della contrattazione singola con la speranza di ognuna di portare a casa per proprio conto il migliore risultato possibile anziché costituire insieme una controparte capace di condizionare l’Unione europea in fatto di sostegno all’agricoltura.
Questo piano prevede l’attivazione di risorse, di cui una gran parte regionali, per quasi 1.000 miliardi a fronte di un rientro in termini di prodotto interno lordo di poco superiore ai 650 miliardi, da qui si evidenzia un palese deficit del settore. Questa situazione fa affermare che l’agricoltura deve essere sostenuta in quanto la sua produttività è deficitaria. Si deve però tenere conto che il risultato della sua attività non è solo produzione, è anche servizi, il cui corrispettivo potrebbe essere semplicisticamente e riduttivamente individuato negli oltre 300 miliardi di sbilancio.
L’agricoltura, considerata come produttore di servizio, è attendibile nella misura in cui le assicuriamo la capacità di mantenere il paesaggio e alcuni equilibri ambientali, favorire una demografia diffusa sul territorio, offrire prodotti di qualità tipici e genuini ottenuti secondo metodi compatibili con l’ambiente e sani, aspetto questo che sarà sempre più importante con il passare del tempo. Per poter assicurare questi servizi l’agricoltura di montagna ha bisogno di essere considerata globalmente nel suo contesto e deve poter realizzare le produzioni secondo logiche effettivamente orientate a coniugare produzione e servizi.
Gli orientamenti della politica agricola si basano su alcuni principi che poco hanno a che fare con quelli sui quali poggia l'agricoltura di montagna e li richiamo: la redditività dell’azienda agricola in termini di prodotti; la negazione di ogni sostegno al reddito per timore che possa porre le aziende in condizioni di favore per rapporto alla concorrenza quando per queste non esistono nemmeno i presupposti: un quintale di fieno da noi costa 55.000 lire, il prezzo di mercato è di 35.000 lire; la scarsa attenzione per le condizioni di vita dell’agricoltore; il non chiaro rapporto con l’ambiente e infine, come ha detto recentemente il Commissario europeo all’agricoltura, Fischler, l’attenzione esasperata alla produzione e non alla qualità.
Sono orientamenti coerenti con l’agricoltura di pianura, ma antitetici alla specificità e alle problematiche dell’agricoltura di montagna; questa ha riferimenti opposti e necessita di un sostegno in ragione della pluralità delle produzioni intendendo con queste anche lo svolgimento di servizi indipendentemente dall’assolvimento di condizioni imposte dall’Unione europea.
La procedura che questa oggi impone, infatti, fa sì che i sostegni più rilevanti, siano essi comunitari o statali o regionali, non solo vengano erogati sulla base di una dimostrata efficacia aziendale in termini economici, ma siano in generale tollerati o sentiti solo se si configurano come un compenso per le perdite di reddito che l’azienda subisce nel seguire certe modalità produttive sollecitate o ammesse dall’Unione europea stessa e non perché l’azienda si trovi in un certo contesto nel quale è importante che continui ad esistere pur non essendo rigorosamente redditizia.
Nel caso della montagna, e nostro in particolare, le regole condizionanti poste dalla comunità sono per lo più già connaturate con le modalità stesse della produzione; l’esistenza di un'insufficiente redditività consegue ai costi della produzione compresi quelli dei servizi, non nel rispetto di direttive confezionate a Bruxelles e spesso frutto di mediazioni fra attori che hanno palcoscenici ben diversi dai nostri.
Con simili premesse è chiaro che le giustificazioni per le perdite di reddito sono delle mere alchimie contabili.
Dal punto di vista finanziario si può dire che con questo piano il volume complessivo degli aiuti non si modifica o forse potrebbe addirittura aumentare, ma saranno sostanzialmente modificati gli aiuti in modo da soddisfare le regole dell’Unione europea, non le esigenze di sopravvivenza, di razionalizzazione e di rilancio della nostra agricoltura. Da una parte infatti si può sottolineare che con l'introduzione dei presupposti di ammissibilità a contributi quali la superficie minima su cui realizzare la produzione, la redditività aziendale, la buona pratica agricola, il benessere degli animali, la compatibilità ambientale, con questi presupposti il divario fra azienda virtuale e azienda reale verrà attenuato, fatto di per sé positivo a condizione che il territorio agricolo, che fa capo a quei soggetti che abbandoneranno le coltivazioni, venga utilizzato da altri e favorisca la composizione di aziende più capaci di rimanere sul mercato, altrimenti ci sarà l’aumento dell’incolto.
Dovrebbe poi esserci la garanzia di una reale incentivazione economica a favore di chi effettivamente lavora la terra per rapporto alla semplice proprietà evitando il rischio che l’aumento delle indennità compensative non determini delle lievitazioni eccessive degli affitti o peggio che l'indennità vada alla proprietà e non a chi effettivamente la coltiva.
Rimane poi da vedere se l’applicazione rigorosa o esasperata dei criteri che ho citato prima non determini ingiuste penalizzazioni a danno di una parte della nostra agricoltura da chi comunque la pratica, ma in termini di dimensioni aziendali più ridotte.
D’altra parte c’è da sottolineare una quasi completa chiusura imposta dalla commissione verso il settore cooperativistico da sempre perno dell’attività di produzione e di commercializzazione della filiera agricola valdostana.
Questo sempre a causa dell'esasperata rigidezza nell’applicazione del principio della concorrenza che viene a vietare consolidate forme di sostegno al funzionamento e alla gestione, fatto grave, in maniera assolutamente repentina.
In prospettiva futura preoccupano poi la mancanza di flessibilità del piano e l'impossibilità di diversificazioni e modifiche in sede attuativa salvo che non siano volute o imposte dall’Unione europea.
È una condizione che ritengo molto pericolosa in quanto, di fronte all’allargamento dell’Unione europea, essa porterà inevitabilmente a non avere più aiuti da parte della comunità in quanto è destinata ai Paesi che si accingono ad entrare nell’Unione, e questo potrebbe verificarsi prima della scadenza del 2006, ma anche di trovarsi in un futuro penalizzati per non essere più nella possibilità di darsi delle forme di sostegno in quanto le regole che viceversa rimarranno non lo permetteranno.
L’ultima annotazione riguarda il carico burocratico e la complessità di gestione con oneri non indifferenti che questo piano impone per la sua attuazione, in particolare per l’applicazione delle misure e dei controlli.
In una realtà come la nostra si rischia, applicando tutte le procedure concepite per dove le unità produttive hanno ben altre dimensioni, di avere un salariato che fa il ruscello e tre che controllano se viene fatto nel rispetto delle cinque direttive. Il Consiglio regionale dovrebbe cogliere questa occasione di approfondimento dell'approvazione di questo piano intanto per sottolineare che esso parte da presupposti che non ci stanno bene e quindi per sollecitare la revisione della politica agricola nazionale, della quale peraltro esistono in Parlamento almeno cinque progetti, e quella comunitaria in modo che tenga conto della specificità dell’agricoltura di montagna, altrimenti la "Valutazione ex ante" del prossimo qualsiasi piano avrà molte caselle vuote in fatto di aziende agricole e di addetti all’agricoltura, per contro registrerà una lievitazione dei costi per assicurare la manutenzione del territorio e gli equilibri demografico-ambientali.
C’è infine un luogo comune che credo debba essere sfatato ed è quello dell’accusa di assistenzialismo in agricoltura che il piano saggiamente avrebbe in parte decurtato. È possibile che qualche elargizione sia stata poco ponderata e inopportuna nel passato, in questo senso qualche taglio può considerarsi salutare, ma nel complesso se ci fosse stato l’assistenzialismo di cui si racconta, non avremmo l’età media degli agricoltori valdostani a 55 anni, scarso ricambio, e non constateremmo la perdita in pochi anni di migliaia di aziende agricole e il preoccupante aumento degli incolti.
Se viceversa non avessimo sostenuto l’agricoltura, come è stato fatto finora, oggi l’abbandono con tutte le sue ricadute sarebbe l’elemento caratterizzante delle nostre vallate.
Oggi, grazie alla politica di sostegno adottata dalla Regione, è ancora possibile fondare sull’agricoltura rimasta dei progetti per il suo rilancio nella modernizzazione se a questa agricoltura viene effettivamente riconosciuto il suo ruolo e la sua collocazione in un ambiente non genericamente svantaggiato, ma specificatamente classificato montano. Di questo dovrebbe prendere atto l’Unione europea.
Sono ben altre che l’ammissione in modo meno fiscale dei sostegni all’agricoltura di montagna, che ha un suo mercato ed è ininfluente per i grandi commerci, sono ben altre le storture della politica agricola comunitaria che assorbe metà del bilancio dell’Unione europea e costa ad ogni famiglia italiana 3 milioni all’anno a fronte di un prodotto interno lordo che incide complessivamente solo sul 2 percento favorendo di fatto l’agricoltura industrializzata.
O come l’assurdo protezionismo agricolo che pesa sulla Comunità europea per oltre 2.000 miliardi di lire all’anno, per non fare coltivare 4 milioni di ettari di terreno agricolo con il solo scopo di mantenere un elevato prezzo dei prodotti agricoli aggravando l’onere a carico dei consumatori senza però generare le condizioni per il miglioramento del reddito delle aziende agricole che resta pericolosamente basso, ma che per contro è anche alla base dei processi di esasperazione delle rese produttive sulle minime superfici o con i minimi volumi o, per dirla in altro modo, attraverso l’impiego eccessivo di fertilizzanti e antiparassitari o la somministrazione agli animali di mangimi forzati con le conseguenze che cominciamo a conoscere per evitare le quali l’agricoltura di montagna nella sua irripetibilità, se l’Unione europea vorrà lasciarla sopravvivere, rappresenta un modello e forse una speranza.
PrésidentLa parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (SA)Per la prima volta quasi tutti gli elementi della politica agricola e rurale regionale sono riuniti in un unico testo. Gli investimenti previsti superano i 1.200 miliardi in 7 anni e comprendono sia i finanziamenti provenienti dall’Unione europea e dallo Stato italiano, sia gli aiuti regionali alla partecipazione delle collettività locali.
Questo importante piano pertanto rappresenta un fondamentale strumento per il futuro dello sviluppo rurale in Valle d’Aosta e non solo per la quantità di risorse che vengono impegnate.
Questo è un piano che attribuisce all'agricoltura, oltre alla funzione classica produttiva, anche altre funzioni come quella di protezione dell’ambiente, di presidio del territorio, di mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, il tutto in un'ottica di integrazione dei diversi settori, ottica che in una Regione come la nostra risulta essere la più corretta.
Tra gli aspetti che ritengo più meritevoli c’è l’offerta il più possibile diversificata di prodotti anche non agricoli di alta qualità e riconoscibilità, inoltre particolare interesse rappresenta la riconversione delle aziende agricole da centri di produzione a centri di pluriattività con la commercializzazione di prodotti e servizi di ospitalità e anche la valorizzazione di tutte le potenzialità, espressione culturale delle aree rurali. E ancora le attività turistiche connesse all’agricoltura con l’indicazione della necessità di interventi che devono basarsi sul principio del recupero dell’esistente e non su quello di nuova realizzazione, il che significa recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico esistente anche per alpeggi e mayen e non nuove cementificazioni.
Siamo di fronte quindi a un piano di sviluppo rurale che traccia un quadro sicuramente ampio e articolato della situazione esistente senza però nascondere situazioni e dati anche preoccupanti emersi anche nella discussione della commissione competente, come ad esempio il fatto che la produzione lorda vendibile relativa al 1996-1997 ha superato di poco i 100 miliardi di lire quando tra Regione, Stato e Unione europea sono stati versati ben 139 miliardi di fondi per l’agricoltura.
Questo fatto dimostra alcune debolezze della nostra realtà, debolezze, e questo è anche un limite, che non si sa se derivano da elementi strutturali tipici e quindi insopprimibili dell’agricoltura alpina o se invece sono la conseguenza di nostre specifiche carenze e questo è anche difficile da individuare visto che mancano comunque dei rapporti comparativi con realtà simili o omogenee alla nostra.
Occorre comunque tener conto di queste nostre carenze per poter capire le ragioni e di conseguenza agire per eliminarle o almeno attenuarle.
Ritornando al dato sopracitato, relativo alla produzione lorda vendibile alla portata dei fondi investiti, ne deriva una facile considerazione da fare ad alta voce: se vengono meno le attuali provvidenze che si danno al settore agricolo, i nuovi indirizzi della politica agricola europea potrebbero portare il settore agricolo valdostano al collasso.
Inoltre bisogna tener conto dei processi di globalizzazione dei mercati poco compatibili con la nostra realtà agricola.
La domanda quindi che dobbiamo porci è quali sono gli investimenti necessari per stare sul mercato tenuto conto del fatto che non possiamo immaginare per la nostra realtà una corrispondente riduzione dei costi di produzione vista la nostra realtà di agricoltura di montagna, una risposta, che mi sembra fosse già stata dichiarata nella precedente discussione dal collega Cerise, è quella di trovare una collocazione nel cosiddetto "mercato di nicchia", ma attenzione che se per caso si compiono degli errori, si fa presto a passare da un mercato di nicchia a un mercato marginale e quindi a fuoriuscire dal mercato.
Credo quindi sia importante aver chiaro che il futuro della nostra agricoltura sia nella qualità globale e nella responsabilità di tutti gli attori della filiera produttiva, fra l’altro quando parlo di qualità globale non mi riferisco solo alla produzione, ma anche ai servizi che devono essere effettivamente servizi di qualità.
Il futuro della nostra agricoltura passa anche attraverso uno sforzo per aggregare i poli associativi, le cooperative, i consorzi al fine di ridurre i costi di gestione.
Occorre poi una strategia commerciale e distributiva efficiente e il riconoscimento remunerativo dei servizi resi all’ambiente dall’agricoltura.
La cosa importante sulla quale dobbiamo assolutamente puntare è che in un’altra sede, quella europea ovviamente, si riesca finalmente a far capire che i prodotti della montagna, laddove sono tipici, genuini, ecocompatibili, oltre che derivare da un’agricoltura che si può definire eroica, usando anche un termine forte però pertinente in questo caso, sono caratterizzati da unicità e hanno una produzione irrisoria e comunque contenuta in volumi tali da non modificare gli equilibri economici che regolano i mercati. E tutto ciò per evidenziare che nelle zone di montagna gli aiuti alla produzione, le deroghe ai vincoli dei reimpianti, le limitazioni ai finanziamenti alle infrastrutture e qualche volta anche il richiamo quasi ossessivo alla possibilità di violare la cosiddetta "libera concorrenza" sono poco pertinenti e rischiano solo di penalizzare fortemente l’attività agricola che, come evidenziato dai dati dell’esame "ex ante" annesso al documento, rischia di trovare grandi difficoltà a mantenersi nel futuro per la disaffezione dimostrata dai giovani nonché per la qualità della vita, per il ritorno in termini di soddisfacimento del lavoro svolto, infine per la non comparabilità del reddito a fronte dell’impegno con altre categorie di lavoro.
Bisogna peraltro raggiungere una sorta di equilibrio fra le nostre esigenze e quelle della Comunità europea, ma perché gli equilibri siano tali occorre anche che la Comunità europea tenga in considerazione le nostre istanze e a tal proposito devo sottolineare alcune note negative di questo piano alle quali io spero si possa al più presto porre rimedio.
Vi sono infatti in questo documento notevoli differenze rispetto al vecchio testo iniziale approvato lo scorso anno, modifiche imposte a livello europeo e che personalmente ritengo peggiorative per i nostri agricoltori, contribuzioni molto importanti per l’economia agricola valdostana previste nella prima bozza del piano sono state stralciate, cito ad esempio i contributi agricoli unificati, gli interventi a sostegno delle spese di gestione delle cooperative agricole, la percentuale degli aiuti per gli impegni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, i contributi per l’utilizzo degli elicotteri.
E non si tratta di tagli minimi, ad esempio i contributi per la spesa di gestione delle cooperative coprivano il 60 percento della spesa, mentre la percentuale dei contributi per gli impegni di trasformazione e commercializzazione è passata dal 70 al 40 percento e tutto questo perché la Comunità europea non ha tenuto conto della specificità della nostra agricoltura di montagna, ma ha considerato il territorio agricolo nel suo insieme senza riflettere sulle ovvie e giuste differenziazioni.
In sede di commissione consiliare ci è stato precisato che queste perdite saranno controbilanciate da un incremento dell'indennità compensativa: il cosiddetto "verde agricolo". Non dobbiamo però dimenticare che tale promessa compensazione avrà comunque l’effetto di penalizzare in parte le aziende, e in Valle non sono poche, che possiedono poca superficie agricola.
Ritengo pertanto giuste e comprensibili queste preoccupazioni espresse anche in sede di commissione e anche da altri colleghi e credo che occorra intervenire immediatamente presso le sedi opportune per chiarire meglio la situazione e porvi quanto prima rimedio.
Abbiamo la fortuna di essere rappresentati da un Europarlamentare a Bruxelles, ecco una buona occasione per la Valle d’Aosta di farsi promotrice di una robusta azione politica volta a rivendicare la giusta attenzione della Comunità europea nei confronti del mondo agricolo alpino.
Per raggiungere tale obiettivo dobbiamo anzitutto convincere l’Europa che i criteri di applicazione del piano di sviluppo rurale dovranno contenere dei coefficienti, soprattutto per i successivi provvedimenti, in grado di tener conto sia della peculiarità delle aree alpine, sia della morfologia tipica del territorio ove i dettami europei dovranno trovare applicazione. Ecco perché mi sono permesso assieme ad altri colleghi e d’accordo con l’Assessore di presentare una risoluzione che ha il fine di sensibilizzare i vertici europei verso un'ulteriore rivalutazione delle problematiche delle zone di montagna come la Valle d’Aosta.
Mi auguro che questa iniziativa, che non ha alcuna pretesa se non quella di farsi portavoce del mondo agricolo valdostano, sia approvata da questo Consiglio a dimostrazione del fatto che la Valle d’Aosta desidera affermare in tutte le sedi opportune l’impegno a trasformare l’agricoltura di montagna in un'attività produttiva in grado di stare al passo con le trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali in atto in Europa.
Con questa risoluzione pertanto si chiede alla Giunta regionale di farsi promotrice di una forte azione politica a livello europeo attraverso il proprio Europarlamentare, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale dell’Unione europea e di concerto con il Governo italiano al fine di poter rivendicare una giusta e differenziata attenzione nei confronti delle zone di montagna quali la nostra, attraverso l’attribuzione nei criteri di applicazione di futuri ed ulteriori provvedimenti, di coefficienti che tengono conto sia della particolarità delle aree alpine, sia delle caratteristiche morfologiche del territorio ove tali determinazioni dovranno essere applicate.
Per concludere vorrei sottolineare l’importanza attraverso questo piano di reintrodurre il mondo agricolo nel contesto sociale togliendo l’agricoltore da quello stato di emarginazione attraverso un riconoscimento appieno del suo ruolo produttivo, ma anche di servizio, un agricoltore cioè che diventa multifunzionale in quanto offre ricettività, servizi per la collettività oltre ad essere principale attore nella filiera produttiva. Occorre però sottolineare che questa proposta di riorganizzazione deve ora e in futuro basarsi su alcuni aspetti irrinunciabili, se effettivamente vogliamo contribuire tutti a migliorare la situazione nel mondo agricolo valdostano, e quindi dobbiamo assicurare un'effettiva burocratizzazione delle procedure. Bisogna adoperarsi affinché rimangano assegnate al mondo agricolo le attuali risorse finanziarie, altrimenti si rischierebbe di veder diminuire la presenza sul territorio con tutte le conseguenze relative al mantenimento dello stesso, occorre dare maggiore aiuto alle piccole e medie aziende agricole molto importanti per la salvaguardia del territorio.
I giovani devono essere aiutati, abbiamo visto dei provvedimenti interessanti, ma ovviamente bisogna continuare in questa direzione perché i giovani rappresentano un ricambio generazionale più che mai indispensabile per l’agricoltura valdostana. È necessario prevedere aiuti mirati e differenti a seconda che si tratti di agricoltori a tempo pieno e agricoltori part-time.
Bisogna puntare alla diversificazione produttiva e qui abbiamo alcune indicazioni.
Occorre presentare, anche alla luce delle misure stralciate a livello europeo, se possibile delle soluzioni alternative che possano compensare questi tagli tenuto conto che gli agricoltori si troveranno di fronte a una situazione transitoria tra la legge n. 30 e il presente piano che potrebbe comportare dei disguidi nel mondo rurale se la Regione non saprà in tempi brevi intervenire attraverso un regolamento attuativo e mi sembra che l’Assessore nel suo intervento abbia detto che si stanno preparando queste delibere attuative e soprattutto attraverso una capillare informazione su quanto c’era e ora non c’è più e sulle nuove misure contributive stabilite dal piano oggi in approvazione. Tenuto conto dell'importanza del settore agricolo per la nostra Regione non si può fallire e quindi occorre tutti insieme lavorare per difendere da interpretazioni e imposizioni generalizzate la nostra particolare agricoltura di montagna.
Questo documento è senz’altro un atto fondamentale a cui occorre dare seguito celermente con i regolamenti attuativi delle singole misure ivi previste.
Il gruppo consiliare della Stella Alpina voterà questo piano e dà la sua piena disponibilità a lavorare ora e in futuro in maniera propositiva a difesa e a favore del settore agricolo valdostano.
PrésidentJe donne lecture de l’ordre du jour présenté par le Conseiller Lanièce et d'autres:
Ordine del giorno Preso atto dell’approvazione del "Piano di sviluppo rurale 2000/2006", redatto in attuazione del Regolamento CE 1257/99, all’ordine del giorno di questo Consiglio, che costituisce un atto amministrativo indispensabile per lo sviluppo rurale della Valle d’Aosta;
Sottolineata l’importanza di tale Piano, che rappresenta uno strumento fondamentale con il quale si va a riconsiderare a 360° tutto il settore dell’agricoltura, della forestazione e delle risorse naturali della nostra regione;
Tenuto conto che a tal proposito il Piano contiene importanti misure a sostegno dell’agricoltura e più in generale dello sviluppo rurale;
Tenuto conto altresì del fatto che tale documento oggi in discussione presenta alcune modifiche rispetto al testo originale approvato lo scorso anno dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta ed inviato successivamente alla Commissione Europea di Bruxelles per la dovuta istruttoria;
Evidenziato che le modifiche apportate potrebbero avere come conseguenza ripercussioni negative sul mondo agricolo valdostano, essendo state stralciate alcune misure contributive finora importanti per l’agricoltura valdostana;
Ravvisato che tali modifiche corrispondono alla logica generale del mercato e della libera concorrenza valida anche per la realtà agricola, e quindi poco attenta alle problematiche delle zone di montagna quali la nostra, dove l’agricoltura svolge un’importante funzione di equilibrio ambientale e di valorizzazione paesaggistica;
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta
Impegna
la Giunta regionale a farsi promotrice di una forte azione politica a livello europeo, attraverso il proprio Parlamentare, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico-sociale dell’Unione europea e di concerto con il Governo italiano, al fine di poter rivendicare una giusta e differenziata attenzione nei confronti delle zone di montagna attraverso l’attribuzione, nei criteri di applicazione di futuri ulteriori provvedimenti, di coefficienti che tengano conto sia della particolarità delle aree alpine sia delle caratteristiche morfologiche del territorio ove tali determinazioni dovranno essere applicate.
F.to: Lanièce - Perrin - Cerise - Squarzino Secondina - Martin - Nicco - Fiou - Collé - Borre - Bionaz - Cottino
La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV)A un anno dalla presentazione alla Commissione europea del nostro piano di sviluppo rurale ci troviamo a riapprovare un documento che ha passato tutti i filtri della burocrazia di Bruxelles e tutte le costrizioni della contrattazione che viene definita con termine ottimistico "bilaterale".
In realtà il piano di sviluppo rurale è stato uno sforzo notevole e inedito di programmazione pluriennale e anche di revisione profonda nel modo di intervenire dell’Amministrazione. Dal concetto di conservazione e di mantenimento si passa a quello più impegnativo di sviluppo.
L’attenzione all’agricoltura si dilata allo spazio rurale e alle tematiche ambientali, un elenco di interventi settoriali è sostituito da un progetto globale finalizzato. A questo sforzo siamo stati in parte obbligati dalla Commissione europea, ma da questa anche condizionati in modo pesante.
L’estenuante trattativa che l’Assessore e i tecnici dell’Assessorato hanno condotto per più di un anno con i funzionari della Divisione agricoltura ci fa riflettere e preoccupare sul nostro spazio di autonomia in campo agricolo, autonomia sancita dal nostro Statuto speciale ed esercitata per cinquant’anni, autonomia che ora sempre essere limitata alla capacità di interpretare e di ottenere qualche spazio all’interno della fitta e precisa normativa comunitaria, la cui attuazione è controllata con rigore e dedizione da preparatissimi burocrati provenienti da tutti i sedici Paesi dell’Unione.
Ho già espresso queste valutazioni e queste preoccupazioni un anno fa, ma oggi occorre riflettere su due punti che mi sembrano fondamentali. Il primo riguarda il cambio di mentalità che bisogna fare per ottenere dal piano di sviluppo rurale regionale il massimo effetto possibile sia per la parte cofinanziata dall’Unione, sia per la parte ben più consistente finanziata dal bilancio regionale.
Questo cambio di mentalità non riguarda solo il mondo agricolo e rurale, ma anche l’Amministrazione e i professionisti; progettare interventi organici, lavorare per obiettivi chiaramente identificati e misurare di continuo il progresso dei programmi verso gli obiettivi sarà l’unico modo di realizzare le tante azioni e misure previste dal piano di sviluppo, in più tutto questo non solo come metodo di lavoro nostro, ma anche come misura della nostra credibilità da parte delle valutazioni che la burocrazia della Commissione europea farà periodicamente.
Il nostro mondo agricolo, gli agricoltori e le loro organizzazioni cominciano ad avvertire la portata di questi cambiamenti, ripeto, sia nel bene sia nella sostanziale riduzione della nostra autonomia e molto lavoro rimane da fare per spiegare e far capire i mutamenti in atto.
Forse abbiamo accumulato qualche anno di ritardo rispetto ad altre realtà agricole nell’acquisire la portata dei mutamenti imposti da Agenda 2000; per molto tempo è stata vista solo come una minaccia, come una pericolosa limitazione al nostro sistema di intervento in agricoltura, soprattutto nel regime degli aiuti diretti. Gli aiuti alla gestione oggi non sono più possibili anche se qualche imbonitore si aggira affermando il contrario, ma si aprono nuovi spazi di intervento che puntano sulla professionalità, sulla multifunzionalità del lavoro agricolo, sulla qualità dei prodotti e sull'integrazione sociale dell’agricoltore.
Questa riflessione mi porta ad esporre il secondo punto: in molti documenti politici dell’Unione europea e anche nei documenti di programma della stessa commissione si leggono affermazioni che sono perfettamente sovrapponibili a quello che abbiamo sempre sostenuto, ad esempio la necessità di riconoscere all’agricoltura il ruolo di gestore di gran parte dell’ambiente e che questo ruolo ha una valenza economica che deve essere riconosciuta dalla società.
In parole più concrete abbiamo sempre sostenuto la necessità di riconoscere all’agricoltore un pagamento per il lavoro di "management" dello spazio rurale: pagare insomma per il lavoro che gratuitamente e inconsciamente l’agricoltore per tanto tempo ha svolto dai prati e campi e borri della Dora fino ai pascoli più alti.
L’Europa, per troppi anni impegnata a stimolare e a finanziare un’agricoltura intensiva e superproduttiva, ha messo molto tempo per capire che lo spazio rurale e il lavoro agricolo non è solo produrre alimenti per rifornire l’industria alimentare e per garantire stabilità sociale alle grandi concentrazioni urbane.
Si parla nei documenti del Comitato delle regioni, come in quelli del Comitato economico-sociale, in modo esplicito di questi argomenti e si traccia una linea europea allo sviluppo agricolo in contrapposizione al modello nord-americano.
I punti fondanti di questa via europea sono quelli che abbiamo cominciato ad introdurre nel nostro vocabolario: agricoltura sostenibile, multifunzionale, metodi di coltivazione come parte ineliminabile del paesaggio rurale, benessere animale, sicurezza alimentare, qualità dei prodotti, conservazione della biodiversità e delle tradizioni. Tutta musica per le nostre orecchie.
Per molti anni osservatori esterni ed interni hanno tentato di tutto per farci credere che la nostra agricoltura non era che un fatto marginale, economicamente residuale e che i tanto commentati contributi non fossero altro che un patetico tentativo per mantenere in piedi una realtà superata dalle moderne dinamiche di mercato.
Questa coscienza politica, espressa nei documenti comunitari e ripresa dagli stessi protocolli della Convenzione delle Alpi, non trova ancora una sufficiente traduzione pratica negli articolati dei regolamenti della commissione e la trattativa sul piano dello sviluppo rurale ne è una dimostrazione.
Già da oggi però siamo tutti coscienti che il quadro di interventi programmato per il 2000-2006, ormai definito nel dettaglio, si scontrerà alla sua scadenza con una revisione ben più radicale di quella imposta da Agenda 2000.
L’apertura ai Paesi dell’est e le trattative sul commercio mondiale, oltre che sconvolgere il bilancio dell’Unione, ridurranno a zero il significato economico della parte meno competitiva dell’agricoltura europea.
Il modello europeo che i documenti che ho citato indicano come possibilità per il futuro di avere uno spazio rurale vivo e socialmente connesso con lo spazio urbano deve trovare una definizione precisa a livello di programmazione operativa. Questo è un grosso impegno che deve partire dalle entità politiche più vicine al territorio, cioè dalle regioni. Dico questo perché posso immaginare la sensibilità che può avere un funzionario di Bruxelles quando tratta del prezzo del latte a livello mondiale di 400 lire al litro, per i nostri montagnards arrampicati per 100 giorni con le loro vacche per fare un po' di fontina.
Sono due mondi troppo separati e la sola logica di mercato, anche se la nostra fontina diventasse costosissima, garantisce la sopravvivenza di solo uno dei due.
Oltre a lavorare bene per realizzare tutto quanto è previsto dal nostro piano di sviluppo rurale dobbiamo quindi preoccuparci di preparare già da oggi gli strumenti per una dignitosa sopravvivenza futura e questi strumenti sono a mio avviso: un mutamento di mentalità, una presa di coscienza del mondo agricolo e un convinto progetto politico che parta dalle regioni per essere fatto proprio dal Parlamento dell’Unione e approdi nei regolamenti della commissione.
Alcune misure del precedente piano hanno riscontrato tutta l’approvazione della Comunità europea, altre invece hanno dovuto essere modificate, comunque non credo che queste possano costituire il motivo principale per una preoccupazione del futuro dell’agricoltura. Ritengo infatti importante un raffronto che mi prospetta la realtà della vita quotidiana; proviamo a confrontare la vita dei conduttori di un’azienda agricola, del contadino, degli operatori di agricoltura di montagna con quella dei dipendenti statali, regionali o di altri enti pubblici con stipendio, pensione e mutua assicurati; proviamo a confrontare l’impegno per il lavoro, gli orari, le giornate, i festivi, confrontare la sicurezza e la tranquillità dello stipendio a fine mese, confrontare la qualità della vita e tante altre cose, forse il mio è un ragionamento semplicistico, banale, ma è quello che affronto nella discussione con gli amici che ancora lavorano nel mondo agricolo.
In conclusione sono venuto a conoscenza grazie all’Assessore Perrin di un documento trasmesso dal Segretario comunale di Challand-Saint-Anselme al quale va il mio ringraziamento per la sensibilità e intelligenza di aver colto questo documento e averlo trasmesso all’Assessorato. È un documento che aggiunge una misura molto importante all’interno di questo piano, una misura che non arriva dall’Unione europea, né dal Consiglio regionale, ma dallo Stato ed è una misura che riprende la legge n. 97/1994 ed è contenuta nella legge n. 388, la finanziaria del 2001, che all’articolo 15 dice: "I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto sia dagli enti pubblici che dai privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, le proprie macchine e attrezzature, possono fare i seguenti lavori: lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano in genere, lavori di forestazione, lavori di costruzione di piste forestali, lavori di arginatura, lavori di sistemazione idraulica, lavori di difesa dalle avversità atmosferiche, lavori di difesa dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali per un totale di 50 milioni all’anno".
Questa è una delle forme per la multifunzionalità all’interno del settore agricolo, l’importante è riuscire a trovare chi farà questi lavori.
PrésidentLa parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI)Che questo piano abbia una sua importanza e in particolare un suo peso. Si deduce non solo dal faldone cartaceo che ci è stato consegnato, ma soprattutto dagli impegni finanziari che sono contenuti in calce allo stesso documento: impegni finanziari per un volume complessivo di movimentazione in sette anni che assomma a quasi 1.200 miliardi, dei quali circa 1.000 miliardi consistono in aiuti pubblici, dei quali 800 a carico della Regione autonoma Valle d’Aosta. È quindi un piano che ha una sua notevole importanza, proprio per queste cifre, proprio perché va ad incidere in un settore, in un comparto, quello primario, quello agricolo-zootecnico, che in Valle d’Aosta ha sempre avuto una considerazione particolare.
Se uno facesse ragionamenti squisitamente economici, si troverebbe di fronte a dati paradossali.
Non si può però ragionare solo in termini meramente economici o di valore aggiunto perché se prendiamo i dati della relazione introduttiva e dello studio INEA, in particolare quelli relativi al 1997, vediamo che, a fronte di una produzione lorda vendibile di poco più di 100 miliardi, c’è stato un flusso di interventi pubblici pari a 139 miliardi. Ciò significa che per produrre un valore di 100 lire in agricoltura o zootecnia in Valle d’Aosta si è speso 135.
C’è di più: la produzione lorda vendibile regionale rappresenta solo l’1,5 percento di quella nazionale, vuoi per la ridotta estensione geografica della nostra regione, vuoi per la sua orografia particolarmente accidentata. Inoltre la produzione lorda agricola rappresenta solo il 2,8 percento del PIL regionale, del valore aggiunto complessivo: da ciò ne deriva che se ragionassimo esclusivamente in termini di cifre economiche, diremmo che l’agricoltura non ha senso di esistere.
In realtà sappiamo che non è così, sappiamo sì che l’agricoltura valdostana è fortemente sovvenzionata ed assistita, ma sappiamo che l’agricoltura valdostana realizza anche attraverso i suoi operatori un servizio di cura e di tutela dell’ambiente. E l’ambiente per la Valle d’Aosta è un patrimonio insostituibile.
C’è da dire, sempre ragionando in termini non squisitamente economici, che tuttavia in questi anni passati l’intervento pubblico nel suo complesso è stato particolarmente sostanzioso. Molti fondi dell’aiuto pubblico complessivo sono stati destinati a investimenti, però l’altro dato che ci fa riflettere è quello sul relativo risultato di questi investimenti. E qual è il risultato?
Se l’intento era quello di far sì che il comparto agricolo valdostano non si riducesse in termini di quantità di operatori economici e di qualità del servizio che essi svolgono sul territorio, possiamo dire che questo primo obiettivo non è stato centrato o quanto meno lo è stato solo in parte perché, altro dato significativo, dal 1980 al 1995 un'azienda agricola su cinque ha cessato l’attività e addirittura dal 1995, quando c’erano 7.100 operatori agricoli in Valle d’Aosta, ad arrivare ad oggi vediamo che si sono pressoché dimezzati, tant’è che oggi contiamo più o meno 4.000 operatori.
Quindi c’è un calo di interesse da parte della popolazione attiva valdostana nei confronti del comparto agricolo-zootecnico e sappiamo il perché: la ragione principale è che la redditività di questo comparto è tutt’altro che allettante, soprattutto per le giovani generazioni, e i dati della produzione lorda vendibile ne sono una testimonianza evidente.
L’altra faccia della medaglia che vogliamo sottolineare, in virtù della portata dell’investimento nel corso del settennio, è che comunque gli impegni finanziari del passato non hanno centrato l’obiettivo di far sì che la montagna non si spopoli o non si spopoli eccessivamente, in modo che gli agricoltori possano continuare ad accudire le nostre bellezze ambientali, i nostri pascoli, i nostri prati e naturalmente per trasformare una parte di queste bellezze ambientali in prodotti agroalimentari che servono per la nostra alimentazione e per la loro commercializzazione. Sulla base di questi ragionamenti iniziali vogliamo sottoporre all’Assessore alcune richieste che sono le seguenti. Il documento è complesso ed è anche burocratizzante, è un documento che si articola in assi, sottoassi e misure, secondo una logica di pianificazione che è probabilmente nuova, è comunitaria, alla quale dobbiamo sottoporci perché la Valle d’Aosta fa parte dell’Europa.
Uno dei punti dolenti di questo piano è che pare però più uno strumento di controllo piuttosto che di programmazione, proprio in virtù di questi vincoli amministrativi recepiti e adattati alla nostra realtà. Ci risulta che questo difetto sia stato evidenziato anche da molti organismi associativi che quotidianamente si occupano delle problematiche del settore agricolo e del settore zootecnico.
È un documento complesso, è un documento che ha forse più una funzione di controllo che di programmazione e saremmo grati all’Assessore se riuscisse ad essere più esplicito a questo riguardo, se ha una funzione universale per quanto riguarda la realtà agricola valdostana oppure come si integra con quelle che sono le altre normative, gli altri interventi, le altre leggi, gli altri finanziamenti tuttora vigenti in Valle d’Aosta, mi riferisco ad esempio alla legge n. 30/1984, la legge madre sugli interventi nel settore agricolo. Chiedo come si integra questa legge o altre leggi che sono seguite a questa con tutto questo impianto pianificatorio che oggi andiamo ad esaminare.
Mi pare che la relazione, fatta peraltro in maniera dettagliata, trascuri questo aspetto e non faccia comprendere in modo agevole come si integrano questi strumenti legislativi e finanziari.
Molte risorse contenute nel piano sono estremamente vincolate come settore di destinazione proprio perché devono attenersi a una logica comunitaria piuttosto selettiva e rigorosa.
Altra carenza che abbiamo rilevato leggendo il piano è che non si fa cenno a una sorta di rendicontazione del sessennio precedente: qual è il consuntivo ad oggi dei primi interventi? Mi riferisco al periodo 1994-1999, dove già la Regione ha impiegato i fondi del documento unico di programmazione "Obiettivo 5B". In una frase contenuta a pagina 34 si fa un riferimento sommario, che però non aiuta a comprendere quali siano stati i risultati, perlomeno se ci sia stata coincidenza fra gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e gli obiettivi realmente conseguiti. Si dice a pagina 34 che: "? Per quanto riguarda l’impatto complessivo del documento unico "Obiettivo 5B" è difficile esprimere valutazioni in questa fase in quanto gran parte degli interventi finanziati sono ancora in corso e i loro effetti potranno essere meglio evidenziati dalla valutazione ex-post e comunque non prima del medio periodo?".
Cosa vuol dire questo, Assessore? Sono passati cinque anni dai primi interventi, siamo nel 2001, penso sia ragionevole, anche alla luce di questa vistosa programmazione nel settore, sapere se il passato ha prodotto i risultati attesi oppure no. Sarebbe importante capirlo per sapere se gli investimenti, visto che sono una parte consistente dell’aiuto pubblico complessivo, stanno andando nella direzione giusta, e se i numeri, al di là di quei numeri aridi del valore aggiunto che non possono essere isolatamente considerati, possono essere controbilanciati da un altro fattore e cioè: sì, è vero, il valore aggiunto ha un suo peso specifico che è diverso rispetto a quello di altri comparti, però sappiamo che i nostri investimenti perseguono questo obiettivo, un obiettivo che è di qualità, ma l’obiettivo, per quanto riguarda il mantenimento di giovani o di determinate persone in campo agricolo, non ce l’abbiamo fatta a raggiungerlo perché qui i dati sono inequivocabili, contiamo poco più di 4.000 operatori, dato che è in forte ribasso rispetto già solo all’ultimo quinquennio quando l’Europa cominciava a finanziarci in maniera più consistente e ci permetteva di usare le risorse comunitarie proprio per perseguire una politica agricola più mirata in montagna.
Una delle grosse conquiste è stata quella di riuscire a far distinguere l’agricoltura di montagna da quella di pianura, in quanto non possono essere poste sullo stesso piano: da una parte ci sono sistemi intensivi di coltura con risultati economici che possono essere apprezzabili, che possono essere anche appetibili per le giovani generazioni affinché continuino le attività dei loro padri e dei loro nonni, dall’altra e cioè in montagna abbiamo aziende che hanno dimensioni estremamente piccole, che si pongono in una situazione di mercato marginale, che paradossalmente hanno terreni da coltivare e da accudire che sono molto ampi perché i pascoli e i prati che coprono le nostre montagne hanno superfici di una certa estensione.
Altro punto che vogliamo sottolineare e di cui domandiamo chiarimenti all’Assessore riguarda la gestione delle erogazioni: tutto questo pacchetto finanziario come verrà gestito e come verrà erogato? L’AIMA lascia il posto all'AGEA e noi avevamo già proposto un'interpellanza in materia. L'AGEA avrà delle articolazioni regionali, perlomeno la legge istitutiva lo prevede, qui a pagina 152 si fa riferimento al futuro sistema delle erogazioni e si dice: "? sulla base di appositi elenchi, nel corso dell’annata 2000?" e l’annata 2000 ormai è decorsa "? Le restanti annate?" cioè a partire da quest’anno ad arrivare al 2006 "? saranno probabilmente erogate, previo approfondimento delle incombenze tecnico-operative con gli organismi ministeriali preposti, attraverso strutture regionali?". Non so se sono le strutture esistenti dell’Assessorato oppure se anche in Valle verrà costituito il sistema articolato dell'AGEA sulla base di orientamenti normativi che sono stati anche oggetto di nostre interpellanze. Il nostro settore primario evidenzia anche dei nei, non dobbiamo dimenticarlo.
Non vogliamo ragionare in termini meramente economici, ma possiamo ragionare anche in termini di risultati, di risultati di qualità. Prendiamo ad esempio la filiera lattiero-casearia o quella zootecnica.
Il primo neo della filiera zootecnica è quello della selezione della razza bovina valdostana, più volte definita come il fiore all’occhiello per le sue caratteristiche di rusticità e per il fatto che si possa incrociare con altre razze (abbiamo visto addirittura in Brasile), la cui tutela serve a valorizzare il patrimonio bovino valdostano e le sue peculiarità indiscutibili.
Dal documento che fa da preambolo al piano si legge purtroppo che se la Commissione europea da un lato ha approvato definitivamente il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione, relativamente alla parte generale del piano e alle misure cofinanziate dall'Unione europea e dallo Stato, è stata invece esclusa l’azione 3.3 che riguarda proprio la tutela del patrimonio bovino valdostano, visto che tale azione, così si legge: "? non soddisfa al momento le condizioni di cui al punto 9 dell’allegato regolamento comunitario n. 1.750/1999?".
Questa osservazione non è di secondaria importanza o perlomeno vorremmo capire qual è la portata di questa esclusione proprio in un momento in cui sta imperversando quella sindrome, a cui ha fatto cenno prima l’Assessore, che si chiama "mucca pazza", a fronte della quale anche il gruppo di Forza Italia ha presentato un'interpellanza proprio all’Assessore Vicquéry, il quale ci ha tranquillizzato con la sua risposta dicendo che la razza bovina valdostana, in virtù di un'alimentazione prevalentemente foraggiera, esula da un panorama europeo devastato dalla presenza del morbo in molti allevamenti bovini.
Come mai è stata esclusa la tutela del patrimonio bovino valdostano? Quali sono le ragioni? Qui non sono spiegate e, visto che, nell’ambito di quella produzione lorda vendibile a cui facevo cenno all’inizio, la voce più consistente è riferita alla filiera zootecnico-lattiero-casearia, sarebbe importante sapere come mai questo aspetto importante oggi non rientra nella pianificazione dello sviluppo rurale.
L'altro neo è rappresentato dalla Centrale del Latte. Si tratta di un anello debole sul quale più volte abbiamo insistito: la Centrale del Latte dovrebbe essere il momento in cui si riassume la produzione lattiero-casearia valdostana, ove avviene la trasformazione del prodotto agricolo/zootecnico e la sua valorizzazione in termini commerciali.
Oggi più che mai la Centrale sta soffrendo una marginalizzazione dovuta a fattori che non sono ancora ben chiari. Sono queste le considerazioni che ci sentiamo di fare dopo aver letto il Piano e sulla base di una serie di situazioni che sono più che mai note, che sono più che mai conosciute e dibattute, che sono state anche approfondite, ma che non possono essere escluse solo perché non citate all’interno di questo documento. Naturalmente queste considerazioni, sulla base delle risposte che ci verranno fornite dall’Assessore, staranno a loro volta alla base della nostra espressione di voto. Grazie.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Con questo piano di sviluppo rurale 2000-2006 si ridisegna l’insieme dei contributi e delle misure di sostegno per il mondo agricolo e lo si fa seguendo le norme dettate dall’Unione europea. In questo modo dalle molteplici misure emanate di volta in volta oppure enunciate in modo generico, vedi la legge n. 30/1984 che con queste formulazioni generiche poteva essere adattata ad ogni realtà, da queste varie misure indifferenziate adesso si passa ad un insieme più organico di regole e di interventi, finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale secondo gli obiettivi che sono fissati a livello europeo, obiettivi che ha già illustrato l’Assessore, che riprendo brevemente e che sono elencati nell’articolo 4 del regolamento n. 1.257/1999 a cui il piano rurale fa riferimento.
Si dice che obiettivi dello sviluppo rurale sono "ridurre i costi di produzione", "migliorare e convertire la produzione", "migliorare la qualità", "tutelare e migliorare la qualità ambientale, l’igiene e il benessere degli animali", "promuovere la diversificazione delle attività nell’azienda".
Molti di questi obiettivi erano sottesi all’azione finora perseguita in quanto non credo che finora si volesse perseguire il male degli animali o l’aumento dei costi di produzione oppure si volesse abbassare la qualità; questi obiettivi però erano sottesi all’azione finora perseguita. Ora sono stati definiti in modo esplicito e con linguaggio burocratico – come qualcuno ha sottolineato ed è vero -, un linguaggio che, se non altro, ha il merito della chiarezza. Il piano di sviluppo rurale è stato elaborato proprio su sollecitazione della Comunità europea ed indica le condizioni da seguire per poter accedere ai contributi, per continuare a sostenere lo sviluppo rurale.
D’altra parte, forse era necessaria comunque una pausa di riflessione, un'analisi del percorso fatto finora perché, a ben vedere, i risultati, riportati nel documento di valutazione "ex ante", non sono poi così esaltanti nei confronti di risorse ingenti che sono state impegnate in questo settore. Il documento di valutazione "ex ante" ci ricorda che in valle sono presenti 7.000 aziende ma al sistema informativo agricolo ne risultano soltanto 4.000, comunque di queste 4.000 imprese oltre il 70 percento possiede meno di quei famosi ettari di superficie agricola utilizzata che possono far sì che l’azienda abbia un minimo di redditività autonoma e che possono garantire alla famiglia l’occupazione permanente.
Dai dati risulta che c’è un invecchiamento progressivo degli addetti e questo porta come conseguenza un aumento di voci dei costi di investimento e anche di adeguamento delle strutture a standard igienico-sanitari, comporta alti costi di produzione del latte, praticamente il doppio rispetto a quello italiano in quanto il nostro latte viene a costare 1.387 lire/litro a fronte di 711 lire/litro in Italia.
Il risultato di tutta la politica agricola finora seguita, ripeto, non è stato così esaltante, occorreva comunque intervenire.
Diciamo che il problema non è di facile soluzione anche perché non si può valutare la politica agricola solo in termini di economicità; l’Assessore ha avuto modo forse ieri di vedere su "Il Sole 24ore" un articolo dove si denuncia l’antieconomicità della politica europea in ambito agricolo.
L'autore professore all’Università di Siena, dice che bisognerebbe far cominciare a conoscere ai cittadini europei il costo in termini finanziari della politica agraria: oltre la metà del bilancio dell’Unione europea è speso per un settore che produce meno del 2 percento del PIL; bisognerebbe far conoscere anche il costo di un protezionismo agricolo che negli ultimi 40 anni è costato ai consumatori più della spesa pubblica agricola, come afferma l’OCSE. L'articolista continua dicendo che, a difesa dell’interesse dei consumatori, i dirigenti delle organizzazioni agricole potrebbero anche spiegare ai cittadini perché mai si spendono oltre 2.000 miliardi di lire all’anno per convincere gli agricoltori europei a non coltivare oltre 4 milioni di ettari di seminativi al fine di ridurre l’offerta interna e mantenere un elevato livello di prezzi agricoli. Per cui "le famiglie sborsano da una tasca come contribuenti 2.000 miliardi di lire per lasciare inutilizzato un capitale fondiario stimabile in oltre 50.000 miliardi, al fine di poter sborsare dall’altra tasca, come consumatori, una cifra probabilmente molto maggiore in termini di maggior prezzo di mercato pagato per i prodotti agricoli". È un'analisi della politica agricola europea solo dal punto di vista della redditività.
I colleghi che mi hanno preceduto ricordavano che anche la politica agricola valdostana costa. In Valle l’agricoltura produce all’incirca un reddito di 107 miliardi all’anno che in 7 anni raggiunge la cifra di 7-800 miliardi: si tratta di una cifra inferiore di gran lunga alla cifra che nel piano si prevede che venga spesa per il settore agricolo, quasi 1.000 miliardi in 7 anni, di cui 800, a carico della Regione.
Siamo consapevoli che la politica agricola non può essere calcolata solo in termini di pura redditività; chi analizza solo attraverso questo criterio la politica agricola non ha capito che il settore agricolo non è isolato da tutti gli altri settori.
Sappiamo che, specie in zone molto fragili come la nostra, specie in zone di montagna, l’agricoltura porta con sé dei vantaggi collaterali molto importanti fra cui la cura e la salvaguardia dell’ambiente, la presenza sul territorio di persone che vivono e fanno vivere la montagna. Questo ha un costo per la collettività ed è giusto pagarlo se alla collettività interessa l’ambiente.
Siamo i primi a dire che i TIR che inquinano devono pagare il costo dell’inquinamento ambientale, non devono farlo pagare ai cittadini. Qui si verifica una situazione analoga, ma al contrario, gli agricoltori devono essere pagati per mantenere un ambiente vivo.
Ho letto questo articolo de "Il Sole 24ore" mettere in luce l'importanza di un'alleanza fra agricoltori, consumatori, semplici cittadini, alleanza che non c'è ancora ma che dovrebbe diventare uno degli obiettivi di una politica agricola seria, che si basa sulla consapevolezza dell'importanza della relazione fra agricoltura e ambiente. Intanto devono averne maggiore consapevolezza gli agricoltori, per quanto riguarda il ruolo che svolgono per la collettività e allora si può chiedere agli agricoltori di rendere conto del ruolo che svolgono. È come se dicessimo loro: noi siamo disposti come collettività a darvi tutti gli aiuti possibili perché svolgete un ruolo importante, vi chiediamo alcune garanzie, per esempio la redditività dell’azienda, il rispetto dei minimi ambientali di igiene e benessere degli animali e poi il rispetto di criteri di imprenditorialità con cui gestire l’azienda.
E chiediamo questo non perché sta scritto nei documenti europei, ma perché riteniamo che diano valore a quella attività. Se noi chiediamo a un'azienda che sia gestita in modo imprenditoriale, il che non vuol dire che il contadino diventi manager, è perché riteniamo che quella attività sia importante: però questa consapevolezza non c’è e forse va creata. Come pure credo che manchi la consapevolezza dell’importanza dell’agricoltura da parte anche dei consumatori.
Questo piano cerca di passare da una politica assistenziale, con regole definite di volta in volta, ad una politica di contributi ragionati secondo obiettivi. Questo è il grande salto di qualità che viene fatto e, secondo me, questo salto di qualità deve essere spiegato ai consumatori che sono anche loro dei contribuenti: non dimentichiamo che i soldi che vengono dati agli agricoltori sono soldi di tutti: di questo ne devono essere consapevoli sia gli agricoltori che i consumatori, che come contribuenti contribuiscono a produrre la ricchezza da cui sono tratti gli incentivi. Ci deve essere questa consapevolezza anche negli operatori turistici che devono sentire alleati gli agricoltori.
Ora se questo lo diciamo fra noi in quest’aula, sono solo parole e non servono a niente, invece credo che questa consapevolezza vada tradotta negli interventi previsti dal piano che possono essere declinati in modo diverso, a seconda della finalità con cui li penso e li realizzo. Spero che questa attenzione vada inserita nel momento in cui si attuano di volta in volta i vari interventi. D’altra parte questa stessa consapevolezza di alleanza fra agricoltura e ambientalisti è possibile, ma è possibile se alcuni elementi forti anche dell’attenzione ambientale vengono recuperati. È vero che l’ambientalista deve essere consapevole dell'importanza dell’agricoltore, ma anche quest’ultimo deve essere a sua volta consapevole che col suo lavoro rende un servizio all’ambiente che è di tutti.
Questa consapevolezza deve pertanto diventare trasparenza e conoscenza diffusa degli interventi, delle risorse, anche dei controlli, da qui l’importanza dell'informazione, della comunicazione, della formazione. Forse un piano di questo genere avrebbe dovuto essere discusso anche con gli operatori turistici, con le categorie dei consumatori perché in questo modo si riesce a portare il problema al centro dell’attenzione di tutti. Il mondo agricolo non deve essere un mondo a parte, che ogni tanto dialoga con gli altri settori economici; non è un mondo che va con la mano a pietire, è un mondo che ha un suo ruolo che va riconosciuto, ma che lui stesso deve riconoscersi. Vorrei concludere con la puntualizzazione di alcuni elementi critici: non entro all’interno di tutte le varie misure, mi interessava dare il senso dell'importanza che può avere questo piano, se inserito in un contesto più consapevole di rete.
La fase di transizione, e qui concordo abbastanza con quello che diceva il collega Tibaldi, fra il sistema finora in uso e questo nuovo sistema non è molto chiara; anche in commissione abbiamo provato a parlarne, ma dalle risposte avute e anche dal piano stesso non emerge in modo chiaro come si intenda procedere in questa fase di transizione. Non c’è chiarezza poi sul modo con cui vengono erogati gli interventi, sulla differenza fra il prima e il dopo e anche se alcune cose l’Assessore le ha dette, il quadro generale non è delineato in modo chiaro.
Un altro aspetto non è chiaro: non è stata presa in esame la riorganizzazione dell’Assessorato. Questo piano, a mio avviso, richiede una ridefinizione dell’Assessorato che non potrà più lavorare per compartimenti stagni, come adesso, perché se il piano è unitario e organico, come tenta di esserlo, se le procedure sono, sì, procedure articolate, ma non così tanto differenziate nei vari settori in quanto alcune scelte sono uguali per tutti, allora l'attuale struttura dell'Assessorato è inadeguata a gestire il Piano. Su questa base va ristrutturato l’Assessorato. Spero non si aumenti il personale col pretesto che si devono cercare persone nuove per gestire questo piano perché gli altri devono occuparsi ancora delle altre cose. No, se questo è l’insieme delle politiche dell’Assessorato, tutti si devono occupare del Piano. Questa può essere una provocazione, ma potrebbe essere anche un suggerimento. Vorrei capire quale pensiero è stato fatto su questo tema.
C’è un elemento che avevo già sottolineato nel mio intervento precedente un anno fa. Credo che l’Assessore lo conosca già. In questo piano di così grandi risorse, l'alleanza con l'ambiente, di cui parlavo prima, è una petizione di principio, è un auspicio, è una tendenza, è una strada che si sta percorrendo, ma in cui ci sono pochi paletti chiari. Le stesse osservazioni, che avevo fatto un anno fa alla proposta di piano, me le sono trovate tali e quali nella "Valutazione ex ante": nella parte in cui si individuano gli elementi di coerenza e di incoerenza fra gli obiettivi che il piano si pone e gli strumenti che il piano indica per realizzare gli obiettivi, si dice che: "Il programma non presenta significativi elementi di incoerenza?".
Poi aggiunge: "? Le osservazioni che si debbono fare riguardano tuttavia un singolo elemento. Il regime di cofinanziamento, in quanto per alcune misure si utilizzano deroghe al regime normale, e i massimali dell’intervento pubblico, che in alcuni casi vengono superati attraverso il riferimento a precedenti norme regionali?", come si vede permangono elementi di non chiarezza in questa fase di transizione.
E ancora si legge a pagina 36 del documento: "? considerata la grande importanza strategica attribuita dalla stessa Amministrazione regionale al tema ambientale?" e da qui emerge che oggettivamente è importante il tema ambientale, oggettivamente c’è un'alleanza "? si ritiene di poter affermare che l’attribuzione di una maggior quantità di risorse alle misure strettamente agroambientali sarebbe forse stata opportuna. Infatti, nonostante la già rilevante dotazione finanziaria di queste misure, l’intervento pubblico corrente risulta in contrazione rispetto alla precedente programmazione?".
Se vediamo anche la matrice con cui vengono incrociate fra loro le varie tipologie di intervento, per valutare se effettivamente c’è coerenza fra di loro, e se vediamo la simbologia usata per cui la coerenza viene valutata con una S se è una sinergia a forte interazione positiva, con una I se è interazione solo positiva, con E se equilibrio sostanziale e con C se conflitto potenziale, l’unica colonna in cui si verifica un conflitto potenziale tra le diverse tipologie di misure è proprio l’intersecarsi di tutte le misure con l’obiettivo agroambientale.
Il Piano contiene l'obiettivo agroambientale, però tutte le altre misure che sono previste confliggono con questo, a dimostrazione del fatto che l’attenzione in questo aspetto è ancora limitata rispetto a quella che si dovrebbe avere.
PrésidentJe n’ai plus de conseillers inscrits à parler. La discussion générale est close.
La parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Je remercie avant tout tous les intervenus pour leur apport très intéressant et constructif au débat.
Je voudrais partir par quelques considérations d’ordre général. Bien sûr je partage beaucoup des interventions qui ont été faites et aussi je partage maintes préoccupations qui ont été exprimées par les différents intervenants. A un moment donné il me semblait d'être le responsable d’un secteur à la débâcle quand on parle de 2 pour cent du produit interne brut, quand on parle d'économicité, quand on parle de difficultés du secteur, quand on parle d’adeptes qui sont isolés du contexte. Nous le savons, le secteur agricole est un secteur en crise, d’ailleurs le vieillissement de la population agricole en est un signal, une alerte.
C’est vrai, il y a eu une baisse des entreprises agricoles pendant ces années, mais je crois que, si nous lisons attentivement les données, la Vallée d’Aoste, avec l'attention et les investissements importants qui a mis sur le secteur agricole, a, de quelque façon, sauvegardé jusqu'à ce moment ce tissu sur le territoire, cette présence que tout le monde réclame, à partir de ceux qui ont une attention plus marquée vers l’environnement, à ceux qui ont des préoccupations de nature plus économique, quand même cette présence essentielle? il me semble bien avoir été souhaitée par les différentes interventions.
C'est vrai il y a eu une diminution des entreprises agricoles, mais il y a eu une rationalisation des ces entreprises pendant ces années, donc une augmentation de leur capacité d’entreprise et cela c’est un fait positif.
La réduction des adeptes aussi doit être interprétée comme une rationalisation dans le contexte d'une mécanisation plus poussée. Il y a eu certainement une diminution de la main d’?uvre, la main d’?uvre la plus humble, dans nos entreprises.
Je voudrais rappeler encore que ce document est défini un plan de développement rural, donc cet objectif, réclamé par tout le monde, que l’agriculture ne doit pas être isolée, mais c’est un élément important du contexte de notre Région, c’est un objectif que nous avons ciblé parce que nous ne parlons pas de développement agricole tout court, mais de développement rural en général. Nous allons d’ailleurs prévoir toute une série de mesures qui ne visent pas seulement à améliorer l’entreprise stricte, mais qui visent à améliorer le milieu rural.
Sur la quantité des financements je crois qu'il faudra là aussi faire quelques petites précisions et quelques raisonnements. L’on ne peut pas dire qu’on a destiné à l’agriculture toute cette quantité de milliards; cette quantité de milliards a été destinée au territoire en général et je fais un exemple: si j’ai investi 100 milliards dans l’amélioration foncière sur le territoire, j’interviens aussi pour soutenir des entreprises, une main d’?uvre qui travaille dans le secteur et donc ce n’est pas de l’argent qui va directement à soutenir l’agriculture, c’est de l’argent qui va soutenir un contexte économique général. C’est une réflexion qu’on doit faire.
Certes, le revenu brut de l’agriculture, je l'ai dit aussi dans ma relation, nous inviterait à fermer, dans le sens de dire: "Bon, l’agriculture c’est quelque chose de déficitaire, nous ne pouvons pas la rendre économiquement valable, nous le savons, nous en sommes conscients", mais je crois que là aussi tout le monde a partagé la nécessité de maintenir sur le territoire cette présence humaine qui fournit toute une série de services à l’environnement, à l’entretien du territoire et c’est un préside important et fondamental, fonctionnel au "système Vallée d’Aoste" et pas fonctionnel seulement à lui-même. Je crois que nous sommes d'accord sur ces principes.
Il y a bien sûr la nécessité selon nous - et cela a déjà été aussi en évidence - d’une révision de la politique agricole de l’Union européenne.
Quand on parle de l’agriculture assistée au niveau européen, là j’ai quelques doutes, nous pouvons prétendre qu’on assiste l’agriculture de montagne, mais pas tellement qu’on assiste une agriculture des grandes entreprises agricoles de la plaine car cette dernière n’a pas besoin de la même assistance directe dont nécessite une agriculture faible, une agriculture qui donne aussi d'autres services telle l’agriculture de montagne.
En ce qui concerne la phase de transition, c’est vrai que nous passons d’un système de mesures à un autre système, d'ailleurs nous avons bien prévu cette phase de passage; les mesures prévues par le plan de développement rural vont substituer la loi n° 30 et ses modifications successives.
Il y a un autre dessein de loi qui est en train d’être analysé en ce moment par la Commission européenne, qui concerne de façon spécifique l’élevage, donc nous trouvons ces deux tronçons d’intervention: le plan de développement rural dans lequel nous avons concentré toutes les interventions concernant le monde rural et le monde agricole et le dessein de loi sur l'élevage, sur la zootechnie en particulier, qui se situe à côté du plan de développement rural et qui va soutenir surtout le monde de l’élevage.
La mesure à laquelle M. Tibaldi se référait c’est une mesure de soutien à la race valdôtaine pie noire, qui est une race qui a été définie en voie d’extinction et la programmation passée avait prévu des aides pour le maintien de cette race. A ce moment l’Union européenne est en train de mieux définir quelles sont les races bovines en voie d’extinction et pour ce faire elle se réfère à une classification de la FAO.
Cette classification doit encore prendre en considération notre race, donc il n’y a pas une définition encore précise quant au fait que cette race est en voie d'extinction, donc c'est une mesure qui de quelque façon a été suspendue. Quant à la complexité du document, c’est vrai, c’est un document qui entre dans les détails. Il faut quand même là aussi faire la distinction entre les deux parties du document: l’une concernant les mesures financées par l’Union européenne et par l’Etat, l’autre concernant les mesures régionales. Quant aux premières, des règles précises sont dictées, concernant aussi les comptes rendus et les paiements, ces derniers confiés directement à l'AGEA. C’est vrai que l’on prévoit en perspective l’ouverture de guichets ou de se substituer en tant que Région à la fonction d’AGEA, mais cela n’est pas encore opérationnel et actuellement les paiements sont faits directement par AGEA aux éleveurs.
Nous avons déjà élaboré dans cette période les mesures de l’agroenvironnement qui ont été payées pour l’année 2000 aux éleveurs et nous sommes en train d’instruire tous les dossiers de l’indemnité compensatoire qui sera à payer les prochains mois afférent l’année 2000; donc toutes les sommes publiques disponibles de la part de l’Union européenne et de l’Etat, celles qu’on appelle les sommes exigibles, ont été disponibles à partir de 2000 car nous avons la partie du plan cofinancée approuvée au mois de septembre et nous avons le droit d’accéder à tous les financements, aucun euro a été perdu face à ces mesures.
Je suis d’accord avec Mme Squarzino sur ce binôme agriculture/environnement. Je partage parfaitement ce binôme, cette fonction que l’agriculture, et surtout l’agriculture de montagne, a et dans ce contexte, même si INEA pose quelques problèmes, je crois que les mesures agroenvironnementales sont quand même des mesures importantes.
Nous avons 73 milliards dans les six ans et il faut aussi considérer que, par exemple, l'indemnité compensatoire va dans cette direction, en imposant des conditions à remplir par l'entreprise qui adhère à cette mesure, donc surtout le bien-être des animaux, les minimums environnementaux, la structure minimale d'organisation économique de l’entreprise agricole.
Il y a une nouveauté en effet dans ce plan: il y a des barèmes où l’on fixe des conditions minimales pour qu’une entreprise soit définie "entreprise" et qu’elle puisse avoir droit aux aides et aux indemnités qui y sont prévues.
Je partage donc les préoccupations, surtout vis-à-vis du moment où cette programmation ira terminer, car justement au moment où va terminer cette programmation avec une Union européenne encore plus élargie certainement il y aura de sérieux problèmes d’acquérir d’ultérieures aides pour l’agriculture, mais en ce moment commençons à donner application à cette programmation, à travers laquelle les entreprises agricoles qui ont un équilibre avec le territoire et qui travaillent de façon convenable (et j'ouvre une petite parenthèse: l'Union européenne a introduit le concept de contrat avec les entreprises agricoles, est un contrat entre le public et l'entreprise où l’entreprise est rémunérée et payée pour faire un certain service, voilà pourquoi il y a le contrôle, parce qu’il faut que ce service soit garanti) en sortiront renforcées.
La préoccupation que j'avais déjà énoncée pour les mesures qui n'ont pas été acceptées et qu'on avait proposées dans la première programmation qu'on avait portée à l’attention de ce Conseil, me préoccupent surtout quant à la structure de la coopération agricole. Nous avons bâti notre système sur la coopération; étant donné les dimensions minimales de nos entreprises, la coopération a été une nécessité pour rendre économiquement valables certaines opérations de ramassage et de transformation de lait, de ramassage et de transformation du raisin et les coopératives ont donné un revenu à nos paysans.
Pour l’Union européenne la coopérative est une entreprise normale et donc elle a droit aux mesures qui ne constituent pas une aide au fonctionnement. Cette mesure a été cassée tout de suite, d’où les préoccupations qui sont reprises aussi dans l’ordre du jour qui a été élaboré et qui demande justement à l’Union européenne d’avoir un ?il d’égard pour la politique agricole de la montagne.
Cet engagement, qui est un engagement politique, je crois que nous le pouvons prendre, mais pas tout seuls, donc il faut poser à l’attention d’autres partenaires, d’autres régions alpines ce problème de la montagne qui doit être abordé de façon différente par rapport à la politique agricole générale de l’Union européenne. Le travail en perspective de ces années c’est un travail de nature politique pour aller de quelque façon à faire reconnaître la spécificité de la montagne vis-à-vis d’autres réalités et là c’est un engagement que ce Gouvernement et même le Conseil doit prendre.
Il me semble avoir touché les différents aspects qui ont été sollicités. Pour ce qui est de l’évaluation des investissements précédents, M. Tibaldi faisait référence à l’objectif 5B qui faisait partie de la vieille programmation. C’est un objectif qui est à l’intérieur de l’objectif 2, réservé au développement rural et qui avait touché une partie des communes de la Vallée d’Aoste. Une partie des investissements sont en cours, on est intervenu sur les améliorations foncières, sur la récupération des maisons rurales, sur la voirie rurale et donc ce sont des investissements sur le territoire, sur le tissu rural.
Si nous voulons, c’est le sillon qu’on a tracé pour le développement rural que maintenant nous avons vu à 360 degrés. L’objectif 5B a été un échantillon de ce processus. C’est vrai qu’une analyse devra être faite dans les années à venir.
Cela dit, en partageant les préoccupations qui sont résumées dans l’ordre du jour, j’invite à voter ce document et je rappelle encore l’engagement que l’Assessorat est en train de mettre à l’exécution de ce plan.
Répondant à la Conseillère Squarzino j'avoue que jamais comme dans cette période, dans la formulation de ce plan, les bureaux de l’Assessorat ont dû travailler ensemble. Le plan de développement rural est le résultat d’un travail synergique des différents bureaux de l’Assessorat et donc ça a engendré une réorganisation à l’intérieur de l’Assessorat pour arriver à ce résultat et même les délibérations d’exécution du plan demandent de la part des bureaux un effort supplémentaire et surtout de la concertation à laquelle peut-être ils n’étaient pas habitués auparavant. Cela donc représente un processus dynamique naturel aussi dans la façon de travailler de notre Assessorat.
Donc nous sommes engagés à réaliser les mesures du plan, financées avec des chapitres spécifiques qui seront transformés par une délibération du Gouvernement dans la phase de réalisation. Quant aux mesures nouvelles prévues dans le plan de développement, on avait prévu sur le budget 2001 un chapitre avec 5 milliards.
J’annonce que probablement avec l’inondation et la nécessité d’engager de l’argent pour la reconstruction nous ne pourrons pas démarrer en 2001 avec les nouvelles mesures mais, étant donné que dans le budget triennal on avait déjà prévu la même somme pour les années à venir, il y a l’engagement à réaliser les nouvelles mesures en 2002.
PrésidentA défaut de déclarations de vote, je soumets au vote l’ordre du jour:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je rappelle au sujet du plan de développement rural que son adoption a lieu par une seule votation qui comprend le texte du plan et toutes les pièces adjointes.
Conseillers présents: 30
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.