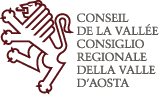Oggetto del Consiglio n. 1587 del 3 novembre 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1587/XI Esame dei vari aspetti legati all'alluvione del 14, 15 e 16 ottobre 2000. (Presentazione di risoluzioni)
Président Chers collègues, le Conseil est convoqué en session extraordinaire dans la journée d'aujourd'hui pour examiner les différents aspects liés à l'inondation des 14 et 16 octobre 2000. Les communications du Président du Conseil auront lieu lors de la session ordinaire qui est convoquée pour les 15, 16 et 17 novembre prochain.
La parole au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)L'evento alluvionale del 13-16 ottobre scorsi è stato sicuramente di dimensioni eccezionali: il Prof. Butera del Dipartimento di idraulica del Politecnico di Torino, che aveva analizzato l'evento nel 1993 su incarico dell'Amministrazione regionale, ha valutato la piena rapportandola a tempi di ritorno di 500 anni.
Oggi abbozziamo un'analisi che non potrà certo esaurirsi con questa seduta del Consiglio regionale, ma che dovrà vedere coinvolta, ai vari livelli, l'intera Comunità valdostana perché quanto è successo, in relazione anche all'evoluzione generale del clima, potrebbe ripetersi con una frequenza non immaginabile fino ad oggi, con tempi di ritorno e con gravità dei fenomeni imprevedibili, rispetto a cui bisognerà cercare di essere pronti.
A tutto questo dobbiamo aggiungere le condizioni che definirei predisponenti del territorio valdostano: la sua conformazione geologica e l'orientamento orografico della regione.
Le cause scatenanti dell'evento sono da individuarsi nelle condizioni meteorologiche, in particolare nella pluviometria e nella quota dello zero termico che hanno caratterizzato le giornate dal 13 al 16 ottobre scorso.
Credo sia importante, preliminarmente, fissare alcuni concetti per poter meglio comprendere quanto è avvenuto.
L'analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche è illustrata in una relazione che farò pervenire al Consiglio non appena disporrò delle copie. In questa sede voglio evidenziare solo che dal pomeriggio di venerdì 13 ottobre, pressoché in tutto il territorio regionale, ma con particolare intensità nel bacino di Cogne, hanno avuto inizio le forti precipitazioni che hanno determinato l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua.
Si è verificato contemporaneamente un rialzo dello zero termico da 2.700 a 3.500 metri.
Il perdurare delle precipitazioni ha generato come conseguenza un forte e continuo apporto delle aste secondarie alla Dora Baltea prolungato fino alla fine dell'evento.
L'onda di piena si è trasmessa dalle valli laterali all'asta principale, nella quale si è registrato il massimo livello, e quindi la massima portata, nel pomeriggio di domenica 15.
Le precipitazioni registrate durante l'evento hanno interessato tutto il territorio e hanno avuto inizio giovedì 12 in mattinata; si sono intensificate, come ho detto, durante la giornata di venerdì 13 e si sono protratte fino al primo pomeriggio di lunedì 16.
L'intensità di pioggia è stata abbastanza uniforme su tutta la Valle con l'eccezione della valle di Cogne e della valle del Lys, nelle quali si sono misurate precipitazioni molto al di sopra della media regionale del fenomeno.
Su base regionale la media delle altezze di pioggia registrate durante tutto l'arco dell'evento è di 220 millimetri caduti; nella valle di Cogne, invece, si sono misurati 460 millimetri.
Il dato che bisogna evidenziare riguarda l'intensità istantanea di pioggia, che è stata da subito molto elevata ed ha raggiunto un primo massimo pari a 16 millimetri all'ora durante la notte fra venerdì e sabato.
Si è poi verificato un graduale decremento di intensità nelle 24 ore successive e nuovamente un picco di intensità, nella notte seguente fra sabato e domenica, di entità paragonabile al primo.
Nel resto della Valle, invece, la media delle intensità massime misurate si è attestata intorno al valore di 10 millimetri all'ora, con massimo di 12 millimetri all'ora e minimo di 8; inoltre si è registrato un solo picco di intensità nella nottata di domenica, in corrispondenza del secondo picco misurato a Cogne.
In sintesi:
- si è trattato di un evento pluviometrico eccezionale, sia per intensità media della precipitazione, sia per durata, sia soprattutto per estensione della perturbazione che ha coinvolto l'intera regione Valle d'Aosta e gran parte del nord-ovest;
- lo zero termico si è mantenuto durante tutto l'arco dell'evento a quote comprese fra i 3.000 e i 3.500 metri. Ciò ha fatto sì che da un lato non si sia formata precipitazione nevosa a quote inferiori e dall'altro la neve già presente sul territorio, caduta durante la perturbazione avuta negli ultimi giorni di settembre, si sia in parte sciolta facendo defluire in alveo un ulteriore quantitativo di acqua;
- i livelli idrometrici raggiunti, come conseguenza di quanto sopra descritto, sono stati tali da superare abbondantemente i livelli di criticità provocando esondazioni.
A questo aggiungiamo la morfologia della Valle d'Aosta che presenta valli di origine fluviale molto strette e ripide e quindi con velocità del flusso d'acqua molto elevate, dove sono enormemente favoriti il trasporto solido e l'erosione al piede dei pendii.
Si sono così innescati fenomeni franosi che hanno ostruito l'alveo dei corsi d'acqua provocandone l'esondazione e in alcuni casi anche lo spostamento dal corso originario.
L'inizio delle precipitazioni ha causato la reazione immediata dei corsi d'acqua i quali hanno contemporaneamente innalzato il loro livello; di grande importanza ai fini del dimensionamento del fenomeno è stato lo scarso sfasamento fra i massimi di precipitazione e i massimi di portata: la pioggia, per la sua estensione, ha determinato un innalzamento dei livelli pressoché contemporaneo nelle diverse valli laterali.
Va sottolineata la rapidità con la quale il livello ha raggiunto il culmine. Dal suo nascere fino al termine del momento di maggior valore di livello sono trascorse due giornate.
Come detto, i fenomeni di pioggia sono stati particolarmente intensi nella valle di Cogne e nella valle del Lys; nelle altre valli laterali, dove l'altezza idrometrica ha raggiunto livelli inferiori, pur rimanendo estremamente significativi, si può riscontrare come l'andamento dei livelli sia simile a quello di Cogne soprattutto per quanto riguarda l'inizio dell'innalzamento e per quanto riguarda il momento in cui è stata raggiunta l'altezza massima, in corrispondenza della mattinata di domenica 15.
Oltre alla rapidità con cui si è verificato l'evento va sottolineato il valore massimo di livello raggiunto che riveste carattere di eccezionalità.
L'apporto di tutti gli affluenti laterali ha provocato l'aumento del livello della Dora Baltea in tempi brevi e con valori eccezionali.
A titolo esemplificativo, ma certamente non esaustivo, segnalo che il picco dell'onda di piena registrato a Cogne, in località Crétaz, ha impiegato circa mezz'ora per raggiungere la stazione di Aymavilles che dista 20 chilometri, da ciò si può facilmente intuire come la Dora Baltea abbia potuto, in un tempo molto ristretto, raggiungere livelli considerevoli.
In sintesi, per quanto attiene l'aspetto idrometrico, si può affermare che, sia per quanto riguarda i bacini laterali che il fondovalle, l'evento è stato caratterizzato dall'elevato livello idrometrico raggiunto in termini di valore assoluto e in brevità dei tempi entro i quali tutto è avvenuto.
Dal punto di vista meteorologico la situazione che si è verificata il 13-16 ottobre 2000 ha presentato diverse analogie con gli eventi alluvionali che hanno colpito la Valle d'Aosta nel recente passato (nel settembre 1993, nell'ottobre 1997, nel giugno 1957).
Sebbene si notino delle analogie con l'evento del settembre 1993 quanto a condizioni meteorologiche, l'evento del 1993 si differenzia dall'evento attuale soprattutto per quanto riguarda l'entità della precipitazione; nel settembre 1993 nei cinque giorni di durata dell'evento fu registrata ad Aosta un'altezza di pioggia pari a 108,4 millimetri.
Per l'ultimo evento si è raggiunta un'altezza di pioggia pari a 263 millimetri in soli tre giorni con intensità massime notevolmente superiori concentrando un volume di acqua maggiore in un arco temporale nettamente minore rispetto ai 5 giorni del 1993.
Oltre all'effetto dell'intensità massima superiore ha giocato un ruolo fondamentale il persistere di temperature elevate in alta montagna: lo zero termico si è mantenuto nel 1993 costante intorno alla quota di 3.000 metri, durante il recente evento è salito a 3.500 metri.
Inoltre l'altezza di pioggia registrata nel 2000, da gennaio a ottobre, appare di gran lunga maggiore rispetto alle medie annue precedenti.
Riferendosi anche ai dati idrometrici significativi si può inoltre affermare che la Dora Baltea ha ampiamente superato nel 2000 l'evento del 1993, dall'analisi delle tracce lasciate dalla piena nella sezione di chiusura del bacino a Tavagnasco si è registrato un livello di 6,5 metri contro i 4,72 metri dell'evento precedente.
Valutazioni effettuate consentono di affermare che la Dora Baltea ai confini fra la Regione Valle d'Aosta e il Piemonte abbia raggiunto un valore di portata dell'ordine di 2.600 metri cubi al secondo, tale valore supera ampiamente quello del 1993 che fu di circa 2.300 metri cubi al secondo.
È statisticamente importante, per valutare l'entità dei fenomeni, assegnare un tempo di ritorno ai valori di portata stimati nell'ambito del territorio valdostano: richiamando il concetto di tempo di ritorno definito come "numero di anni in cui in media una determinata variabile statistica è superata una sola volta", si può affermare che le portate stimate durante il recente evento non sono lontane da quelle statisticamente desumibili come portate con tempo di ritorno di 500 anni.
Le portate stimate a seguito dell'evento alluvionale del 1993 facevano riferimento ad una piena con tempo di ritorno pari a 100 anni.
Concludendo su questi aspetti ribadisco che si è trattato di un evento eccezionale: dalle prime valutazioni fatte l'evento è stato il più violento verificatosi nella nostra regione, non solo stando ai dati disponibili, ma anche a memoria d'uomo.
La notevole entità dei danni prodotti dall'evento alluvionale è stata determinata da una serie di concause fra cui certamente la contemporanea sollecitazione di più bacini in relazione allo stato del suolo.
Fra le cause più influenti che hanno messo in crisi il reticolo idrografico valdostano, oltre al regime di precipitazioni registrato, vanno sicuramente ascritti i numerosissimi fenomeni di frana o comunque di instabilità che hanno contribuito ad aumentare il già cospicuo trasporto solido generando in alcuni casi veri e propri fenomeni impulsivi sulle portate dei corsi d'acqua nel corso della piena.
Inoltre, il trasporto cospicuo di materiale di origine vegetale ha contribuito in maniera determinante a mettere in crisi localmente il sistema fluviale in presenza di attraversamenti quali passerelle, ponti e altre infrastrutture insistenti nell'ambito dell'alveo in piena innescando processi erosivi ed alluvionali di notevole entità.
Lungo le aste torrentizie principali i dissesti sono stati prodotti principalmente sulle conoidi a causa di fenomeni di trasporto torrentizio in massa caratterizzato da un ingente trasporto solido al fondo con accentuati processi di erosione spondale, con notevoli movimenti franosi sui pendii spesso accompagnati da notevole ampliamento della sezione d'alveo.
Il materiale trasportato era spesso costituito da blocchi di grandi dimensioni cui costantemente erano associati tronchi d'albero di alto fusto. Risultano infatti diffusi gli eventi franosi, causati in prevalenza da erosione al piede dei versanti, che hanno provocato in molti casi l'occlusione temporanea dei corsi d'acqua interessati.
Il trasporto solido, alimentato dalle falde detritiche e dagli scoscendimenti dei versanti, considerato che la produzione di sedimenti in questi bacini è sempre molto elevata, ha determinato l'innalzamento del letto provocando la deviazione del torrente con conseguente attacco da parte della corrente a versanti più vulnerabili di quelli, ormai stabilizzati, costituenti l'alveo originale.
Oltre alle esondazioni quindi il sovralluvionamento ha innescato processi erosivi dei versanti anche in quei tratti interessati da deposito di sedimenti. In diversi tratti la piena non è stata contenuta e si sono manifestati fenomeni di alluvionamento su una o su entrambe le sponde ed in taluni casi le acque si sono aperte lateralmente nuove vie di deflusso specie in corrispondenza di attraversamenti stradali quali i ponti o di ostacoli di varia natura.
Gli effetti della piena sono stati così accentuati localmente dall'esistenza di ostacoli al deflusso che hanno fatto sentire la loro influenza anche a livello non strettamente locale provocando aumenti estesi delle altezze d'acqua, aumenti locali delle velocità di corrente con amplificazione dei fenomeni di erosione di sponda o di fondo.
Le intense e prolungate piogge hanno completamente imbibito i suoli a quote elevate, innescando in tale modo numerosissimi fenomeni gravitativi con scivolamento anche di masse considerevoli di terreno.
In diverse situazioni il terreno si è comportato come una lava fluida, in altri casi l'intero blocco si è staccato unitamente alla copertura vegetativa senza scomporsi e dislocandosi solamente in altro luogo più a valle. Le acque piovane hanno ruscellato per più giorni sui pendii creando sedi di scorrimento nei terreni più morbidi e provocando scivolamenti locali della copertura per lo più erbosa.
In molti casi la presenza di un reticolo di raccolta delle acque, per lo più a scopo irriguo, ha permesso di drenare le acque stesse evitando danni, in altri casi proprio la presenza di questi canali ha innescato piccole frane quando la sede risultava in qualche modo occlusa.
Gli attraversamenti viari dei canali e degli impluvi hanno dimostrato spesso un loro sottodimensionamento con una rapida occlusione da parte delle piante trasportate e la successiva erosione ai lati e tracimazione delle acque sulla sede viaria da dove ha raggiunto anche punti lontani dai corsi d'acqua stessi.
Va detto che le opere di consolidamento e di contenimento di frane realizzate in passato hanno operato al meglio; non c'è stata alcuna riattivazione di grandi movimenti franosi che nel passato avevano creato problemi a numerosi centri abitati.
Esiste dunque un insieme di situazioni "naturali" che agiscono sia come cause predisponenti sia come fattori scatenanti e questo indipendentemente dalle azioni antropiche intraprese sul territorio, anche se queste sono evidentemente in strettissima relazione di causa effetto con i danni che si verificano: la conoscenza di tali situazioni è fondamentale per effettuare la prevenzione.
Quando accadono fatti di queste dimensioni giustamente ci si domanda se quanto stiamo facendo è sufficiente per dare le risposte attese. Non voglio dare io la risposta, ma in questa sede voglio evidenziare le attività intraprese dall'Amministrazione per approfondire le conoscenze e migliorare quindi il livello di prevenzione.
Rispetto a tali fenomeni la Regione ha da tempo avviato, in particolare dopo gli eventi del 1993, una serie di attività conoscitive per la loro migliore definizione. Partecipiamo al Programma Interreg IIC, "Prevenzione delle inondazioni", in collaborazione con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e le Regioni Piemonte e Liguria.
Tale progetto prevede la posa di 13 nuove stazioni idrometeorologiche sul territorio regionale, ad integrazione di quelle già esistenti, e la condivisione dei dati idrologico-meteorologici di ogni struttura al fine di effettuare previsioni meteorologiche locali e quindi maggiormente significative proprio al fine di prevedere gli effetti delle perturbazioni meteorologiche. Tale rete sarà operativa dal prossimo anno; durante l'attuale crisi i contatti con le strutture piemontesi sono stati costanti.
Dopo l'evento del 1993 è stato dato un forte impulso anche alla ricostituzione della rete di monitoraggio idrologico regionale che oggi può contare su 12 stazioni di misura, alcune anche meteorologiche ad integrazione della rete specifica che durante il recente evento hanno fornito in tempo reale le informazioni sull'evento delle piene dei principali corsi d'acqua regionali.
Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e idrogeologica del territorio regionale e dei suoi dissesti, è in atto un vasto programma di attività di studio e di ricerca in collaborazione con centri di ricerca e amministrazioni delle regioni limitrofe nazionali ed estere che comprende:
- la raccolta, la selezione e la classificazione dei dati storici sul dissesto idrogeologico posseduti da organismi regionali o nazionali quali il CNR di Torino; tali dati sono organizzati nel Sistema informativo geologico;
- la realizzazione della Carta geologica regionale, cosiddetto "CARG", attraverso rilevamenti geologici originali alla scala 1:10.000;
- la partecipazione al Programma Interreg IIC - Mediterraneo occidentale, Alpi latine, con il Progetto "Prévention des mouvements de versants et des instabilités de falaises".
Il progetto, della durata di due anni e al quale aderiscono amministrazioni ed enti francesi, svizzeri e italiani, prevede un approfondimento nelle metodologie di indagine sui fenomeni dei crolli rocciosi.
Una sintesi delle conoscenze sulla pericolosità idrogeologica del territorio regionale è rappresentata dalla cartografia specifica in scala 1:50.000 allegata al piano territoriale paesistico; successivamente un primo approfondimento delle problematiche è stato effettuato nell'ambito della predisposizione del piano dell'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po, dove è stata prodotta una cartografia in scala 1:25.000 con dei dissesti attivi e potenziali dell'intero territorio regionale.
Rispetto a tale prima perimetrazione i comuni hanno l'obbligo di attivare misure di cautela specifiche in relazione ad eventuali interventi edilizi.
La normativa urbanistica regionale impone l'obbligo ai comuni di dotarsi della cartografia degli ambiti inedificabili perché esposti al pericolo di frana, alluvione o valanga; il termine fissato dalla legge è scaduto ad agosto del 1999, va detto che solo un terzo circa dei nostri comuni ha al momento provveduto.
La Regione, che avrebbe potuto sostituirsi in caso di inadempienza dei comuni, non lo ha fatto in quanto la maggior parte dei comuni stessi sta provvedendo in concomitanza con l'adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale paesistico.
Queste cartografie, determinanti per impedire l'urbanizzazione in aree a rischio, poco aggiungeranno comunque per quanto riguarda le aree già antropizzate alle cartografie del piano dell'assetto idrogeologico del bacino del Po di cui i comuni già dispongono, ma dovranno riportare in scala catastale (1/1.000 e 1/2.000) le situazioni verificandole nel dettaglio.
Ancora con il piano straordinario della legge n. 267/1998, cosiddetto "decreto Sarno", e che si attua in parallelo alla conduzione della fase di osservazioni sul progetto del piano di assetto idrogeologico, sono state individuate e perimetrate le aree a rischio idrogeologico molto elevato, le cosiddette "aree R4", adottando in queste zone le opportune misure di salvaguardia e programmando gli interventi necessari per mitigare il rischio.
Non deve stupire il fatto che i dissesti si siano verificati al di fuori di queste zone; le 12 aree R4 sono state individuate assumendo come elementi essenziali del livello di pericolosità la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato. Le numerosissime altre aree a rischio sono cartografate nel piano di assetto idrogeologico.
È innegabile che lo sviluppo antropico nella nostra regione abbia occupato via via sempre maggiori porzioni di terreno per cui gli eventi naturali, che originariamente potevano causare danni limitati alle attività, ora diventano sempre più catastrofici e lo sono tanto di più quando purtroppo c'è anche la perdita di vite umane.
Nel recente evento è possibile individuare un insieme di realizzazioni sottodimensionate o inidonee che hanno innescato, favorito o aggravato i danni subiti da altre strutture o dal territorio in genere oppure sono state esse stesse distrutte: i ponti, quali ad esempio quello ferroviario di Aosta sul Buthier, quello sulla strada regionale di Valpelline, quello comunale di Issime; gli attraversamenti sulle strade comunali e regionali oppure sull'autostrada; gli insediamenti stessi posti troppo vicino ai corsi d'acqua seppure regimati.
Nei piccoli bacini montani i meccanismi di piena non sono rapportabili ad eventi puramente idraulici, ma coinvolgono notevolissimi trasporti solidi. I piccoli corsi d'acqua sono collassati e hanno determinato un forte trasporto solido e di piante che ha notevolmente aggravato le situazioni mettendo in crisi numerosi grandi conoidi.
Credo sia necessario anche analizzare se l'opera di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua regionali, gli interventi di consolidamento idrogeologico dei suoli e gli interventi di distribuzione delle acque irrigue possono a loro volta essere ritenuti fattori predisponenti gli eventi.
La mia analisi non vuole certo essere una difesa d'ufficio, ma una fredda e obiettiva valutazione di quanto è accaduto e di quanto è stato fatto, in particolare dopo gli eventi del 1993 e del 1994.
Lo studio di analisi idrologica e idraulica dell'evento alluvionale del settembre 1993, condotto dal Prof. Butera e dall'Ing. Fabiani, su incarico dell'Amministrazione regionale, ha fornito, fra le altre, l'indicazione che la miglior difesa sia lasciar divagare il corso d'acqua in tutte le possibili zone di espansione, là però dove sono compatibili con un territorio fortemente antropizzato e dopo aver adeguatamente delimitato e protetto tali aree.
Voglio evidenziare che in questo periodo, cioè dopo gli eventi del 1993 e del 1994, le opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua sono state realizzate in modo mirato a difesa degli insediamenti, spesso a ricostruzione di difese danneggiate o distrutte dagli eventi precedenti, applicando ove possibile nuove concezioni e diverse impostazioni rispetto al passato. Voglio citare la sistemazione della parte terminale del Lys a Pont-Saint-Martin o le sistemazioni delle parti alte dei torrenti di Torrent, Quesseunnaz e Chausettaz in Val di Rhêmes.
La canalizzazione, si dice, aumenta la velocità delle correnti in caso di piena rispetto a quella naturale. In linea generale ciò è vero perché in condizioni naturali la corrente può espandersi su porzioni più vaste di territorio rallentando. È pur vero che l'idraulica ha affinato le metodologie di calcolo per definire le pendenze da realizzare e gli accorgimenti da adottare per limitare il pericolo di erosione, ma le velocità sono per forza diverse.
Bisogna dire che solo nell'ultimo decennio si è rivalutato il concetto di aree di espansione perché si è compreso che i danni causati dalle piene sono di gran lunga maggiori ai valori dei terreni che risultano vincolati per la creazione di aree di espansione.
Certo, con l'ottica di oggi, certi interventi fatti in passato sarebbero certamente da riconsiderare, ma credo di poter dire che siamo appena agli inizi.
Nei nuovi progetti, dopo l'evento del 1993, si è adottato generalmente come criterio quello di governare l'espansione sui terreni circostanti solo al verificarsi del superamento di determinate portate realizzando di conseguenza solo opere di consolidamento dei terreni magari anche totalmente invisibili perché mimetizzate, lontane dalle sponde vere e proprie.
Al di fuori dei centri abitati sono rarissimi i casi di veri e propri argini che devono contenere le piene rispetto a quote superiori a quelle dei terreni circostanti. Attribuire alla "canalizzazione" o "cementificazione" dei corsi d'acqua la causa dei danni è troppo semplicistico: voglio dire con chiarezza che l'attuale assetto del reticolo idraulico valdostano ha scongiurato danni ben maggiori.
Vero è che la pressione antropica ha notevolmente semplificato e soprattutto ridotto il reticolo idrografico cosiddetto minore o naturale, secondo un processo di progressiva riduzione delle aree a disposizione delle acque. Pensiamo poi alla riduzione di quella rete incredibilmente vasta di "ru" oggi ridotta in conseguenza del diminuito utilizzo del suolo ai fini agricoli, ridotta in termini quantitativi, ma soprattutto per quanto riguarda la manutenzione.
A seguito dell'evento del 1993 è stato predisposto un massiccio programma di interventi di sistemazione idraulica che non era ancora concluso all'inizio di ottobre.
Gli interventi realizzati, volti al ripristino di idonee condizioni di sicurezza e di uso del suolo, hanno interessato tutta la regione e le risorse investite sono state considerevoli, stimabili in oltre 50 miliardi.
Tutti gli interventi realizzati nel corso del recente evento alluvionale hanno efficacemente svolto la loro funzione impedendo o limitando i danni.
Nelle zone che avevano patito danni nel 1993 i problemi sono stati limitati, i danni non si sono ripetuti o sono stati contenuti e le opere di difesa, seppure subendo anche danni notevoli, hanno, salvo rare eccezioni, contenuto le acque e svolto la funzione di laminazione loro assegnata.
Credo che rispetto ai conoidi, dove ci sono stati i problemi maggiori, ci si debba interrogare sull'entità che i danni avrebbero potuto assumere in assenza di arginature.
A questo proposito si deve constatare che a Nus il torrente Saint-Barthélemy era l'unico torrente non arginato nel tratto di conoide, solo alcuni modesti lavori di rinforzo delle sponde erano stati eseguiti negli anni '70 e durante le alluvioni del 1993 e del 1994 il vasto bacino idrografico non aveva creato problemi di natura idrogeologica: contenuti movimenti franosi localizzati erano stati bloccati da interventi puntuali di raccolta delle acque superficiali e da drenaggi.
Certo, è vero che in presenza di fenomeni con caratteristiche di eccezionalità come quello che abbiamo subito le opere di ingegneria non bastano; ripeto però che hanno comunque limitato i danni.
Ho letto e sentito in questi giorni alcuni interventi che ascrivono all'incuria in cui verserebbero i nostri torrenti la causa degli straripamenti. Voglio dire che questo non corrisponde assolutamente alla verità. Lo stato dei corsi d'acqua era ottimale per quanto riguarda la pulizia degli alvei e posso dire con assoluta tranquillità che non erano presenti in alveo accumuli significativi di materiali né impedimenti abusivi tali da costituire vero e proprio impedimento al regolare deflusso, né vegetazione di alto fusto tale da poter creare danni.
L'eccezionale quantità di tronchi trasportata dalla piena non è da riferire alla presenza di alberi negli alvei, ma alle frane che hanno interessato ampie zone boscate di versanti limitrofi agli alvei.
La manutenzione delle opere di difesa esistenti era ad un buon livello e non risultavano segnalazioni di particolari tratti arginali strutturalmente carenti.
Rispetto agli attraversamenti dei principali corsi d'acqua va detto che quelli distrutti nel 1993 sono stati ricostruiti secondo sezioni ampiamente cautelative, gli altri che avevano subito una specie di collaudo nel 1993 erano stati ritenuti sufficientemente adeguati, alcuni sono stati purtroppo "aggirati" denotando una carenza di portata causata però dall'eccezionale trasporto di detriti e di piante.
Il sistema idraulico dei torrenti laterali ha funzionato al meglio, specie se rapportato all'evento del 1993:
- sul torrente Grand Eyvia i danni causati dal corso d'acqua sono inferiori, le opere di protezione prima di crollare in alcuni punti hanno svolto il loro compito, la viabilità è stata compromessa in modo meno importante, ricordo che nel 1993, ad esempio, crollò il ponte di Crétaz;
- il torrente Ayasse ha causato danni limitati a valle di Chardonney, in Comune di Champorcher, ma l'abitato è stato adeguatamente salvaguardato dalle nuove opere di difesa; a Hône non si sono avuti problemi per l'Ayasse contrariamente a quanto è successo nel 1993;
- il torrente Lys ha causato gravissimi danni a Champsil, a monte di Gaby, dove non erano stati ancora realizzati i lavori di sistemazione idraulica, per i quali era stata appena avviata la procedura di affidamento, e a Issime, dove la caduta del ponte sulla strada comunale ha indirizzato in modo anomalo le acque, nelle altre località si lamentano danni molto locali, ma le sistemazioni idrauliche, seppure gravemente danneggiate, hanno resistito;
- il torrente Savara e la Dora di Rhêmes hanno causato danni limitatissimi, neppure confrontabili con quelli dei precedenti eventi.
Evidenzio ancora una volta come in questa occasione il trasporto solido abbia giocato un ruolo molto importante, le frane dei versanti hanno trasportato nei corsi d'acqua non solo grandi quantitativi di materiale litoide, ma anche piante che hanno determinato l'occlusione degli attraversamenti.
Il corso della Dora Baltea dalla confluenza del torrente Grand Eyvia scorre fra due sponde ben definite, in parte naturali e in parte dotate di arginature, più o meno parallele e non esistono più aree dove il fiume meandrizza, crea isole formando più bracci nei quali scorrere o attraversa aree acquitrinose.
Questa trasformazione ha permesso l'espansione dei centri abitati, lo sviluppo di insediamenti industriali, la realizzazione delle grandi vie di comunicazione quali la ferrovia e l'autostrada. Bisogna realisticamente dire che non sono più facilmente recuperabili le grandi piane alluvionali, geologicamente chiaramente individuabili, che testimoniano di tale attività della Dora Baltea.
È indubitabile che sono state modificate le caratteristiche di deflusso idraulico della Dora Baltea, cioè i tempi con cui le grandi piene venivano trasportate da un punto all'altro; ritengo però impossibile attribuire alle attività di sistemazione idraulica la causa dei danni causati dalla Dora Baltea, in particolare agli insediamenti della bassa Valle.
Non esistono sufficienti dati e non sono mai state eseguite analisi per dimostrare l'equazione: opere di canalizzazione uguale danni.
L'evento del 1993 ha rappresentato in termini di portata della Dora Baltea un evento record raggiungendo circa 2.300 metri cubi al secondo, il massimo mai misurato alla stazione di Settimo Tavagnasco considerata la stazione di chiusura del bacino valdostano. L'evento precedente più gravoso si era verificato nel 1977 con circa 1.700 metri cubi al secondo e il massimo di circa 2.000 metri cubi al secondo era stato raggiunto nel 1948.
All'evento attuale i tecnici della Regione Piemonte hanno attribuito una portata maggiore a 2.500 metri cubi al secondo confrontabile con i livelli massimi raggiunti durante una tragica piena del 1920, le cui informazioni sono però molto frammentarie e poco attendibili.
Si può quindi concludere che la portata della Dora Baltea è stata eccezionale raggiungendo i massimi mai misurati.
Con queste premesse, la presenza o meno di un attraversamento, seppure sottodimensionato, non poteva fare la differenza nel tratto a valle di Montjovet, la fuoriuscita delle acque sarebbe avvenuta lo stesso, magari con differenze di qualche minuto in più o in meno; le opere di protezione hanno semplicemente dato il tempo di effettuare le evacuazioni necessarie anzi, rispetto all'evento del 1993, meno gravoso come portata, si è potuto verificare che a monte di Montjovet le opere realizzate hanno consentito che non si ricreassero le stesse numerose situazioni di interruzione della viabilità.
Dopo il 1993, con l'approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali, le opere di difesa spondale della Dora Baltea vanno considerate nel loro insieme come un sistema complesso destinato a contenere in alcuni punti la portata e a governare l'esondazione delle acque in altre. Il sistema di difesa è infatti basato su opere di contenimento anche estese quali quelle di Aosta, di Montjovet in sponda sinistra, di Verrès e di Issogne, purtroppo non ancora ultimate, e in aree di laminazione delle piene per le quali valgono vincoli di inedificabilità posti con l'approvazione del piano, le cosiddette "zone A", e le misure di protezione civile per gli insediamenti esistenti ricompresi nelle fasce B e C, quali le piane di Montjovet, di Verrès, di Arnad e di Donnas in sponda destra.
Per quanto riguarda le attività che abbiamo posto in opera nei giorni successivi all'evento, queste hanno interessato essenzialmente il ripristino della viabilità anche attraverso l'esecuzione di opere provvisorie. Abbiamo offerto ai comuni il supporto tecnico nell'attività di ripristino delle infrastrutture e dei servizi primari, la definizione e l'attuazione di interventi urgenti di disalveo, ricostruzione dei manufatti di difesa spondale distrutti o danneggiati al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità nelle zone antropizzate.
Abbiamo quindi iniziato la ricognizione puntuale dei danni attivando il confronto con tutti i comuni per la definizione di un programma di ricostruzione articolato per priorità di intervento e compatibile con le risorse finanziarie disponibili.
Sono in corso gli incontri con i comuni per definire il programma dei lavori urgenti ai sensi dell'ordinanza della Protezione civile e quelli di somma urgenza ancora da realizzare. Nell'immediato gli interventi riguardano essenzialmente la ricostruzione di manufatti danneggiati con interventi da realizzare con la massima urgenza in un arco temporale di breve periodo, entro cioè la fine dell'anno.
Sarà essenziale identificare e censire tutte le situazioni che sono state causa di problemi e non solo per le opere che dovranno essere rifatte perché gravemente danneggiate, ma anche per quelle che pur non demolite hanno provocato ostruzione e altri problemi, per le quali dovranno essere studiati ed apportati i correttivi necessari. Questo dovrà essere uno degli impegni prioritari.
Per quanto riguarda gli alvei, il materiale litoide depositato nei tratti a minore pendenza ha provocato fenomeni di sovralluvionamento. Le condizioni sono ancora tali da non permettere, se non nei bacini laterali, di identificare le aree a maggior pericolo.
Si opererà quindi secondo due direttrici: asportando il materiale laddove esso costituisce un ingombro al regolare deflusso delle acque nei tratti in cui le opere di difesa spondale non hanno subito danni rilevanti e delimitando quindi il letto del corso d'acqua e creando una sede per il corso d'acqua ove questo ha divagato mediante la sola movimentazione dei materiali sulla sponda.
L'asportazione, limitatamente ai soli quantitativi in esubero, verrà fatta al momento in cui saranno stati realizzati gli interventi di sistemazione complessiva delle aree che potrebbero sicuramente necessitare di materiali inerti per i riempimenti e la formazione delle sezioni definitive.
La movimentazione comporterà nei punti più pericolosi anche la costituzione di protezioni provvisorie con masse alla rinfusa per limitare i fenomeni erosivi.
Le linee di intervento da seguire per l'attività di ricostruzione deriveranno direttamente dai criteri definiti dagli strumenti di programmazione a livello di bacino contenuti nel piano dell'assetto idrogeologico.
Il piano definisce e programma le azioni attraverso una valutazione unitaria dei settori con l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio, conseguire il recupero degli ambiti fluviali quali elementi centrali dell'assetto territoriale del bacino idrografico, raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti.
Le linee di intervento da perseguire, coerenti con le indicazioni del piano, dovranno tendere a:
- proteggere i centri abitati e le infrastrutture rispetto ad eventi di piena gravi in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori compatibili;
- mettere in sicurezza gli abitati e le infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- privilegiare per la difesa degli abitati interventi di laminazione controllata come ad esempio le briglie selettive all'apice dei conoidi al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali;
- mantenere in efficienza i sistemi difensivi ed assicurare l'affidabilità nel tempo degli stessi assicurando la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei;
- promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale per la difesa dei fenomeni di erosione e di frana;
- ridurre ove possibile le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.
È chiaro che si dovranno attuare le azioni necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio conseguendo ogniqualvolta sarà possibile il recupero ambientale degli ambiti fluviali, stabilendo condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti.
In questo quadro dovremo definire le azioni e gli obiettivi specifici per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e dei versanti interessati dagli eventi alluvionali.
Il criterio fondamentale di intervento è rappresentato quindi dal mantenimento e dalla salvaguardia delle aree esondabili disponibili in corrispondenza di zone meno di pregio che permettano al corso d'acqua di espandersi lateralmente riducendo i valori di portata in transito nel corpo idrico. Tale criterio, oltre a garantire al corso d'acqua la propria libertà di divagazione, consente soprattutto di apportare un beneficio nel tratto di valle costituito da un abbassamento dei livelli idrici di piena.
Particolare importanza assumono poi i sistemi per il controllo del materiale solido che può essere eroso sulle sponde dei versanti. Dovranno essere pertanto previste, specie nei bacini montani, idonee strutture per il contenimento del materiale trasportato dalle acque.
Dove il corso d'acqua ha radicalmente mutato il suo corso oppure ha occupato sezioni rilevanti, notevolmente superiori a quelle precedenti, sarà necessario intervenire con molta cautela nel ripristinare le sezioni di deflusso o gli alvei originari.
Tali situazioni dovranno essere studiate e valutate puntualmente anche in relazione ai risvolti di tipo urbanistico.
Attenzione particolare dovrà essere riservata alla sistemazione dei conoidi e ai livelli di sicurezza conseguibili in relazione all'utilizzo degli stessi. È di tutta evidenza che le situazioni preesistenti non potranno essere riprodotte.
La normativa urbanistica vigente prevede l'adozione da parte dei comuni della cartografia delle aree inedificabili, in quella sede dovranno essere date le risposte.
Per i comuni che già ne dispongono sarà necessario aggiornare le cartografie che, ricordo, prevedono una graduazione del rischio tenendo conto di quanto è accaduto.
Per i comuni che ne sono sprovvisti, prima di autorizzare gli interventi di ricostruzione, dovranno comunque essere definiti tali ambiti almeno per quanto riguarda le zone interessate dall'evento.
Questo è quanto è stato fatto dopo la valanga di Dialley a Morgex.
Il disegno di legge n. 75, che rivede la normativa regionale in materia di protezione civile, attualmente in corso di notifica alla Commissione europea e che contiamo di poter proporre all'approvazione del Consiglio quanto prima, contiene una norma che dispone l'obbligo per i comuni di rivedere la perimetrazione degli ambiti inedificabili e relativamente alle porzioni di terreno interessate dall'evento entro sei mesi dallo stesso introducendo al tempo stesso una norma di salvaguardia che limita alla manutenzione e al ripristino dei servizi primari gli interventi possibili prima della nuova perimetrazione.
Fatta la perimetrazione si inserirà il discorso riguardante la delocalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture a rischio. Si tratta di una questione da prendere sicuramente in considerazione, ma che non enfatizzerei troppo.
Delocalizzare significa prima di tutto reperire nuove aree disponibili, evidentemente poste in zone sicure, ma anche normare procedure non semplici e aspetti delicati come ad esempio gli indennizzi e non sarà facile. Bisognerà comunque provarci.
Questo sarà certamente un tema che i comuni dovranno affrontare nella revisione già in corso o da iniziare dei loro piani regolatore per il loro adeguamento al PTP.
In relazione alla supposta mancata predisposizione da parte della Regione del piano di rilocalizzazione, così come previsto dal "decreto Sarno", vorrei fare una puntualizzazione: è importante sapere che alla base di tutto sta l'individuazione delle infrastrutture e dei manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Questo, prima degli avvenimenti di metà ottobre, era previsto che fosse fatto nel piano stralcio di bacino che al momento è in fase di adozione, è stato trasmesso dall'Autorità di bacino direttamente ai comuni nel giugno 1999 per acquisire le eventuali osservazioni.
La conclusione dell'iter approvativo non dipende solo dalla nostra Regione. A livello di Autorità di bacino, unitamente alle altre Regioni e con l'accordo dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, è stato concordato di prolungare i tempi di esame per approfondire nel dettaglio le perimetrazioni delle aree in dissesto.
Come Regione si era tentato di dare applicazione alla legge n. 228/1997 che prevede la possibilità di rilocalizzazione per le attività produttive esistenti nelle fasce a rischio di esondazione limitatamente al corso della Dora Baltea, prevedendo per questo finanziamenti a tassi agevolati. L'iniziativa non ha sortito gli effetti sperati in relazione soprattutto alla difficoltà di reperimento di aree alternative.
Per quanto attiene invece ai 2.000 miliardi citati dal Ministro Mattioli, che sarebbero stati messi a disposizione dallo Stato, aspettiamo con curiosità che ci venga indicata la loro allocazione nel bilancio statale e la quota disponibile per la nostra Regione.
Voglio ora dire, concludendo, che non è mai mancata da parte del Governo regionale l'attenzione alle problematiche legate al territorio. La creazione del nuovo Dipartimento territorio e ambiente con il raggruppamento di tutte le strutture che hanno competenza in materia di assetto del territorio, di difesa del suolo, di cartografia, di urbanistica va nella direzione anche da altri indicata di trovare momenti di confronto e coordinamento in materie che devono obbligatoriamente essere gestite in modo coordinato.
Anche gli investimenti sono sempre stati considerevoli ponendo sempre molta attenzione alla possibilità di integrare le nostre risorse con quelle messe a disposizione dallo Stato nel settore.
En passant, voglio dire che oggi l'Amministrazione regionale può contare sull'apporto di sette geologi dipendenti rispetto ai due del 1993.
Certo, si può fare meglio e bisognerà fare meglio soprattutto in termini di previsione del rischio. Dovremo investire ancora molto sia per quanto attiene alla conoscenza e alla previsione sia in termini di risorse umane e per quanto riguarda la realizzazione di opere di difesa, protezione e consolidamento dei versanti. Le strutture che si occupano di queste questioni dovranno essere ulteriormente potenziate.
Sicuramente nella gestione dell'assetto del territorio abbiamo complessivamente come Comunità valdostana commesso errori e forse sottovalutato situazioni fidandoci o forse sopravvalutando le garanzie offerte da alcune opere. Certo è che dobbiamo renderci conto del fatto che sta venendo meno la "cultura del territorio" intesa come conoscenza complessiva del territorio e coscienza dei rischi connessi allo stesso, cose queste che erano invece patrimonio acquisito e posseduto, parte integrante dell'essere dei nostri vecchi.
Dobbiamo anche comunque avere coscienza, questo lo dico non per malcelato fatalismo o rassegnazione, ma per obiettiva e forse anche banale constatazione che le montagne sono sempre venute giù e mai andate in su!
PrésidentLa parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Au rapport de l'Assesseur Vallet, avec ses éléments de réflexion et ses considérations, il serait utile d'ajouter également un article publié sur "La feuille d'annonces de la Région de la Vallée d'Aoste" au mois d'octobre 1846. Des réflexions qui, à l'époque, ne prenaient pas en considération les phénomènes d'urbanisation ou d'intervention sur le territoire, concernant les inondations de la mi-mai 1845, trop connues pour les dégâts qu'elles ont causés dans plusieurs hameaux et de vastes campagnes, plus de 180 personnes y ont trouvé la mort, aussi que des inondations du 18 octobre 1846.
Il s'agit de considérations exprimées par l'abbé Vescoz qui doivent nous faire réfléchir et qui peuvent nous amener à ces conclusions que nous souhaitons pour dégager des perspectives pour le futur.
Je voudrais quant à moi, à titre de complément des communications que j'avais présentées à cette Assemblée lors du Conseil précédent, formuler encore quelques réflexions en guise de mise à jour, surtout pour donner à tous les collègues les renseignements nécessaires concernant les diverses facettes des événements de ces dernières semaines.
A cet égard je demanderais au Président Louvin de bien vouloir distribuer à tous les collègues un recueil, que nous avons préparé, des principales mesures que nous avons adoptées au cours de ces dernières semaines de façon que tout le monde puisse se rendre compte du travail accompli.
Il y a trois volets dans ce recueil qui ne comprend pas toutes les dispositions mais les principales concernant l'alerte, ensuite l'organisation de l'urgence et enfin les mesures et les disponibilités financières des dispositions étatiques, mais je reviendrai sur ce thème quand je présenterai les mesures spécifiques que nous avons mises au point.
En tant que complément des communications que j'ai présentées lors de l'assemblée précédente, nous pouvons aujourd'hui affirmer que la phase la plus critique a été dépassée avec le rétablissement presque partout des conditions normales ou un retour à une normalisation progressive et ce, grâce à l'action efficace, rapide, très appréciée par la population, à l'aide de milliers de secouristes venus d'Italie, de France, de Suisse sans oublier les personnes directement touchées par l'inondation, les collectivités locales, tous les Valdôtains, les forces de l'ordre, le Corps forestier, le 118, le secours alpin valdôtain, les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les employés de l'Administration régionale, la Croix Rouge, les associations de bénévolat et les volontaires, les militaires, la Protection civile, ceux qui ont fait partie de l'unité de crise, donc tous les Valdôtains qui, sans ménager leurs efforts, se sont aussitôt mis au travail.
Au cours de ces derniers jours, la réflexion qui m'a le plus frappée a été celle du Responsable de l'Unité d'intervention de la Province de Trento. C'est une unité mobile qui a participé à toutes les opérations de secours et d'intervention dans différentes zones sinistrées. Ce responsable, formulant des commentaires sur le travail qu'ils avaient effectué, en présence du Président de la province, Dellai, a affirmé qu'ils s'étaient trouvés dans la condition d'aider les gens et que donc si leur intervention avait été utile, elle n'assumait pas le caractère de l'indispensable, à savoir que même sans leur intervention la communauté locale s'était déjà mobilisée. C'est le commentaire le meilleur concernant cette grande mobilisation que le Val d'Aoste a connue.
C'est souvent dans les moments de difficulté que des liens durables se créent entre les personnes, entre les institutions; personnes et institutions qui ont la possibilité de mieux se connaître et de se rapprocher davantage.
Et là nous ne pouvons encore une fois qu'exprimer notre appréciation, notre gratitude et nos remerciements pour le travail qui a été accompli. Nous avons tous été particulièrement touchés par ces marques d'attention, d'amitié, de solidarité et nous sommes convaincus que cette action restera à jamais gravé dans l'histoire du Pays d'Aoste, dans la mémoire et le c?ur de ses habitants.
Par ailleurs, au cours de ces semaines-là les secours ont bien fonctionné et un énorme travail a déjà été accompli. Avec cette semaine, au plus tard avec la semaine prochaine, dans toutes les communes, les premières interventions seront achevées. Reste une situation encore critique du point de vue des réseaux d'égout et d'adduction d'eau à Nus, mais là aussi les temps sont définis pour que l'on retrouve des conditions normales de fonctionnement.
Nous nous sommes fixé deux objectifs, tout en étant conscients de devoir apprendre à mieux nous protéger des désastres futurs et ce, en termes de sécurité, de prévention, d'aménagement du territoire. Et les deux objectifs consistent, tout d'abord, à assurer au plutôt la remise en état de notre région; on s'est fixé comme terme la fin novembre ou le début décembre de façon à ne pas empiéter sur le début de la prochaine saison touristique et ensuite soutenir, encourager la reprise des activités économiques en évitant ainsi qu'une catastrophe physique se transforme en catastrophe économique.
Les dégâts en effet sont importants. Nous avons procédé à une première estimation de ces dégâts et nous avons pourvu dans la journée d'hier à le transmettre au Département de la Protection civile à Rome. Pour ce qui est des dommages des différents secteurs productifs nous pouvons estimer à plus de 60 milliards de lires ceux concernant l'agriculture, à une centaine de milliards de lires ceux du secteur industriel, à 45 milliards de lires pour le secteur de l'artisanat, à 10 milliards de lires pour le commerce et le tourisme et à 10 milliards également pour les sociétés de remontées mécaniques.
Pour ce qui est des infrastructures, des ouvrages des collectivités locales ou de l'Administration régionale touchées par l'inondation, l'on peut là estimer les dommages à quelque 800 milliards de lires. Donc, nous arrivons, en considérant uniquement ces données, vu que nous n'avons pas pris en compte le rétablissement des liaisons vers l'extérieur, c'est-à-dire le chemin de fer, la route nationale, l'autoroute ni les dommages causés dans les réseaux de télécommunication, d'adduction d'eau, de conduite de gaz ou l'oléoduc, nous pouvons affirmer sans crainte d'être démentis, qu'ils dépasseront les 1.000 milliards de lires.
La situation des personnes qui ont dû être évacuées et qui sont sans abri en raison des maisons écroulées ou endommagées, est aussi en train d'être définie. Nous avons eu quelque 7.000 personnes qui ont été évacuées. A la date d'aujourd'hui nous sommes à même de prévoir combien de familles seront intéressées à moyen et long terme par ce phénomène. Il y a donc sur la base des données qui ont été recueillies par la Croix Rouge quelque 172 familles qui sont encore concernées; pour 69 d'entre elles nous prévoyons une rentrée et donc qu'ils retournent chez eux après 6 mois, et 93 dans les 6 mois.
Il y a également 916 familles qui sont encore hors de chez elles; on prévoit qu'elles pourraient rentrer dans un délai d'une trentaine de jours; il y a ici les 900 familles de Nus, qui est la situation la plus critique. Enfin il y a 229 familles qui sont encore évacuées et qui sont concernées par le plan d'évacuation des zones à risque, principalement la commune de Pollein.
Je disais, quelques points critiques demeurent: Pollein, Nus, Epinel, Gressoney, Saint-Barthélemy, le chemin de fer, mais nous sommes en train d'aller vers une normalisation progressive.
Quelle est l'activité que nous avons déployée concernant les mesures gouvernementales, la présentation du budget pour l'année 2001 et l'organisation des interventions concernant les remboursements pour les gens et les activités endommagées?
Pour ce qui est des mesures du Gouvernement, un arrêté de la Protection civile avait attribué 150 milliards de lires pour les premières interventions. Ces 150 milliards de lires ont été élevés à 200 milliards de lires, dont 45 attribués au Magistrato del Po, 1 milliard pour les sapeurs-pompiers, 1 milliard pour les forces armées et 3 milliards en tant que fonds de réserve; par contre les 150 milliards ont été répartis entre les différentes régions: 40 milliards à la Vallée d'Aoste, 60 milliards au Piémont, 18 milliards à l'Emilie Romagne et à la Lombardie, 7 milliards à la Ligurie et à la Vénétie.
Il y a eu aussi la répartition des 40 milliards engagés toujours par cet arrêté concernant la contraction d'emprunts pour accélérer la reconstruction des zones sinistrées: 9,5 milliards à notre Région, 14,5 milliards au Piémont, 4,2 milliards à l'Emilie Romagne et à la Lombardie, 1,8 milliards à la Ligurie à la Vénétie et 4 milliards en tant que fonds de réserve.
A ces fonds il faut ajouter les fonds que nous avons déjà engagés, à savoir les 27 milliards auxquels s'ajouteront 5 autres milliards, donc 32 milliards disponibles immédiatement pour faire face à cette urgence.
Nous avons sollicité la publication de cet arrêté avec la directive y afférente; de concert avec nos Parlementaires, nous avons également présenté des propositions de modification. L'Assesseur Vallet a déjà illustré l'iter de présentation à cette Assemblée de la nouvelle loi concernant l'organisation du système de la Protection civile au Val d'Aoste; nous espérons, avoir l'avis favorable de cette dernière de façon à présenter ce projet de loi à votre attention et à votre approbation lors de la séance de la prochaine assemblée, compte tenu des délais et de la nécessité de disposer d'un cadre législatif défini pour pouvoir intervenir en faveur des sinistrés.
Mais nous sommes intervenus aussi pour ce qui est de la conversion en loi du "décret Soverato". Dans le recueil vous trouverez toutes les propositions d'amendement que nous avons présentées, toujours de concert avec nos Parlementaires, avec le texte unifié des propositions formulées par la Conférence des présidents des régions. Ce texte inclut les propositions formulées par le Piémont ainsi que celles formulées par notre Région concernant le report des échéances et des différents délais, aussi que les mesures en faveur du système économique, ces amendements ne seront probablement pas pris en considération lors de la conversion du "décret Soverato".
Selon nos derniers renseignements seulement quelques amendements concernant les dispositions d'ordre fiscal et le report des échéances, seront acceptés; par contre toutes les autres mesures seront inscrites dans un décret spécifique pour les Régions du nord-ouest de l'Italie qui ont été touchées par les inondations d'octobre.
Enfin, même vis-à-vis de l'Union européenne, nous avons sollicité un report des délais prévus pour la réalisation des différents programmes communautaires; la nouvelle période de planification des fonds structurels de l'Union européenne prévoit que si les délais fixés ne sont pas respectés , les financements sont automatiquement retirés. Nous allons donc demander à bénéficier d'un report de ces délais pour éviter de compromettre la réalisation de nos programmes.
Dans le cadre des programmes communautaires, l'autre jour à Turin nous avons signé le nouveau Programme "Alcotra 2000-2006 Interreg III" concernant les projets de coopération transfrontalière et dans ce programme il y a des mesures spécifiques concernant notamment la mobilité, le système des transports et le territoire que nous considérons prioritaires pour intervenir dans cette phase de la reconstruction.
Je dois également présenter les orientations de la majorité et du Gouvernement concernant le budget qui sera présenté la semaine prochaine à la IIème Commission de façon que tous les conseillers puissent disposer du temps nécessaire pour l'examiner. Nous regrettons qu'il ne s'agisse pas du mois canonique qu'on avait concerté au cours de ces années, mais vous comprendrez que ces événements nous ont obligés à redéfinir notre planification; nous nous sommes efforcés en tout cas de faire au plus tôt ces réflexions de façon à vous laisser un délai suffisant pour approfondir et pour examiner le budget.
Nous avons redéfini notre planification et nos objectifs, notamment nos priorités, tout en considérant deux objectifs prioritaires: c'est-à-dire la remise en état de notre pays et le soutien aux activités économiques; il n'y aura donc pas d'augmentation de pression fiscale; une attention tout à fait particulière sera encore accordée aux collectivités locales qui seront les acteurs principaux de cette phase de reconstruction; des mesures d'aide aux investissements sont également prévues tout en sauvegardant les aspects sociaux qui caractérisent depuis toujours notre budget avec une rigueur pour ce qui est des frais de fonctionnement, en essayant de qualifier nos dépenses et surtout de mettre en premier lieu les aspects liés à la sécurité, à la prévention et à l'aménagement du territoire.
Nous avons prévu par ailleurs des mesures spécifiques dans la loi de finances que nous présenterons; il y a un titre concernant des mesures liées à l'inondation d'octobre 2000, consistant, tout d'abord, en un fonds spécifique de 250 milliards sur les trois années, 100 milliards 2001, 100 milliards 2002, 50 milliards pour 2003 pour réaliser nos interventions; ensuite des mesures que nous pouvons définir de rationalisation quant à la disponibilité de nos ressources financières.
Une attention particulière pour mieux utiliser toutes les ressources dont nous disposons et ensuite des mesures spécifiques concernant les investissements. Nous avons concerté avec les communes qu'une partie des fonds qui leur sont attribués, devrait être prioritairement assignée aux communes sinistrées et donc nous avons défini pour les investissements, mais aussi pour d'autres mesures, une priorité aux zones touchées par l'inondation.
Toutes les activités et les personnes concernées auront aussi une priorité dans les différentes mesures, que ce soit pour les projets d'investissement ou pour l'accès aux différentes mesures de financement concernant par exemple la maison ou la loi n° 33 sur les fonds de rotation, des interventions aussi seront prévues concernant le secteur du bâtiment, les logements sociaux, pour ce qui est des loyers payés par les personnes qui ont eu leur maison endommagée.
Quand je me réfère à ces mesures spécifiques je me rapporte à l'Administration régionale car nous ne pouvons intervenir sur d'autres administrations. Les loyers se rapportent donc aux immeubles propriété de l'Administration régionale ou qui sont gérés par l'ARER.
Il y a encore des interventions concernant les fonds de roulement, en reprenant la sollicitation qui nous avait été adressée par toutes les forces politiques, à savoir intervenir sur les emprunts accordés par Finaosta, en prévoyant un renvoi du paiement des emprunts et pour ce qui est des intérêts et pour ce qui est du remboursement du capital. Pour les personnes qui ont eu par contre leur maison détruite il y aura carrément l'annulation de l'emprunt.
Mais aussi des dispositions particulières concernant la loi n° 76 sur la résidence principale et la loi n° 33. Concernant toutes les activités économiques sans distinction. Nous prévoyons à ce propos que tous ceux qui ont contracté des emprunts avec Finaosta, ne payent pas des intérêts sur les emprunts contracté avec notre société financière.
Une mesure spécifique concernant le secteur industriel, à savoir des interventions sur les loyers des immeubles industriels et enfin; le paiement de l'impôt régional de transcription pour les véhicules détruits et des mesures pour la collecte des déchets.
Mais nous aurons en tout cas la possibilité de revenir sur ce thème au cours de l'examen au sein de la commission et ensuite de la discussion dans cette Assemblée. Nous nous sommes penchés également sur les aspects liés aux remboursements et donc dès lundi nous allons instituer une cellule de crise spécifique qui sera chargée de l'examen des demandes de remboursement et de l'octroi des fonds pour accélérer les procédures de remboursement; nous voulons donner également une assistance aux différentes communes.
A ce propos, il faut considérer que certaines dispositions sont prévues par des lois étatiques qu'il faut modifier; je fais référence à l'amendement de ne pas présenter les demandes avec le timbre fiscal.
Nous devons attendre que le Parlement approuve ou que le Gouvernement puisse adopter ces décrets. Il y a d'autres mesures, mais je renvoie au recueil qui vous a été distribué, je veux simplement souligner que dès le 17 octobre nous avons demandé pour ce qui est du service militaire le report du contingent.
Enfin quelles sont les perspectives? Tout en considérant les proportions qu'aurait pu prendre cette catastrophe si nous n'étions pas intervenus au cours de ces dernières années et tout en considérant également que nous sommes des gens de la montagne qui connaissent la double personnalité de Dame nature, je crois qu'il est nécessaire de réfléchir, de tirer des leçons de ces événements.
Tout d'abord en considérant que prévenir c'est avant tout prévoir et donc une attention accrue à la cartographie des zones non constructibles, à la sécurisation des versants, des affluents de la Doire et de la Doire elle-même, à l'entretien de notre territoire, mais je reviendrai sur ce thème en abordant les deux considérations plus générales concernant la dimension montagne, aux travaux de prévention et d'assainissement, aux techniques et modalités de construction et à la confrontation des images de ces derniers jours aux cartes des dangers pour redimensionner les zones à bâtir, nous pouvons - en reprenant une sollicitation qui nous est venue de plusieurs parts - synthétiser cette perspective avec la volonté de reconstruire, oui, mais avec intelligence.
Ensuite il y a celles que nous pouvons définir les priorités concernant le Val d'Aoste, le nord-ouest italien et le système alpin en général, à savoir ce sont les réflexions concernant la mobilité et les communications et donc l'isolement que nous avons subi et qui doit nous faire réfléchir davantage sur l'importance des infrastructures. Je veux me référer notamment au chemin de fer, les dégâts sont importants: on estime sur les 52 milliards de lires, les temps de remise en état vont de juillet 2001 à juin 2002; ce sont les données qui nous ont été communiquées par les Chemins de fer eux-mêmes.
Nous espérons que ce délai pourra être anticipé, mais je crois que l'occasion est importante pour réfléchir et l'Assesseur Lavoyer l'a déjà fait au cours de la réunion avec les responsables des Chemins de fer: quel chemin de fer reconstruire, comment le reconstruire pour l'insérer dans les réseaux italiens et européens, en liaison non seulement donc avec la nouvelle transversale ferroviaire transalpine Turin-Lyon ou la ligne à haute vitesse Turin-Milan, mais aussi avec notre projet de liaison Santhià, Aoste et Martigny.
Je fais référence à l'électrification et au doublement de la voie ferrée par exemple et donc ce volet de la mobilité et des communications est un volet important comme l'est aussi celui concernant l'aménagement du territoire, le risque naturel et la sécurité civile, mais c'est un volet qui doit être inséré dans l'autre grand thème de réflexion, à savoir le thème de la montagne. Vallet faisait référence tout à l'heure à la culture de la montagne, c'est vrai, c'est quelque chose de réel, mais c'est quelque chose que nous devons aussi promouvoir si nous voulons le sauvegarder. Et pour promouvoir une culture de la montagne, il faut que cette montagne puisse être considérée dans tous ces différents aspects, il faut que cette montagne soit une montagne vivante vu que les réflexions concernant l'entretien du territoire, ou le dépeuplement ont des retombées d'ordre général.
Donc s'il est nécessaire d'avoir une attention accrue pour les problèmes de sauvegarde, de protection, d'environnement, nous devons en même temps assurer les conditions nécessaires pour qu'il y ait des activités économiques, pour qu'il y ait une vie à la montagne.
Je crois que notre engagement sera, avec les autres régions alpines, de mener cette réflexion afin de donner à la montagne cette dimension de véritable système avec toute l'attention nécessaire et en dépassant l'opposition entre la montagne et la plaine; nous devons nous mettre tous autour d'une table et définir quelles sont les mesures nécessaires pour une meilleure protection, une meilleure sauvegarde et un meilleur développement des territoires respectifs.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Sono passati venti giorni da questa tragedia che ci ha sconvolti e io credo che anche dopo venti giorni il nostro primo pensiero debba andare alle vittime, ai familiari delle vittime ai loro amici e a coloro che in questa vicenda hanno perso tutto: c'è chi ha perso la casa, chi ha perso l'azienda, chi ha perso il lavoro.
Credo che la seconda osservazione da fare sia invece di rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che in questi frangenti hanno aiutato chi era in difficoltà in molti modi. C'è stata nella nostra Regione una dimostrazione concreta di solidarietà in cui credo che molti Valdostani abbiano dato il meglio di sé. Mi sembra una cosa da sottolineare perché in riferimento a una tragedia così terribile uno dei pochi dati positivi, direi molto positivi, è proprio quello della laboriosità, delle dignità di coloro che sono stati colpiti e di coloro che hanno inteso, attraverso varie forme, aiutare le persone in difficoltà.
Dopo venti giorni è anche il tempo di fare una prima analisi ed è un'analisi che a mio giudizio dobbiamo sforzarci di fare con umiltà e prendendo insegnamento dagli eventi che si sono svolti. Io stesso cercherò di dire le cose che sto introducendo con un atteggiamento di umiltà e voglio sottolineare questa esigenza perché, anche se non l'ho sentita oggi, in vari frangenti in questi giorni ho sentito dell'altezzosità e della supponenza che a me hanno dato un certo fastidio.
Innanzitutto, l'evento. L'evento che è stato definito più volte eccezionale, oggi l'Assessore Vallet ha ripreso questo aggettivo numerose volte, c'è chi molto più prestigioso di me ha contestato questo aggettivo, penso al Magistrato del Po, ma sentivo per radio l'altro giorno un insigne studioso, un climatologo di cui non ricordo il nome che diceva che parlare di evento eccezionale era fare torto alla lingua italiana.
Sicuramente c'è stato un evento inusuale, un evento che si potrebbe definire anche straordinario, non nella misura che è stata data nell'immediatezza dell'evento. Mi ricordo che si è parlato nei primi giorni e si è diffusa la notizia di 600 millimetri di acqua in Valle d'Aosta, oggi l'Assessore Vallet, ma erano dati che già abbiamo, forniti dall'Ufficio meteorologico, ha detto che la media in Valle d'Aosta è stata di 220 millimetri di acqua, ci sono state delle punte molto più alte, in particolare a Cogne, con circa 450 millimetri di acqua e mi pare a Champorcher dove i 600 millimetri di acqua sono stati sfiorati se non superati.
Certamente tanta pioggia. È un dato enorme, ma è un dato che ci deve far riflettere perché io ho l'impressione che al termine eccezionalità si voglia far seguire il termine irripetibilità. Ho sentito parlare di un evento che si può verificare ogni 500 anni, i geologi responsabili in Regione hanno detto questa cosa ufficialmente. Consiglierei di evitare di ripetere queste castronerie perché sappiamo bene che ci troviamo in presenza di un cambiamento climatico molto significativo: la temperatura media nel globo terrestre negli ultimi decenni è aumentata di oltre un grado ed è una cifra che apparentemente sembra piccola, ma che in termini assoluti è enorme, perché provoca degli sconvolgimenti climatici significativi.
Sappiamo che negli ultimi 15 anni l'isoterma, cioè lo zero termico, nella nostra regione è salito di circa 200 metri, fatto che ha portato all'arretramento dei ghiacciai ed ha comportato tanti problemi. Quindi dobbiamo prendere atto che a questi cambiamenti climatici deve conseguire un cambio di cultura e di mentalità rispetto all'approccio culturale e politico che dobbiamo avere nei confronti del fenomeno meteorologico nel suo insieme.
Questo evento significativo è stato imprevedibile? Abbiamo fatto tutto? Possiamo stare con la coscienza a posto? Io credo di no e bisogna sottolineare che c'è stata in questi anni una grossa difficoltà nel far avanzare una cultura del territorio. L'Assessore Vallet diceva che da dieci anni si sono posti?, magari c'era già qualcuno che ci pensava prima a queste cose?
E qui secondo me dobbiamo distinguere, rispetto a un aggravamento dell'evento causato dalla mancata prevenzione e dall'incapacità dell'uomo, due elementi. Il primo di carattere ambientale e territoriale: in questi anni si è fatta una politica idraulica sbagliata preceduta da una politica urbanistica sbagliata. Perché si sono regimati tanti torrenti, si sono fatte le canalizzazioni dei torrenti, le cementificazioni, eccetera? Nella maggioranza dei casi perché c'erano delle abitazioni da salvaguardare e questo perché si è consentito di costruire in zone dove non bisognava consentire di costruire. Poi lo capisco anch'io, da ambientalista, che in alcuni casi l'argine serve, ma chi può dire il contrario? Serve a quelle venti, trenta, quaranta case; se non ci fossero, l'argine non solo non servirebbe, ma sarebbe utile che non ci fosse per due ordini di ragioni tecniche.
La prima, l'ha accennata l'Assessore Vallet, è che un sistema di imbrigliamento dell'acqua, di cementificazione dell'acqua porta l'acqua a scorrere più rapidamente e a farla arrivare a valle con maggiore velocità. Ci siamo accorti tutti che non solo un'alluvione, ma ormai una pioggia normale in Valle d'Aosta comporta problemi alluvionali nel Canavese perché l'acqua arriva a Ivrea, dal Canavese e dalla Dora Baltea nello stesso tempo, mentre prima c'erano dei distacchi temporali più lunghi.
Ma c'è un secondo punto tecnico che va preso in considerazione: la cementificazione e la canalizzazione non consentono che l'acqua filtri attraverso il terreno e si espanda nell'alveo. Su questo tema occorre fare una serena analisi critica di quello che è avvenuto in questi anni e su questo voglio aprire una parentesi che riguarda una favola, non so come chiamarla diversamente, ma è una barzelletta che un poco ha circolato: i Verdi, gli ambientalisti, non so chi, avrebbero delle responsabilità rispetto alla gestione degli alvei perché non consentirebbero la manutenzione e la pulizia dei torrenti.
Devo dire la verità, non ho mai sentito un Verde dire una cosa del genere, non ho mai sentito in questa sede né altrove un altro politico dire che i Verdi avessero detto una cosa del genere, ma questa cosa è circolata, circola nelle strade e nei bar, si vede che bisogna trovare qualcuno a cui addossare una qualche responsabilità, anche se l'accusa è nient'altro che una stupidaggine. La manutenzione all'interno dei torrenti e dei fiumi va fatta! Mi sono anche chiesto: ma da dove deriva la favola? Perché c'è sempre un germe, un qualcosa che ha consentito lo svilupparsi di questa sciocchezza. Io credo che potrebbe individuarsi nell'opposizione che i Verdi hanno sempre fatto alla dragatura degli alvei che viene fatta in maniera cospicua e spesso in maniera abusiva. Il Magistrato del Po dice che la dragatura avviene in maniera abusiva nel 90 percento dei casi, nella zona del Po e di alcuni fiumi che si prestano a questi abusi.
Ma un conto è essere contro questa abitudine di prelevare sabbia a milioni di metri cubi che comporta tutta una serie di problemi di tipo idraulico e favorisce le alluvioni, un conto è occuparsi della manutenzione degli alvei dei quali siamo i primi sostenitori.
Tra l'altro, appendice curiosa della favola, qualcuno dice addirittura che sarebbe vietato dalla legge andare a prendere il legname di risulta negli alvei; a me se non ricordo male risulterebbe addirittura il contrario perché trattandosi di "res nullius" chiunque può appropriarsi di una qualsiasi cosa che sia relitta nell'alveo di un fiume o di un torrente, ma io chiedo che venga fatta a livello di opinione pubblica una divulgazione di informazioni sensate e positive in questo settore; se ci sono persone che intendono prendere della legna di risulta e portarsela a casa, credo che facciano un piacere non solo a loro, ma a tutti. Quindi che lo facciano, non c'è nessuna legge che lo impedisce.
Ma, tornando al tema principale, siamo anche persuasi che qualsiasi politica diversa del territorio non farebbe venir meno totalmente i rischi. Quindi bisogna andare verso politiche di delocalizzazione; a me sembra che se c'è un insegnamento che emerge evidente da questa vicenda, è che bisogna evitare di far costruire in zone a rischio e laddove si è costruito bisogna tornare indietro. Secondo me una classe politica degna di questo nome deve porsi questo problema e deve trovare le soluzioni adeguate in modo da prevenire ulteriori rischi che sarebbero gravissimi e avrebbero le conseguenze che purtroppo abbiamo dovuto constatare qualche settimana or sono.
Credo poi, e qui vengo su un piano riguardante una prevenzione tout court dell'evento, che un'altra carenza vada individuata in una sorta di mancanza di prevenzione. Non voglio fare polemiche in questa sede, sono disposto a concedere alla Protezione civile, ai sindaci, di avere generalmente operato bene dopo la sciagura, questo glielo concedo volentieri.
Ci sono state delle cose che hanno funzionato molto bene e bisogna sottolinearlo. Però, nel momento della prevenzione della sciagura, ci sono stati degli errori macroscopici, una sottovalutazione evidente tant'è che in alcuni comuni, alcuni di quelli più gravemente colpiti, non sono stati dati allarmi oppure sono stati dati in maniera tardiva, c'è stata una carenza di informazione, c'è stata una difficoltà di comunicazione fra i centri operativi e la periferia, perché di questo si tratta.
In periferia non si è agito perché c'è stata una carenza di comunicazione o un'ignoranza complessiva del fenomeno.
Le proposte per il futuro. Ho già accennato all'esigenza di delocalizzare e direi anche di ricostruire in maniera più intelligente e lungimirante. Un'altra cosa che voglio evidenziare è che a me pare che questa vicenda abbia sottolineato come sia necessaria nella nostra regione una struttura unica a presidio del territorio e dell'ambiente.
Sono necessari poi dei provvedimenti immediati: è necessario intervenire sul bilancio del 2001 e oggi il Presidente ha indicato alcune linee sulle quali ci confronteremo. Ricordo che il mio gruppo ha fatto tre proposte molto concrete, le voglio richiamare un attimo: la prima è quella di utilizzare i 500 miliardi che ci derivano dalla sostituzione dell'IVA da importazione per degli investimenti chiamiamoli intelligenti, per decostruire, per delocalizzare, per indennizzare e risarcire; la seconda è quella di dislocare le risorse fra i comuni in maniera diversa attraverso una sorta di fondo di solidarietà in cui i comuni meno colpiti cedono delle risorse ai comuni più colpiti; la terza proposta è quella di deliberare non come atto di liberalità, ma come provvedimento di bilancio legislativo che le spese di funzionamento del Consiglio regionale, comprese le indennità per i consiglieri regionali, vengano per il 2001 ridotte del 30 percento.
Questi sono in sintesi i problemi che volevo toccare. Su argomenti particolari ovviamente torneremo nei prossimi Consigli.
Volevo però ancora soffermarmi qualche minuto sulle relazioni svolte dall'Assessore Vallet e dal Presidente Viérin. Si è trattato di relazioni ampie, ma dalle quali sono stati sottovalutati alcuni aspetti, soprattutto è mancata, se non per brevi cenni, un'analisi critica. Mi riferisco in modo particolare alla relazione dell'Assessore Vallet che mi è parsa più intesa a difendere quello che è stato fatto piuttosto che a capire quello che non è stato fatto e soprattutto quello che è stato fatto di sbagliato.
L'Assessore Vallet ha risposto solo per cenni a due domande fondamentali che voglio riproporgli. La prima domanda è perché i comuni e la Regione adottando il potere sostitutivo previsto dalla legge non hanno individuato le zone inedificabili così come era previsto dalla legge urbanistica. I comuni avrebbero dovuto farlo entro l'agosto 1999, in caso di mancato provvedimento comunale la Regione avrebbe dovuto esercitare il suo potere sostitutivo. Si tratta di una carenza grave che peraltro conferma quello che in questa sede continuiamo a dire ovvero che della legge urbanistica e del piano territoriale paesistico a questa amministrazione interessa poco, interessa trovare il sistema per non applicarli. La seconda domanda è perché non si è spesa neppure una lira dei 2.000 miliardi stanziati dal Governo per la delocalizzazione dei manufatti immobiliari. Le risposte che sono state date per cenni a me sono sembrate poco convincenti.
Il Presidente Viérin, alla fine del suo intervento ci ha rassicurato con delle petizioni di principio che apprezzo, però ho ravvisato anche pochi elementi concreti, soprattutto mi sarei aspettato in questa sede che il Presidente Viérin anche in maniera succinta avesse dato risposta ad alcune delle domande che attraverso l'opinione pubblica, attraverso la stampa sono emerse in questi giorni suscitando di tanto in tanto anche delle polemiche, per esempio non è stato fatto cenno alle problematiche relative alle evacuazioni tardive, non ci sono stati cenni di analisi a proposito dei sistemi di telecomunicazione che non funzionavano più: almeno per quanto ne sappiamo noi tutta la bassa Valle domenica era isolata. Ora se la Protezione civile non riesce in caso di calamità a mettersi in contatto con una parte significativa della Regione, mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona; capisco che il mio telefono non funzioni, ma che la Protezione civile non riesca ad avere contatti con la bassa Valle mi sembra una cosa enorme.
Non ci sono stati cenni su alcuni soccorsi provenienti da regioni italiane che sarebbero stati rifiutati. Non c'è stato cenno a perché si è organizzato, questa è una mia curiosità personale, il viaggio delle macchinine attraverso il Tunnel del Monte Bianco: sei macchinette, altro che rinforzi che arrivano dalla Francia: ripeto, sei macchinette con due mezzi di accompagnamento, sedici persone. Questi sono i dati che risultano a me, completamente diversi dai dati ufficiali che hanno enfatizzato l'intervento e la riapertura. Voleva forse essere un atto simbolico, ma io mi chiedo se durante un'alluvione di questo tipo, quando abbiamo bisogno di tutto, andiamo ad enfatizzare il problema della chiusura, che è un problema reale, facendo passare sei macchinine più due di scorta attraverso il Monte Bianco, con sedici persone a bordo, a meno che ce ne fossero altre nei bagagliai, come un evento straordinario che consentiva alla Valle d'Aosta di uscire dall'isolamento a cui la chiusura del tunnel ci ha costretti...
Su queste cose avrei preferito sentire qualcosa, vorrà dire che ci torneremo con le iniziative ispettive che il Regolamento ci consente nei prossimi Consigli.
Termino annunciando da parte del nostro gruppo la proposizione di due risoluzioni: una di carattere generale sull'intera vicenda e una che riguarda specificatamente il problema delle ferrovie.
Risoluzione n. 1 Il Consiglio regionale
A fronte dell’alluvione che ha devastato la Regione Valle d’Aosta il 14 e 15 ottobre u.s;
Esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime che sono state colpite negli affetti più cari;
Si fa partecipe delle preoccupazioni di tutti coloro che, a livelli diversi, hanno subito danni all’abitazione, alle strutture agricole, artigianali, industriali;
Prende atto della dignità e della laboriosità con cui le popolazioni colpite hanno reagito alla catastrofe e ai disagi cui hanno dovuto far fronte in tale situazione di emergenza;
Ringrazia tutti i volontari, anche di città e paesi diversi, che, singolarmente o all’interno di associazioni, hanno dato il loro contributo, in modo capillare e competente, facendosi carico delle diverse esigenze che via via emergevano in modo differenziato nelle diverse situazioni;
Prende atto che post factum sono scattati gli interventi di soccorso per portare aiuto alle persone in pericolo, per ospitare gli sfollati, per organizzare il ripristino delle infrastrutture viarie;
Riconosce che là dove il territorio è stato presidiato in modo attento e fattivo, sono stati evitati perdite umane e danni gravi alle abitazioni;
Registra nell’azione complessiva esplicata dalla Protezione civile carenze nel settore della prevenzione, cioè nella tipologia di interventi finalizzati a prevenire, informare/formare la popolazione, nel sistema di passaggio di informazioni dal centro operativo alla periferia, come nella chiarificazione delle responsabilità decisionali dei diversi livelli di soggetti;
Registra, altresì, un'analoga e parallela assenza di cultura della prevenzione nell'organizzazione e nell’espletamento dell’azione amministrativa degli Enti Locali;
Riconosce che molti episodi di esondazione, di caduta di frane, di cedimento di massicciate, di interruzione di strade, di rottura di argini, di crollo di ponti, sono la conseguenza di una pluriennale gestione non sempre corretta del territorio;
Individua, in particolare, nella cementificazione indiscriminata di torrenti e di estesi tratti della Dora Baltea, nel progressivo restringimento dell’alveo dei corsi d’acqua, nell'urbanizzazione dei terreni spondali e delle zone esondabili, nella mancanza di rispetto delle norme di urbanizzazione e di tutela del paesaggio, le condizioni che hanno, da una parte, favorito ed esaltato lo scorrere veloce e travolgente delle acque e, dall’altra, aggravato le conseguenze naturali dell’alluvione;
Ritiene che l’enormità dell’accaduto imponga a tutta la comunità sia una severa riflessione sugli attuali limiti e carenze sia il ripensamento di una nuova politica del territorio, al fine di prevenire le conseguenze di eventuali futuri eventi calamitosi;
tutto ciò premesso il Consiglio regionale
Impegna
la Giunta regionale
a) ad attivare un’accurata indagine amministrativa, affidata ad una commissione indipendente di esperti nominati dalla stessa Giunta, sull’intera struttura della Protezione civile, col fine di evidenziare sia quali punti critici sono emersi in questo frangente sia le linee di intervento con cui ridisegnare un sistema integrato di Protezione civile, adeguato ed efficace;
b) a verificare, per ogni singolo episodio, quale è stato l’elemento scatenante dell’inondazione, della frana, dello smottamento del terreno o del crollo di abitazioni, edifici ed infrastrutture, e a relazionare in Consiglio regionale entro 60 giorni;
c) a rivedere, insieme ai Comuni, i piani regolatori ed in particolare le caratteristiche di edificabilità delle zone che sono state colpite dall’alluvione, prima che siano concesse autorizzazioni a ricostruire gli edifici danneggiati o distrutti;
d) ad utilizzare tutte le risorse che saranno messe a disposizione dallo Stato italiano e dall'Unione Europea per favorire ed incentivare la delocalizzazione di abitazioni e aziende (agricole, artigianali, manifatturiere) che sorgono in zone esondabili di fiumi o torrenti;
e) a impegnare, per quanto possibile, le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione in sostituzione dell’IVA da importazione, in interventi di indennizzo di danni, di prevenzione, delocalizzazione e ricostruzione in zone sicure.
F.to: Curtaz - Squarzino Secondina - Beneforti
Risoluzione n. 2 Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Preso atto che dal giorno 15 ottobre 2000, in seguito ai disastri provocati dall’alluvione, la ferrovia non è più agibile, a causa di smottamenti, allagamenti, ponti interrotti, binari divelti che hanno reso impercorribile il tratto Aosta-Chivasso;
Atteso che, mentre si è assistito al ripristino immediato, prima, di alcuni tratti e, poi, dell’intera autostrada Aosta-Quincinetto e della strada statale n. 26, nulla è stato finora fatto per quanto riguarda il tracciato ferroviario;
Ricordato che prima dell’alluvione sulla tratta ferroviaria che interessa la Valle d’Aosta erano censiti oltre 2500 utenti giornalieri nei giorni feriali;
Considerato che la ferrovia è un mezzo indispensabile di trasporto sia per le lunghe percorrenze sia per gli utenti pendolari, che per motivo di studio o di lavoro debbono tutti i giorni percorrere la distanza che separa la loro abitazione dal luogo di attività;
Ritenendo che i servizi sostitutivi possono venire incontro alle suindicate esigenze solo per un periodo breve, ma che non possono sostituire il servizio ferroviario;
Impegna
la Giunta regionale a sollecitare i responsabili delle Società di Trasporto ferroviario affinché:
a) siano attuati in tempi brevissimi i progetti di risistemazione della tratta Aosta-Chivasso, in modo da consentire il progressivo ripristino, anche procedendo per tratti, del servizio ferroviario;
b) si lavori contemporaneamente, nei diversi tratti della ferrovia, a ripristinare ponti, ricostruire massicciate, rimettere in sesto gallerie ostruite, in modo da ottimizzare il tempo;
c) si considerino tutte le possibilità, ivi compreso l’utilizzo del Genio Ferrovieri, per realizzare al più presto le opere di ripristino;
Chiede
ai Parlamentari valdostani e alle diverse forze politiche presenti in Parlamento di farsi portavoce presso il Governo delle esigenze della Regione in merito al ripristino in tempi brevissimi del servizio ferroviario Aosta-Chivasso.
F.to: Squarzino Secondina - Curtaz - Beneforti
Président La parole au Conseiller Nicco.
Nicco (GV-DS-PSE)Credo sia del tutto evidente a chiunque abbia percorso la Valle d'Aosta in questi giorni, da Cogne a Gressoney, passando per Pollein, Nus, Fénis, Donnas e troppe altre località colpite dall'alluvione, che "ricostruzione" (globalmente intesa perché, ovviamente, i singoli elementi dovranno tutti essere verificati proprio alla luce degli eventi, quindi "ricostruzione intelligente" come la definiva il Presidente Viérin) e nello stesso tempo "messa in sicurezza del territorio" diventano, non possono non essere, l'impegno centrale della seconda parte della legislatura, impegno a cui subordinare ogni altra questione, rispetto al quale ridefinire i nostri comportamenti politici, superando almeno su questo tema la tradizionale divisione di ruoli per sviluppare un prolungato e forte impegno unitario a cui chiamare solidalmente tutta la Comunità valdostana.
Largamente condivisa, se non unanime, mi pare sia la considerazione che nel momento della tragedia la Valle d'Aosta, nelle sue diverse articolazioni (i cittadini, i comuni, la Regione) ha saputo esprimere il meglio di sé stessa, con determinazione, orgoglio e dignità diceva prima il collega Curtaz.
Ognuno di noi ha potuto constatarlo direttamente sul proprio territorio.
I cittadini, intanto. In una situazione drammatica, da noi a Donnas, con la borgata e diversi villaggi invasi dalle acque e dal fango, la pioggia non aveva ancora smesso di cadere che già era tutto un fervore di iniziative per ripristinare i servizi fondamentali. Pochi sono rimasti in attesa o peggio a guardare e così mi risulta pressoché ovunque.
I comuni, poi. Credo che debba essere sottolineato il ruolo decisivo svolto dai comuni nel momento più critico, quando ogni collegamento, anche telefonico era interrotto. Comuni che si sono dimostrati ancora una volta le vere cellule fondamentali della Valle d'Aosta. La sede del comune è diventata il naturale punto di riferimento dei cittadini.
Gli amministratori comunali, il sindaco e la sua squadra, a volte maggioranza e minoranza fianco a fianco, sono stati impegnati in attività permanente e hanno dato una prova molto buona di sé, una prova di efficienza ed efficacia in una situazione oltremodo difficile, quando mille e disparate richieste, spesso drammatiche, confluiscono e si accavallano in uno stesso punto e questo stesso punto era la sede del comune.
Ci sono amministrazioni comunali che con interventi oltremodo tempestivi, nel corso stesso dell'alluvione, hanno evitato sciagure maggiori al proprio comune e credo sia giusto ricordarlo in questo consesso. A Saint-Marcel, dopo l'allerta della Protezione civile di venerdì, la costante sorveglianza lungo gli argini del torrente che scende dall'omonimo vallone, ha consentito di individuare i punti critici e di intervenire nel pieno della notte tra sabato e domenica per far defluire le acque.
Così è avvenuto, domenica mattina, a Gressan, sul corso del torrente che scorre a fianco della chiesa di La-Madeleine con interventi nell'alveo in tempo reale (qualcuno mi parlava di 7, 8, 9 mezzi reperiti seduta stante e messi in azione); a Morgex, con interventi sulla Dora e sul torrente di Arpy; a Gressoney-La-Trinité, sul Lys, a monte del capoluogo, impedendo alle acque di scavare un nuovo corso in direzione dell'abitato; a Fontainemore e certamente in altri comuni ancora.
Le strutture dell'Amministrazione regionale e dello Stato, infine. In questi giorni si stanno levando voci critiche, incominciano ad affiorare polemiche anche pesanti contro questo o quel settore, in particolare verso la Protezione civile. Devo dire, per quel che è della situazione di cui ho conoscenza diretta, di avere avuto una percezione diversa e che mi sembra giusto testimoniare qui: di aver visto una macchina che ha saputo far fronte all'emergenza; un Corpo forestale presente con continuità, che ha svolto una positiva ed efficace azione di collegamento, sobbarcandosi le incombenze più diverse, senza troppe pastoie burocratiche; Vigili del fuoco, di professione e volontari, intervenuti con prontezza e dedizione totale; carabinieri e polizia che hanno collaborato pienamente, i primi con efficace azione antisciacallaggio; interventi tempestivi ed efficaci degli elicotteri della Protezione civile che, operando in condizioni talvolta proibitive, hanno consentito di ridurre al minimo, almeno nella Bassa Valle, la perdita di vite umane; responsabili dei diversi servizi, a partire dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica, che certo non si sono risparmiati. Insomma quel che ho visto è stata una situazione caratterizzata da forte iniziativa dei singoli e delle istituzioni, e in quei frangenti l'iniziativa dei singoli e delle istituzioni è determinante, ma anche caratterizzata da un adeguato coordinamento.
Per rimanere ad una situazione che conosco, che ben conosciamo, il borgo di Donnas. Prima le acque ad un livello mai visto, quattro metri nel punto centrale, e poi fango, fango ed ancora fango. Fango ovunque, negli infiniti meandri del borgo. Una situazione disperante. Ebbene, l'azione sinergica di cittadini ed istituzioni, a cui si è aggiunta quella dei volontari accorsi da ogni parte, singolarmente o a gruppi, coordinati da varie organizzazioni, ha fatto sì che a soli quindici giorni dall'evento il borgo sia stato ripulito e lavato. È un risultato impensabile certo la sera del 16 ottobre.
Ci sono stati certamente anche mancanze ed errori, peraltro, in parte inevitabili in una situazione di tale emergenza. È doveroso individuarli per migliorare la nostra capacità di intervento in futuro. È doveroso, in particolare, fornire delle risposte a chi, troppo duramente colpito negli affetti più cari, chiede di capire che cosa effettivamente sia successo e perché. Che cosa non abbia funzionato. È doveroso dare delle risposte.
Ma altra cosa è la polemica da taluni innescata ed alimentata. Alzare il dito accusatore, inquisitore, è troppo facile oggi, anche un po' meschino talvolta. Molto più difficile è essere lì a gestire l'emergenza, a fornire delle risposte convincenti in quel momento, ognuno per la propria parte, assumersi lì la propria parte di responsabilità.
E, comunque, anche quando siano stati individuati degli errori e delle carenze, credo che questi non possano offuscare il quadro complessivo che, per quanto concerne il modo in cui l'emergenza è stata affrontata, a me pare essere stato caratterizzato da elementi sostanzialmente positivi.
Altra considerazione in questi giorni ricorrente è che occorre un cambiamento di mentalità rispetto al territorio ed all'ambiente. Dovremo certamente rivedere i piani regolatori comunali alla luce di quanto è successo, è indispensabile ed urgente farlo, ma non sufficiente. È troppo comodo addossare la responsabilità di perimetrazioni errate solamente all'ente pubblico, comuni e Regione. Quante volte di fronte ad un veto o a perplessità dell'Amministrazione, il singolo ha cercato di aggirarli ricorrendo agli amici degli amici. Lo "pleisi" è stato anche questo. Diciamole queste cose, anche se sono scomode. L'errore è congiunto: dell'amministratore che accetta di fare lo "pleisi", di inserire quell'area tra quelle fabbricabili, ma anche del cittadino che lo richiede, che magari promette il voto in cambio.
Mutamento di mentalità, cultura diversa del territorio, allora, a tutti i livelli, anche del singolo.
Prima di costruire un edificio, di investirvi i risparmi di tutta una vita, di far crescere in quell'edificio i propri figli, impariamo a guardare non solo a valle, se c'è un bel panorama, guardiamo sempre anche a monte se siamo sotto un canalone da cui un giorno può scendere la morte, come è scesa in questi giorni. C'è sempre anche una responsabilità del singolo.
Il termine "Protezione civile" dovrebbe indicare non solo una struttura da cui "passivamente" attendere direttive, ma dovrebbe essere un concetto più ampio che coinvolge "attivamente" ogni cittadino, che quindi è in grado da sé di effettuare una prima valutazione di una situazione di rischio.
È stata quella del 14 e 15 ottobre un'alluvione eccezionale, io non farei queste distinzioni sottili fra eccezionale o straordinaria, sia per intensità che per estensione, e certo tra le più catastrofiche che la storia della Valle d'Aosta ricordi. Una storia peraltro costellata da altri eventi drammatici ai quali voglio accennare brevemente e certo non per una digressione di mera erudizione perché altra sarebbe la sede, ma perché quella storia può fornirci elementi per le riflessioni di oggi.
E allora ricordiamo la distruzione di antichi borghi e villaggi: Donnas, all'inizio del XII secolo, sotto una frana gigantesca; il "bourg des Rives" a Châtillon all'inizio del XIII secolo. La distruzione di numerose chiese: Arnad, Issogne, Montjovet, Chambave, Saint-Marcel, Quart. Ampiamente note sono le vicende di Thora; le inondazioni provocate dal lago del Rutor, specie sul finire del Cinquecento; le devastazioni provocate ad Aosta e dintorni dall'effetto congiunto della Dora e del Buthier nel 1519, con le acque che scorrevano attorno all'Arco di Augusto, e nel 1640; l'alluvione del 1755 che devastò la Valle d'Aosta da Saint-Marcel a Pont-Saint-Martin.
Ed in tempi più recenti la catastrofe di Verrès (80 vittime nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 1840) e "les déluges", ricordati dal Presidente, del 1846 con 32 vittime solo a Chambave.
Anche nel passato, anche in una situazione in cui l'antropizzazione e l'edificazione seguivano logiche differenti, in cui non esisteva la cementificazione dei corsi d'acqua, non un solo metro di torrente era cementificato, in cui non vi era l'abbandono della montagna, ma le coltivazioni con i terrazzamenti erano anzi spinte fino all'estremo limite, in cui la rete dei "ru" ricopriva l'intero territorio della Valle d'Aosta ed era oggetto di costante manutenzione, in cui non vi era emissione di gas inquinanti che producessero il buco nell'ozono o l'effetto serra con gli ipotizzati mutamenti climatici (e apro qui una parentesi per ricordare, collega Curtaz, che variazioni climatiche significative non sono tuttavia mancate neppure nel passato, se è vero che nell'optimum climatico del basso Medioevo il colle del Teodulo era attraversato regolarmente, tanto che anche da lì sono passati i Walser per insediarsi in Valle d'Aosta), ebbene anche allora, in un contesto così radicalmente diverso si sono verificate tragedie non dissimili da quella attuale. Mi sembra perciò francamente semplicistica ed anche fuorviante un'analisi, che qua e là traspare, fondata sulla contrapposizione tra un passato, mitizzato, in cui tutto era regolato in modo armonioso, ed un presente pieno solo di contraddizioni.
E dunque sviluppiamo pure le necessarie riflessioni, considerazioni e valutazioni di carattere generale su quei temi e su quant'altro si ipotizza abbia avuto una qualche influenza nel determinare la situazione attuale, ma ritengo che tra i nostri compiti, tra i primi compiti dell'Amministrazione regionale vi sia piuttosto l'analisi attenta e puntuale delle singole situazioni per individuare, caso per caso, le ragioni dell'evento e, giustamente lo ricordava l'Assessore Vallet, identificare e censire le cause relative ad ogni singola situazione.
Questo è il compito nostro principale oggi, per farne una mappa precisa su tutto il territorio regionale. Ogni situazione sia attentamente esaminata e discussa con gli amministratori locali (e tra questi inserisco anche noi, anche i consiglieri regionali, ognuno dei quali conosce in modo particolare una certa realtà e può, forse, se chiamato, fornire il proprio contributo), sia esaminata con la popolazione che in quel determinato luogo vive ed opera e che ha assistito allo sviluppo dell'evento e meglio di molti altri può fornire precise indicazioni e si indichino, caso per caso, gli interventi necessari, i tempi di realizzazione, le priorità. Questo soprattutto ci serve oggi.
Non si tratta certo di sostituirci ai tecnici, ma di avere tuttavia consapevolezza che talvolta anche le valutazioni tecnico-scientifiche possono essere fallaci, anzi che in certi casi proprio errate valutazioni progettuali sono state una concausa delle tragiche vicende del 15 e 16 ottobre e che, quindi, vi deve essere non una delega progettuale in bianco, ma una valutazione comune di ogni singola situazione, distinguendo intanto tra situazioni determinate da cause oggettive, difficili da prevedere, determinate dall'estensione ed intensità delle precipitazioni, e cause soggettive.
Cause oggettive. Faccio qualche esempio: a Fénis il vallone di Pieiller, per la sua conformazione orografica, difficilmente poteva far presagire ciò che è successo: un bacino di limitate dimensioni, assai poco urbanizzato; il villaggio Perron su cui sono riversate le acque era fuori dall'asse centrale del vallone; ricordo anche che i detriti hanno sepolto l'antica cappella di Pléod e sono giunti non lontano dal castello.
Così altrove, per esempio ad Issime, per quel che è del vallone di San Grato, ove uno smottamento, originatosi dalle parti del Galm, che mai aveva destato preoccupazioni, ed ingrossatosi via via lungo le ripide pendici sottostanti, si è trasformato in una rovinosa massa di detriti e di blocchi che si è abbattuta su Ricourt. Così per gran parte delle frane e degli smottamenti tra Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité; sul versante tra Nus e Chambave sulla sinistra orografica della Dora e tra Fénis e Margnier sul versante opposto; in determinate località della valle di Champorcher.
Particolarmente significativo a Cogne è il caso di Lillaz: lì un'intera area morenica di ablazione che, probabilmente, è scivolata su uno strato sottostante morenico di fondo si è corrugata e frantumata in mille zolle; è un fenomeno che per la sua estensione credo finirà in qualche manuale di geologia.
Allora mi chiedo quali opere di prevenzione potessero essere ipotizzate in questi casi: nessuna.
Non così altrove. Talvolta l'evento naturale, già di per sé foriero di disastri, è stato aggravato da concause legate direttamente all'intervento improvvido e talvolta decisamente sconsiderato dell'uomo.
Errori, talvolta anche gravi, sono stati certo compiuti.
È pur vero che col senno di poi è più facile giudicare e che oggi ci sentiamo un po' tutti geologi ed ingegneri, ma è anche vero che gli infiniti studi sul territorio di questi anni non sempre hanno dato i frutti necessari. Per esempio, se scorriamo il voluminoso malloppo del PTP, nelle schede per unità locali contenenti le "relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali caratterizzanti", all'unità 18, Saint-Barthélemy, Comuni interessati Nus e Quart, leggiamo che: "L'unità locale non presenta situazioni critiche rilevanti, per la relativa integrità del territorio in quota, il ridotto indice di abbandono delle zone pascolive?" eccetera.
Non è di grande aiuto nemmeno "la carta della pericolosità geologica e idraulica" annessa al PTP che inserisce gran parte del capoluogo di Nus tra le "aree che non presentano problemi particolari dal punto di vista della pericolosità idrogeologica". Certo non doveva essere il PTP a definire degli specifici interventi, ma individuare delle aree di crisi, forse sì.
Concause legate direttamente all'intervento dell'uomo. Talune situazioni paiono fin da ora emblematiche.
Per quanto concerne gli effetti provocati dai versanti e dai valloni laterali, proprio il caso di Nus e quello di Pollein, già ampiamente discussi in questi giorni.
Tutte le acque del bacino, dell'ampio bacino del vallone di Saint-Barthélemy, confluiscono nella gola, in quella che è definita "forra di ingresso" dalla citata unità 18 del PTP, una gola che si apre sulla collina o meglio che ha formato il conoide di deiezione su cui è costruito Nus. Ebbene proprio lì, allo sbocco di quella gola, ove il deflusso delle acque dovrebbe essere il più libero possibile, vi è un ponte costruito in epoca recente la cui inadeguatezza strutturale, per il tipo costruttivo e per le dimensioni, si è drammaticamente rivelata in quest'occasione, vi è un altro vecchio ponte, poco a monte, che non è stato rimosso perché, a quanto pare, vincolato dalla Soprintendenza, e vi è un edificio costruito proprio di fronte al canalone.
Tutto ciò ha creato, non poteva non creare una situazione di "tappo" e contribuire ad indirizzare dentro al Paese, dentro a Nus, acqua, detriti e fango con le conseguenze drammatiche che tutti abbiamo potuto constatare.
A Pollein è sufficiente raggiungere la base del ripido e scosceso canalone attraverso il quale le acque escono da Comboé e guardare verso il basso per capire che ciò che è successo era altamente probabile che dovesse succedere, prima o poi, in questa o in altra occasione. I tetti delle case sono lì sotto, in direzione della linea di scorrimento naturale delle acque.
Troppe volte l'uomo, noi, invece di assecondare e di rendere sicura tale linea, abbiamo cercato di ingabbiarla, di forzosamente indirizzarla, di costringerla in una camicia di forza innaturale, ma le acque in casi eccezionali come questo hanno teso, inevitabilmente, a riappropriarsi del proprio corso naturale.
Ed anche il caso di Gressoney-Weissmatten: sotto la Punta Rossa la natura ha disegnato una grande ipsilon, un classico di molti versanti, la cui asta scende diritta proprio sulla paleofrana di Weissmatten, l'area più disastrata, ridotta ora ad una pietraia da cui spuntano alcuni edifici costruiti recentemente.
Per quel che è della vallata centrale, per quanto concerne la Dora, significative sono le situazioni di Donnas e Montjovet, in cui un ruolo preponderante hanno avuto gli sbarramenti per scopi idroelettrici.
A Donnas tutti hanno potuto vedere i tronchi impigliati sulla sommità delle paratoie, constatare che queste, ancorché completamente aperte, non consentivano alle acque di defluire e ne provocavano la fuoriuscita verso il borgo da un lato e verso il villaggio di Clapey dall'altro.
A Montjovet l'acqua, pressata dallo sbarramento, usciva dalle paratoie fortemente velocizzata e si indirizzava su un punto dell'argine poco a valle che è stato scardinato con il conseguente allagamento della parte bassa di Montjovet.
Diversa la situazione di Pont-Saint-Martin: il nuovo sbarramento di Quincinetto, realizzato evidentemente con criteri e dimensionamenti diversi, non pare aver creato problemi ma qui, nonostante i lavori realizzati in questi ultimi anni, continua tuttavia ad esserci una confluenza delle acque del Lys nella Dora a 90 gradi, in direzione del roccione su cui sorge la Tour d'Aviès che non consente alcuno spazio di espansione: l'effetto di riflusso delle acque della Dora è inevitabile con il conseguente allagamento delle cascine di Pont-Saint-Martin e dell'area industriale (Feletti, Tousco, eccetera).
Percorrendo il nostro territorio in questi giorni abbiamo anche visto argini le cui fondamenta sono state troppo facilmente scalzate, come per le opere recentemente realizzate a Staffal. Assessore Vallet, non tutte le recenti arginature hanno dato buona prova di sé. Abbiamo visto argini del tutto insufficienti: il caso ricordato da Vallet, di Champsil, ove il Lys, per la mancanza di un argine adeguato su un'ansa, si è scavato un nuovo corso in linea retta ed ha asportato un lungo tratto della strada regionale ed alcuni edifici. Lì non c'era eccesso di regimazione, lì mancava una regimazione adeguata.
Oppure, abbiamo visto situazioni paradossali come quella di Zindre, poco a monte del capoluogo di Gressoney-Saint-Jean, ove è stato costruito un ponte esattamente sulla confluenza tra un torrentello laterale ed il Lys con gravi conseguenze su tutta l'area circostante. Abbiamo visto argini non completati: il caso di Issogne, con lavori da tempo appaltati, ma sospesi per l'insorgere di questioni tra appaltatori ed Enel e conseguente allagamento dell'area artigianale circostante.
Abbiamo visto alvei notevolmente rialzati dall'evento del settembre 1993 e non ripuliti: il Lys tra Gaby ed Issime con fuoriuscita delle acque in località Serta, erosione della strada regionale e anche lì distruzione di edifici. Abbiamo visto ponti e ponticelli che hanno contribuito a bloccare il deflusso delle acque.
Il caso di Epinel è un classico, villaggio che già di per sé si trova in una situazione difficile attraversato com'è dal torrente che scende dal vallone di Arpisson: su quel torrente sono stati costruiti diversi solidi ponticelli in cemento armato, ognuno dei quali è diventato ben presto uno sbarramento e ha fatto riversare i detriti all'interno del villaggio. Ed ancora abbiamo visto tralicci e cabine ENEL situati troppo in prossimità dei corsi d'acqua: la cabina di Vert, spazzata via; i tralicci ora traballanti o sradicati di cui è disseminata la Valle del Lys.
Sono questi dei semplici appunti che ognuno di noi ha segnato in questi giorni e che non hanno altra pretesa che quella di fornire qualche spunto concreto a chi dovrà tracciare quella mappa complessiva della situazione.
Abbiamo anche rilevato in questi giorni l'urgenza di procedere ad un rapido monitoraggio del territorio. Ogni comune il suo. Quante sono le situazioni in cui non si sono verificati problemi semplicemente perché lì le precipitazioni sono state più clementi, ma in cui le condizioni oggettive non erano dissimili da quelle delle località gravemente devastate? Faccio un solo esempio, uno tra i tanti che mi colpisce ogni giorno salendo ad Aosta: ad Arnad il torrente che scende da Machaby scorre nella parte terminale in mezzo ad un'area industriale (Tecnomec, VITA, eccetera). Ebbene nel letto, rifatto da non molti anni, cresce una rigogliosa vegetazione e laddove è incanalato sotto la statale i detriti accumulati nel tempo quasi già ne ostruiscono la luce.
Rapido monitoraggio, dunque, per rimuovere rapidamente situazioni come questa e per individuare quei tratti dei corsi d'acqua che richiedono urgenti interventi di pulizia ed abbassamento dell'alveo.
Preoccupante è soprattutto la situazione della ferrovia.
Noi abbiamo visto l'Anas subito all'opera, ancora la pioggia non era cessata che già si stava ricostruendo la curva completamente erosa a Bard. Sull'autostrada abbiamo visto subito un gran fervore ed un ripristino del collegamento in tempi rapidi, nonostante che i danni in certi punti fossero rilevanti. Ma c'è stato un grande assente nei primi giorni post alluvione: le ferrovie.
Le ferrovie che hanno dato l'impressione, e mi auguro che sia solo un'impressione, di essere su di un altro pianeta, di agire con tempi e metodi che certo non sono quelli dell'emergenza. Per le ferrovie le lancette dell'orologio sono state ferme troppo a lungo al giorno dell'alluvione; il contrasto talvolta è stato palpabile: Nus era un cantiere unico, l'unico punto in cui per troppi giorni nulla è stato fatto è la stazione ferroviaria. Adesso, finalmente, anche lì sono iniziati i lavori.
Occorre certamente una riflessione, come già è stato detto, sull'assieme della linea. Gli interventi di rilievo dovranno essere finalizzati a quella che sarà la linea, nel tracciato e nell'infrastruttura, del futuro, ma occorre intanto superare l'emergenza, non possiamo subordinare tutto a quella che sarà l'eventuale linea del futuro.
Il collegamento ferroviario tra la rete italiana e la Valle d'Aosta deve essere ripristinato. Ricostruendo i due ponti distrutti nel Canavese (ha detto il Presidente della Camera Violante che il Genio, dopo aver ricostruito i ponti nei Balcani, può certo ricostruirli anche sulla Chivasso-Aosta) e risistemando alcuni tratti della massicciata, in particolare a Quincinetto e Donnas, è possibile attestare la linea a Verrès così come va rapidamente riattivato il tratto Aosta-Nus. Già questi sarebbero segnali importanti: segnali che la ferrovia continua a vivere.
Sento invece dire che un rappresentante del compartimento di Torino avrebbe recentemente ipotizzato la riapertura della linea fino a Borgofranco per giugno-luglio 2001 e della tratta Borgofranco-Nus entro luglio 2002! Mi auguro che le mie informazioni siano totalmente errate, sarebbe una prospettiva del tutto inaccettabile. Non so a quale livello la questione della linea ferroviaria sia stata posta. In Valle sono venuti il Presidente Ciampi, vari ministri. Immagino che il livello sia quello, non può non essere quello.
Qui non stiamo discutendo di una delle tante linee locali che hanno subito danni, ma dell'unica linea che collega un'intera regione alla rete italiana ed internazionale e allora assurdo sarebbe se a decidere in merito fosse, con tutto rispetto, il compartimento di Torino.
Ed intanto, mi rivolgo direttamente all'Assessore Lavoyer, il servizio sostitutivo con autobus non lasci a piedi, per mancanza di posti a sedere, una parte degli utenti, dei pendolari che devono raggiungere Aosta, come è successo più volte a Verrès e a Châtillon (31 ottobre, 2 novembre, eccetera). Non credo che manchino gli autobus! Non aggiungiamo altri disagi a chi già ne deve sopportare tanti, troppi.
Qualche rapida considerazione vorrei aggiungere sulla questione delle dighe, sull'allarmismo che è stato fatto in merito. Domenica 15, in piena emergenza si è diffusa nella Bassa Valle una voce: "Sono state aperte le dighe", Place-Moulin, Gabiet. È facilmente intuibile l'effetto su chi stava incominciando ad approntare i primi soccorsi. Un allarmismo che, una volta diffuso, è poi difficile sradicare. Credo che Place-Moulin abbia, in realtà, svolto il ruolo opposto, non di incremento del Buthier e della Dora, ma di contenimento, invasando le acque dell'alta Valpelline che, senza il bacino, sarebbero allora sì defluite a valle.
Diversa la situazione del Gabiet che ha effettivamente rilasciato acqua nel Netchio tramite lo sfioratore, acqua che sarebbe comunque scesa a valle anche senza la diga, mentre non risulta che vi sia stata alcuna apertura degli scarichi. E tuttavia, per fugare definitivamente preoccupazioni ed apprensioni, sarebbe utile diffondere i dati della portata dei corsi d'acqua in quelle ore, i dati dell'eventuale immissione d'acqua tramite gli sfioratori e quelli dell'ipotetica apertura dello scarico di fondo. Per quel che è del Gabiet, se i dati sono di 500/600 metricubo/secondo per la portata del Lys a Pont-Saint-Martin nel momento della piena, di 9 metricubi/secondo per le acque rilasciate dallo sfioratore e di meno di 10 metricubo/secondo per le acque rilasciabili dagli scarichi di fondo ed intermedio, la preoccupazione dovrebbe svanire da sé.
La ricostruzione, infine, su cui avremo modo di soffermarci in seguito, una ricostruzione certo lunga, difficile ed onerosa: dalla messa in sicurezza dei versanti alla ricostruzione degli argini, dalle innumerevoli opere di consolidamento delle rete viaria al ripristino di vaste aree agricole, specie nel fondovalle tra Donnas e Montjovet, oggi trasformate in deserto. Una ricostruzione che implica, inevitabilmente, determinate situazioni di rischio sulle quali è opportuno fissare fin da ora la nostra attenzione. Ci saranno risorse ingenti a disposizione e ci saranno minori controlli. Chi specula su queste situazioni c'è sempre. È successo altrove, facciamo in modo che non succeda anche in Valle d'Aosta. Sta all'Amministrazione mettere in atto tutti quegli strumenti che sono necessari affinché la tragedia di molti non si trasformi nel business di qualcuno.
PrésidentLa parole au Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV)Quando si è di fronte ad un fenomeno naturale che provoca grandi danni, come quello abbattutosi sulla nostra regione nei giorni 14, 15 e 16 correnti, ci si domanda sempre quale sia la causa e si cerca sempre un colpevole. Il passo successivo è quello di individuare le azioni necessarie per evitare il ripetersi di avvenimenti così drammatici.
Non essendo un tecnico non ho la pretesa di individuare con queste poche frasi una soluzione, ma, dopo essermi documentato, intendo esprimere alcune lince guida che potrebbero permettere di affrontare un'altra emergenza simile in modo migliore e di ridurne gli effetti sull'intera regione.
La causa: si è trattato di un evento meteorologico straordinario come illustrato molto bene su "Tuttoscienze" mercoledì 25 ottobre 2000 da Luca Mercalli, Direttore di Nimbus, che descrive in termini scientifici l'origine del disastro ambientale. A suo parere il motivo principale è l'eccezionalità, in termini quantitativi della pioggia (circa 400 litri per metro quadrato dal 13 al 16 ottobre, tanto quanto ne riceve la pianura padana in un anno), un evento provocato da fenomeni concomitanti quali la solida alta pressione nei Balcani che ha formato un muro di gomma e la temperatura elevata che ha collocato l'isoterma zero gradi a quote prossime ai metri 3.000. Tali fenomeni eccezionali sono però, purtroppo, sempre più frequenti.
Si tratta in sintesi di avvenimenti straordinari che potrebbero evidenziare il cambiamento del clima a causa delle attività umane.
La politica di protezione dell'atmosfera è certamente un elemento decisivo per la tutela del nostro pianeta e quindi anche della nostra regione su cui sfortunatamente possiamo intervenire in maniera molto limitata. Tali azioni riguardano principalmente il modo di comportamento dell'uomo in generale e riguardano ambiti istituzionali ben più ampi a livello planetario (le nostre scelte sarebbero in ogni caso ad effetto nullo perché siamo solamente 120.000 su un totale di 9.000.000.000 d'esseri umani).
Dal punto di vista ambientale e per le sue limitate potestà legislative la nostra Regione ha già fatto molto: da un lato investendo nel campo della produzione dell'energia idroelettrica e dall'altra favorendo lo sviluppo e l'utilizzo delle energie alternative che dovranno sempre essere potenziate; molto altro l'Amministrazione regionale non può certamente fare.
Il colpevole: in ogni catastrofe si ricerca sempre il responsabile. Se è proprio necessario trovarne qualcuno, a mio parere, se ne possono individuare due: il primo, viste le premesse, appare evidente corrispondere con il "diluvio monsonico" che si è abbattuto sul territorio della nostra regione; il secondo può essere individuato nello spirito positivista della nostra società che ritiene che con le scienze si possano vincere le forze della natura. La scienza e l'uomo hanno spesso la presunzione di avere una soluzione per contrastare la natura, per vincere le immani ed incommensurabili forze della terra.
L'altro giorno una trasmissione televisiva su Discovery Channel riferiva sui disastri ed in particolare sui terremoti. Si faceva il caso del Giappone dove se è vero che si progettano le strutture in grado di resistere ad un terremoto di una determinata forza, è pur vero che quando l'avvenimento è di un'intensità maggiore i cedimenti sono inevitabili: facile da capire!
Non esiste pertanto un individuo o una tipologia di "individui" ben identificabili, colpevoli del disastro e non è logico disperdere delle energie nella sua vana ricerca. Le forze debbono essere incanalate in modo positivo per risolvere i problemi non per crearne dei fasulli.
Cosa fare: le scienze ci affermano che, se è in atto una fase di cambiamento climatico, tali fenomeni saranno sempre più frequenti. È necessario quindi che impariamo a convivere con questi fenomeni e le nostre politiche dovranno mirare a minimizzare i danni causati da tali eventi.
Occorre ripensare al nostro territorio, ad una strategia globale che non operi solo su singoli interventi puntuali, ma che intenda il territorio, regionale e non solo, come parte di un grande sistema globale in cui azione con effetti positivi per un soggetto non generi una reazione negativa per un altro.
È necessario capire ed accettare che le precipitazioni, come quelle avvenute nei giorni scorsi, non possono essere contenute negli alvei fluviali e che quindi le esondazioni sono sempre avvenute e dovranno sempre avvenire per una corretta gestione del sistema fluviale.
Un'opzione da considerare rispetto a questo possibile fenomeno è la delocalizzazione delle attività site in zone ad evidente rischio al fine di ridurre al minimo i possibili danni qualora si verificasse un altro evento catastrofico.
Questa azione sarebbe tuttavia di difficile attuazione in un territorio aspro e rude come il nostro: le aree non a rischio nella nostra regione sono molto limitate, le attività da rilocalizzare numerose.
Occorre inoltre potenziare i sistemi di monitoraggio ed i mezzi della protezione in modo che siano più efficienti.
È infine inutile e dannoso cercare e voler trovare forzatamente tra noi "il colpevole" di fenomeni di portata incommensurabile.
Dobbiamo essere coscienti che non possiamo creare una barriera che ci protegga ed elimini dalla nostra regione la possibilità dei disastri. Dobbiamo invece attivarci, ognuno per le proprie competenze, ad effettuare delle scelte razionali e ragionevoli in modo da minimizzare gli effetti dannosi di tali avvenimenti e soprattutto da prevenirli.
PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Nell'intervenire in questo dibattito, non so se c'è la registrazione, Presidente. C'è la registrazione?
PresidenteNormalmente c'è sempre la registrazione.
Frassy (FI)Normalmente è vero che c'è sempre, spesso però capita che non funzioni, Presidente. Non capisco quale sia il suo nervosismo, probabilmente lei ha letto nel pensiero il mio intervento e la premessa del mio intervento. Le do atto che ha delle grosse capacità divinatorie, dovrebbero però essere utilizzate meglio!
Il ruolo istituzionale di questa Assemblea penso che meriti una riflessione anche perché altrimenti non si capirebbe il senso di questo Consiglio monotematico dedicato agli eventi dell'alluvione.
Se questo Consiglio regionale oggi è qui riunito, evidentemente ha senso che i 35 consiglieri regionali possano esprimere le loro sensazioni, possano esprimere le loro opinioni, possano porre le loro domande e possano anche proporre le loro proposte.
Probabilmente quello che sto dicendo è pleonastico e scontato perché oggi siamo qui a dircele queste cose. Non è però completamente scontato se pensiamo che siamo qui a oltre 15 giorni dall'alluvione dopo dura insistenza avvenuta in sede di Conferenza dei Capigruppo, dove Forza Italia ha chiesto e insistito affinché si facesse questo Consiglio e voglio ricordare come nella vicina Regione Piemonte il Consiglio regionale in dieci giorni sia stato convocato tre volte.
E allora è vero che la Giunta ha i mezzi, ha i poteri per intervenire, ha i mezzi e i poteri per affrontare l'emergenza, vedremo dopo come, ma è altrettanto vero che questa Assemblea deve avere un ruolo e sicuramente in una situazione del genere riteniamo che questa Assemblea abbia ancora una volta, Presidente Louvin, perso i tempi e i momenti nei quali riunirsi e nei quali esprimere quelle che sono le doverose proposte e riflessioni che competono a un'assemblea legislativa come quella in cui stiamo oggi ragionando e discutendo.
Abbiamo visto un interessantissimo dossier su quello che è stato fatto per quanto concerne l'alluvione da parte della Presidenza della Giunta, entreremo forse in parte in alcune analisi su questi atti che sono stati adottati dalla Presidenza della Giunta, ma vorremmo anche dire che probabilmente da un confronto proveniente da 35 individualità rappresentative di diverse forze politiche forse potevano arrivare anche ulteriori suggerimenti e ulteriori sinergie e noi abbiamo evitato di fare la polemica in questi quindici giorni anche perché ci siamo resi conto che la polemica non serviva a nessuno, ci siamo resi conto che c'erano delle cose da fare e che, successivamente, ci sarebbe stato il tempo per chiedere e per avere delle risposte.
E considerato che eravamo impossibilitati, come consiglieri regionali, a svolgere quello che era il nostro ruolo propositivo, legislativo, perché l'Assemblea non veniva convocata, abbiamo ritenuto di procedere attraverso i nostri gruppi parlamentari. Abbiamo attivato sin dalla prima settimana i nostri gruppi parlamentari affinché venissero studiati, depositati e formalizzati con la collaborazione del gruppo consiliare regionale di Forza Italia emendamenti al "decreto Soverato", abbiamo depositato una serie di interrogazioni al Ministero dei trasporti, al Presidente del Consiglio su alcune situazioni che abbiamo riscontrato nel corso di questi giorni e abbiamo cercato di conseguenza di guardare anche noi avanti.
Quest'oggi continuiamo a guardare avanti, però riteniamo che ciò non basti e riteniamo che, per evitare che si ripetano situazioni drammatiche come quelle che abbiamo vissuto in questa metà di ottobre, sia opportuno fermarsi anche un momento per guardare indietro, per capire il perché di ciò che è successo e devo dire che i diversi interventi che mi hanno preceduto, da quello dell'Assessore Vallet al Presidente della Giunta e agli altri colleghi Consiglieri, hanno a loro modo cercato di esaminare la situazione per dare delle risposte.
Ma noi riteniamo che sia necessario essere più severi con noi stessi, perché ci sono state delle vittime e noi riteniamo che le vittime meritino quanto meno il rispetto di un'analisi seria che tenga in considerazione ciò che è stato fatto, ma anche ciò che si doveva o che si poteva fare.
Vorrei soffermarmi, prima ancora che sull'analisi di alcune situazioni che vorrò sottoporre all'attenzione di quest'aula, su quella che è stata l'analisi dell'Assessore Vallet, Assessore alle opere pubbliche, che si occupa di conseguenza del territorio della nostra regione. È stata un'analisi che poteva essere probabilmente solo la premessa di un'analisi che arrivasse a proporre delle soluzioni, che arrivasse ad individuare quelli che erano stati i momenti critici dell'emergenza, invece, è stata un'ottima analisi, come tra l'altro titola la relazione che ci è stata distribuita, un'ottima analisi meteorologica!
L'Assessore ha indicato le quantità di pioggia, le quantità d'acqua, la velocità dell'acqua, ci ha detto come si sono comportate le varie aste fluviali delle vallate laterali e ha concluso con una serie di buoni propositi che dovranno essere applicati sul territorio. Penso che i buoni propositivi, Assessore, siano un po' poco, perché questa Giunta e lo stesso Assessore Vallet non sono un'Amministrazione di neofiti, un'Amministrazione che da pochi mesi si occupa del Governo di questa Regione. È un'Amministrazione invece che da parecchi lustri gestisce importanti risorse ed effettua importanti interventi, quantomeno dal punto di vista economico, per le gestioni delle risorse finanziarie che vengono contabilizzate; forse ha dimenticato di essere Assessore di lungo corso. Se questi buoni propositi possono essere accettati da un Assessore di fresca nomina, sono un po' poco per un Assessore che ha l'esperienza, perlomeno in termini di partecipazione al Governo valdostano, dell'Assessore Vallet.
È sorprendente, oltre che di cattivo gusto, me lo consenta, Assessore, la conclusione: che le montagne sono sempre venute giù, anzi penso che questa conclusione, oltre che essere di cattivo gusto, sia probabilmente anche la dimostrazione dei diversi punti di vista che si andranno ad evidenziare in questo dibattito.
Le montagne sono sempre venute giù. Sì, sono sempre venute giù, ma il problema è che le montagne prima di venire giù, studiando quella che è l'orogenesi, sono venute su perciò anche qui è questione di punti di vista, invece la maniera categorica con cui l'Assessore chiude la sua osservazione è la chiusura di chi si rende conto, e lo ha dichiarato, che le acque forse sono state un po' troppo imprigionate negli ultimi decenni.
E allora vorremmo capire qual è stato il ruolo che ha giocato la struttura presente sul territorio regionale, vorremmo capire qual è stato il ruolo della Protezione civile in questa vicenda tenendo presente che nell'etimologia del nome stesso risulta evidente che il compito primario della Protezione civile è la prevenzione e la protezione. Consolarsi con il fatto che i soccorsi siano stati efficaci ed efficienti riteniamo che sia una magra consolazione, perché comunque questa alluvione ha messo impietosamente in evidenza come qualcosa non abbia funzionato a livello di gestione della emergenza o meglio a livello di coordinamento dell'emergenza.
Riconosciamo che in diversi comuni la sensibilità, l'abilità di certi sindaci ha salvato le popolazioni di quelle comunità da disastri che invece si sono verificati in altri comuni, cito Pollein per tutti. Siamo rimasti sorpresi del fatto che in questa regione a martedì non si riuscisse ancora a comunicare con alcune località. Siamo consapevoli che il Presidente della Giunta si sia attivato chiedendo il "roaming" fra i vari gestori della telefonia mobile, ma è fattore notorio e risaputo che la Protezione civile debba andare al di là delle reti tradizionali utilizzate nella telecomunicazione.
Voglio ricordare come sin dal 1982 questa Amministrazione abbia emanato una serie di norme di legge con tanto di finanziamenti cospicui, parliamo di diversi miliardi, per coprire l'intero territorio della Valle d'Aosta ai fini delle radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile. Allora qui, Presidente, qualcosa non deve aver funzionato, perché queste leggi sono rimaste lettera morta, sono rimaste inattuate oppure è successo qualcosa che è andato al di là delle previsioni che tali leggi dovevano contenere, ma su questo nessuno ha dato risposte. Ci si è trincerati dietro il fenomeno dell'eccezionalità.
Nessuno mette in discussione che la pioggia sia stata tanta e che di conseguenza vi fosse particolare necessità di agire con eccezionalità di attenzione, con eccezionalità di misure. Noi invece ci trinceriamo semplicemente dietro l'eccezionalità dell'evento meteorologico e penso che sia difficile seguire il ragionamento storico interessante fatto dal collega Nicco, il quale dice, seguendo probabilmente l'onda de "le montagne sono sempre venute giù", che nel passato ci sono stati molti più morti di quanti non ce ne siano stati nel presente.
È anche vero che nel passato non c'erano tutte quelle strutture tecnologiche, quei mezzi che consentono oggi se non di prevenire quanto meno di evitare i drammi che comportano la perdita di vite umane; vorrei ricordare come in Florida i tifoni siano una realtà che non può essere bloccata dalla tecnologia, ma normalmente vengono preavvisate le popolazioni affinché quanto meno venga evitata la falcidia di vite umane.
Allora è stata semplicemente una fatalità che la montagna, Assessore, sia venuta già a Pollein? Penso di no. Sono convinto che anche lei sia consapevole che non sia una fatalità anche perché l'Assessore Vallet rispondendo a un'iniziativa che il nostro gruppo ha presentato in quest'aula nel luglio 1999, un'interpellanza con la quale il nostro gruppo chiedeva di conoscere - cito -: "? l'entità del pericolo e le misure messe in atto per i cittadini di Pollein?", l'Assessore affermava che il fenomeno franoso era stato segnalato nel giugno 1996 da privati cittadini alla Protezione civile e, diceva, che era stato posto sotto osservazione strumentale dall'estate 1997 con un sistema automatico di controllo in tempo reale dei movimenti. Sarà stato un sistema automatico di controllo in tempo reale, ma sicuramente il controllo in tempo reale è stato messo in atto un anno dopo rispetto al giugno 1996, ma questo è un altro discorso.
L'Assessore Vallet ci rispondeva che tale movimento franoso interessa la parete nord-occidentale della Becca di Nona, parlava di una mobilizzazione di mezzo milione di metri cubi di detrito e diceva testualmente: "? La particolare natura del fenomeno, cioè il movimento franoso, e la sua interazione con la dinamica idraulica del torrente Comboé potrebbero determinare potenziali rischi indiretti sulle aree abitate di Pollein e Charvensod localizzate sul conoide alluvionale del torrente al suo sbocco sul fondovalle principale". Rassicurava poi l'assemblea e i cittadini, dicendo: "? Sono state individuate specifiche procedure di controllo degli eventi e di gestione delle relative emergenze?".
Non voglio dire che l'Assessore Vallet sia colui che doveva andare a gestire l'emergenza, ma l'Assessore Vallet su un fatto del genere, dove lui era stato per certi versi sensibile nell'individuare la situazione, sensibile nel seguire la situazione, oggi come oggi non poteva e non doveva dare copertura politica a ciò che è accaduto nel Comune di Pollein.
Questo non lo accettiamo oggi, ma non lo accettiamo nemmeno domani e non lo accettiamo per rispetto a quelle persone che hanno pagato con la loro vita la fiducia che hanno riposto nelle istituzioni di questa Regione e quindi chiediamo oggi che venga tolta copertura politica a coloro che, avendo e ricoprendo incarichi di responsabilità amministrativa, si sono dimostrati inadeguati, si sono dimostrati inefficaci, si sono dimostrati in una parola non all'altezza del compito al quale erano stati preposti.
Questo noi vogliamo, questo noi qui pretendiamo, altrimenti, Assessore e Presidente della Giunta, questo Consiglio sarà una passerella come tante altre dove ognuno esprimerà i suoi punti di vista, dove ognuno esporrà le sue teorie, ma dove alla fine nessuno riuscirà concretamente ad incidere sulla realtà delle cose.
Riteniamo che, almeno a fronte di una situazione come quella che abbiamo vissuto, per un attimo vadano scoperte le carte, vada fatta chiarezza soprattutto per evitare il ripetersi di fatti simili, Presidente Viérin.
È stato detto che dovremo abituarci nel futuro al ripetersi in tempi sempre più ravvicinati di situazioni simili perché sono cambiate le condizioni climatiche, allora prendiamo esempio dalla Florida, prendiamo esempio da quelle realtà locali in cui si riesce a convivere con i fenomeni atmosferici evitando le situazioni drammatiche che la Valle d'Aosta ha vissuto in questo periodo.
Vorrei andare oltre, passando a quella che è la fase propositiva, perché abbiamo detto in esordio che ci siamo attivati sulla proposizione di una serie di iniziative, le abbiamo prospettate a livello parlamentare e le vogliamo peraltro riportare ampliandole anche nell'aula consiliare, affinché anche la forza di un'assemblea regionale possa incidere su quelle che sono le diverse sensibilità del Parlamento nazionale.
Di conseguenza depositeremo cinque risoluzioni, che non sto ad illustrare in questo intervento di carattere generale, ma che ci riserveremo di illustrare nell'ambito della discussione delle cinque risoluzioni, enunciando semplicemente che ce ne sarà una di carattere generale sulle sospensioni dei termini, sui contributi per la ricostruzione, sulle sospensioni anche del servizio di leva come peraltro anche il Presidente della Giunta ha chiesto in una sua comunicazione al Presidente del Consiglio; ci sono due risoluzioni di carattere particolare legate alle particolarità della situazione ferroviaria sul collegamento Aosta-Chivasso; c'è una risoluzione che riguarda un intervento che riteniamo doveroso e che ci fa piacere che il Presidente della Giunta abbia anticipato nella sua riflessione sui mutui di Finaosta; chiediamo, infine, alla luce anche di quanto è emerso dal mio intervento, ma anche di quanto è stato detto e stato scritto in questi quindici giorni, che ai sensi del Regolamento del Consiglio regionale venga costituita una commissione speciale di inchiesta che abbia il compito non di processare, ma semplicemente di accertare e di verificare l'evolversi degli eventi in quel drammatico fine settimana di mezz'ottobre.
Risoluzione n. 3 Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta
Premesso che la Valle d’Aosta è stata colpita nei giorni scorsi da un gravissimo evento alluvionale che ha causato morte e distruzioni;
Rilevato che la situazione è stata oggetto di un primo e parziale provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, che in particolare ha stabilito: contributi finanziari per il rientro nelle abitazioni e per la ripresa delle attività produttive; cassa integrazione straordinaria sino al 30/11/2000 estesa a tutti i settori; sospensione generale dei termini dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale sino al 31/12/2001; sospensione generale dei termini per i versamenti di natura tributaria (IRPEF, IVA, ecc?) e previdenziale sino al 31/10/2000; sospensione, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa in immobili dichiarati inagibili, dei termini per i versamenti previdenziali e patrimoniali sino al 31/12/2001;
Ritenuto che è urgente la necessità che vengano adottati, al fine di alleviare le sofferenze e i disagi causati dalla calamità naturale, provvedimenti ulteriori destinati a congelare gli oneri e a rinviare gli adempimenti inerenti l’ordinaria burocrazia, affinché tempi e risorse possano essere utilmente destinati alla difficile normalizzazione delle attività private ed economiche;
Invita
il Governo italiano, ad adottare ad integrazione del D.M. del 16/10/2000 e dell’ordinanza n° 3090 del 18/10/2000, ulteriori disposizioni urgenti e straordinarie con efficacia generale sull’intero territorio regionale in materia di termini e di servizio di leva, - analogamente a quanto già stabilito in situazioni simili - e, fatti salvi i provvedimenti già adottati, in particolare:
1) sospensione di sei mesi dei termini di prescrizione, di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza dalla data di lunedì 16 ottobre 2000;
2) sospensione per lo stesso periodo di tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché di ogni titolo di credito con forza esecutiva oltre alle rate dei mutui di qualsiasi genere, oltre agli adempimenti fiscali e previdenziali in scadenza nel medesimo periodo;
3) estensione della cassa integrazione straordinaria a tutti i settori - sino al 15/03/2001 - per i datori di lavoro aventi dipendenti - compresi gli apprendisti - sospesi o lavoranti a orario ridotto;
4) azioni finalizzate alle concessioni di finanziamenti agevolati per artigiani, commercianti, professionisti, imprenditori agricoli o industriali in genere, per la riattivazione urgente delle loro attività;
5) stanziamento, a favore dei proprietari d’immobili ad uso di residenza principale, di contributi a fondo perduto pari alla spesa per la costruzione o l’acquisto di un'unità abitativa con superficie abitabile corrispondente a quella distrutta;
6) stanziamento, a favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, di contributi a fondo perduto pari alla spesa per la ristrutturazione delle unità abitative danneggiate;
7) congedo, a domanda, dal servizio di leva per i residenti in regione già arruolati e dispensa, a domanda, per i prossimi scaglioni del 2000-2001.
F.to: Frassy - Tibaldi - Lattanzi
Risoluzione n. 4 Premesso
- che l'alluvione ha avuto effetti devastanti sia sulle infrastrutture pubbliche sia sul patrimonio privato;
- che tra gli immobili danneggiati alcuni sono ancora gravati dai mutui contratti a suo tempo per il loro acquisto o la loro costruzione;
- che molteplici mutui sono stati erogati dalla finanziaria regionale, Finaosta;
- che è realistico prevedere per il prossimo anno un calo del PIL regionale;
il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Impegna
la Giunta a:
1) attivare una sospensione sino al 31/12/20001 - senza aggravio di interessi - di tutte le rate dei mutui Finaosta inerenti gli immobili residenziali o produttivi danneggiati dall'alluvione;
2) ad estendere tale sospensione a coloro i quali pur non danneggiati nel patrimonio immobiliare documentino una difficoltà finanziaria conseguente ai danni provocati dall'alluvione;
3) a quantificare l'esposizione finanziaria di Finaosta relativamente agli immobili distrutti o gravemente danneggiati, ai fini di verificare la possibilità di attuare misure più incisive di alleggerimento degli oneri dei proprietari.
F.to: Frassy - Tibaldi - Lattanzi
Risoluzione n. 5 Premesso
- che la linea ferroviaria Torino-Aosta nella tratta Chivasso-Aosta è rimasta gravemente danneggiata dall'alluvione che ha colpito le regioni del nord-ovest;
- che per ripristinare binari divelti, massicciate franate, gallerie ostruite dal fango, ponti crollati o pericolanti, stazioni inagibili, sistemi automatici di controllo sono stati annunciati dai mass-media tempi superiori all'anno;
Rilevato
- che la tratta Chivasso-Aosta è obsoleta per la tortuosità del percorso, che non consente velocità medie superiori a 90 km/h, per l'assenza di elettrificazione, per la presenza di un unico binario;
- che da oltre venti anni le FF.SS. hanno a più riprese ipotizzato e condiviso la necessità di un ammodernamento del percorso, al fine di renderlo più veloce e più sicuro;
- che nella legge finanziaria 1999 lo Stato italiano ha stanziato 5 miliardi per studi inerenti la fattibilità del collegamento ferroviario Chivasso-Aosta-Martigny, la cui realizzazione comporterebbe l'imprescindibile necessità di rifacimento dell'attuale tratta Chivasso-Aosta;
il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Invita
il Governo italiano a:
1) predisporre in tempi brevissimi con provvedimenti urgenti d'intesa con l'azienda Ferrovie dello Stato S.p.A. uno studio preliminare di massima comparativo dei tempi e dei costi tra il ripristino del vecchio tracciato e l'ammodernamento di tale tratta, prevedendone la rettificazione, l'elettrificazione e il raddoppio dei binari;
2) aprire un tavolo di confronto con la Regione al fine di valutare, alla luce degli ingenti danni causati dall'alluvione, i tempi e i modi di riapertura del collegamento ferroviario Torino-Aosta.
F.to: Frassy - Tibaldi - Lattanzi;
Risoluzione n. 6 Premesso
- che la linea ferroviaria Torino-Aosta nella tratta Chivasso-Aosta è rimasta gravemente danneggiata dall'alluvione che ha colpito le regioni del nord-ovest;
- che nella Regione Valle d'Aosta il trasporto ferroviario è attualmente limitato alla linea Aosta - Pré-Saint-Didier, alla quale peraltro non sono garantite tutte le corse previste per la carenza del numero di motrici disponibili, in quanto al momento dell'interruzione della direttrice con Chivasso il materiale rotabile era fuori dalla stazione di Aosta;
- che nelle stazioni di Châtillon e di Ivrea vi sono ferme ed inutilizzate per l'impraticabilità della linea diverse motrici;
- che in direzione Torino la tratta con minimi lavori di ripristino potrebbe essere riaperta sino a Nus, località a 12 chilometri da Aosta, consentendo così un servizio metropolitano a beneficio del traffico stradale reso difficile per i danni dell'alluvione;
il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Invita
il Governo italiano a:
1) agire in tempi brevissimi per la riapertura della tratta ferroviaria Aosta-Nus;
2) trasferire con urgenza sulla linea Aosta-Pré-Saint-Didier le motrici necessarie al pieno espletamento del servizio.
F.to: Frassy - Tibaldi - Lattanzi
Risoluzione n. 7 Considerata la gravità dei tragici eventi della recente alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta, creando vittime e danni straordinari;
Verificata la non omogeneità di danni subiti da cose o persone;
Evidenziato lo svolgimento diversificato dei sistemi di monitoraggio e controllo del territorio valdostano;
Preso atto del funzionamento anomalo di allerta e evacuazioni del piano di protezione civile in alcuni siti;
il Consiglio regionale
Costituisce
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale una Commissione di inchiesta speciale con il compito di:
1) analizzare dati e testimonianze dell’evento calamitoso;
2) accertare il funzionamento della rete della protezione civile regionale in termini di prevenzione e attuazioni dei piani di emergenza e protezione della popolazione;
3) redigere, entro 90 giorni, dal suo insediamento una relazione dettagliata al Consiglio regionale sulle cause e sulle eventuali responsabilità accertate.
F.to: Lattanzi - Tibaldi - Frassy
PrésidentLa parole au Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Avevo preparato un intervento che devo constatare è stato in molti punti anticipato da alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me, non me ne rammarico, mi fa piacere perché ci sono delle riflessioni comuni che sono particolarmente importanti e che avevo colto.
Mi sono riletto alcuni passaggi di una pubblicazione fatta dall'Abbé Vescoz, peraltro citata dal Presidente della Giunta dove si parlava di cataclysme e fenomeni meteorologici che avevano fatto sentire i loro effetti nella nostra regione.
Devo dire che ci sono alcuni passaggi che, se uno fa astrazione dalla data, sembrano attuali; la stessa lettura dell'evento del mese di ottobre del 1846, fra l'altro l'evento che ci ha interessato si è verificato nei giorni 15 e 16 e là era il 18, quindi c'è anche una concomitanza di date puntuali, cita gli stessi paesi: il borgo di Nus che viene minacciato, il Comune di Cogne che viene devastato, Donnas con il borgo che viene invaso dalle acque e minacciato di distruzione, perfino il torrente di Valdobbia che è quello che ha creato questa volta i problemi in quel di Gressoney.
Ci è stato detto anche dell'evento di Verrès che aveva causato 80 morti sei anni prima.
C'è però un dato che mi ha colpito: oggi stiamo riflettendo su un evento che ci ha colpito e che ha portato in inventario però delle precipitazioni di 240 millimetri teoricamente in 4 giorni perché in realtà il grosso si è verificato in 2 giorni o poco più. L'evento di Verrès è stato determinato da una pioggia di 80 millimetri. Questo per dire come la situazione della nostra realtà sia molto delicata.
Allora come oggi la gente si interrogava sulle presunte follie meteorologiche imputando ai più diversi fattori queste precipitazioni ritenute eccezionali tanto da causare dei disastri. Siccome non erano ancora stati scoperti l'effetto serra e il buco dell'ozono si attribuivano queste piogge anomale al taglio delle piante e al raffreddamento del clima; che invece si stava riscaldando.
Si suppone essere in atto un cambiamento climatico, ma è presumibile ch'esso resti comunque nella fascia centrale dell'arco che comprende le variazioni meteorologiche conosciute dall'uomo in tempi relativamente recenti e poi i cambiamenti climatici veri hanno tempi di realizzo ben più lunghi di quelli che stiamo decifrando.
Poco o niente di nuovo dunque, pur considerando che in questo secolo gli eventi alluvionali non sono mancati: 1911, 1920, 1948, 1957, 1978, 1993, 2000, ma sostenere che queste calamità sono peggiori di quelle del passato è molto azzardato e scientificamente poco sostenibile; considerato che mancano molti riferimenti parametrici e poi basti pensare all'alluvione già citata della metà del 1700, catastrofica per quei tempi, ma lo sarebbe stata anche per questi, eravamo nel periodo della piccola glaciazione, al centro di una fase di raffreddamento climatico.
Quando avvengono queste calamità diventa consuetudine affermare che gli eventi sono o erano rigorosamente eccezionali. Credo che alla fine il problema non è l'eccezionalità, concetto peraltro molto vago se riferito ai fenomeni naturali e in particolare a quelli climatici.
In ogni paese si registra da tempo immemorabile il ripetersi più o meno frequente di eventi naturali che creano disastri. Il problema vero è la dimensione delle forze che la natura riesce a mettere in gioco e la modestia della dimensione umana. Per i territori come il nostro a ciò si aggiunge la fragilità ecosistemica della montagna che proprio nel momento in cui si manifesta esprime una potenza distruttrice immensa.
In montagna ogni aspetto si estremizza, dalle escursioni termiche alla velocità di discesa delle acque al loro trasporto solido, dall'azione fortemente regimante delle foreste agli effetti negativi delle piante in alveo, la legge di gravità qui si esprime impietosamente e quasi senza condizionamenti.
Piogge intense e di breve durata, dell'ordine di 50-60 mm/g, oggi come ieri hanno determinato situazioni di crisi nei torrenti, con effetti disastrosi. Eppure non si possono chiamare quelle piogge eccezionali dal momento che ne abbiamo avute di quelle che hanno superato i 260 mm/g.
Se in un intero sistema montuoso avviene un'alluvione è perché il fenomeno meteorologico è molto vasto e coinvolge aree geografiche significative.
La Valle d'Aosta non è mai stata alluvionata da sola, ma ciò è avvenuto assieme ad altri territori e in particolare alla pianura, ma possiamo ritenere eccezionale l'alluvione in pianura quando la pianura è fatta di milioni di strati alluvionali? Dobbiamo dunque assumere il concetto di eccezionalità di alcuni eventi con riferimento alla vita media dell'uomo o di un periodo storico, ma che sono da ritenersi del tutto normali e fisiologici per i tempi della natura e dei suoi cicli.
Lo voglio solo ripetere qui, ma non mi dilungo sul riferimento dell'uomo come attore principale dei processi di degrado che sono causa delle calamità, questa è una sintesi che risponde ad una visione antropocentrica, semplicistica e non molto razionale.
L'uomo subisce gli effetti della fragilità della montagna e talora nell'estremo tentativo, persino goffo se rapportato alla dimensione delle forze che si mettono in movimento, di porre rimedio a situazioni gravi si espone maggiormente con risultati vani e a volte tragici.
È indubbio che in montagna più che altrove l'uomo è il primo a pagare, anche con la vita, per gli interventi che contribuiscono a rendere più vulnerabili gli equilibri già precari.
La fragilità della montagna e quindi l'esistenza del pericolo sono una costante di cui dobbiamo prendere atto; certo vi sono da noi angoli con minori rischi rispetto ad altri, ma essi sono di dimensioni e di localizzazione tali da ospitare in relativa sicurezza meno di un terzo dell'attuale presenza umana e dei suoi annessi.
L'uomo ha preso consapevolezza di questi rischi da tempi immemorabili; la stessa forma della città di Aosta fa capire come ai romani fossero ben note le intemperanze della Dora e del Buthier.
Il gioco è terribile perché ha quale posta la vita o i beni fondamentali e si basa sul rischio calcolato e quindi prevedibile e gestibile, anche se gli elementi di riferimento, date le variabili in causa, sono molti e incerti.
L'approfondimento su quanto avvenuto deve servire per il futuro ed essere illuminante per fare diminuire i pericoli tenendo conto dell'alto livello di occupazione del territorio e avendo consapevolezza che il rischio zero da noi non c'è.
L'emergenza ha certamente messo in rilievo alcuni punti deboli nel sistema complessivo di protezione civile sebbene, come è stato rilevato, grazie anche alla capacità di autogestione degli enti locali e l'efficienza e la dedizione dei singoli apparati già richiamati, nel suo insieme abbia dato risultati soddisfacenti.
È sfuggito un dato ovvero che per certi versi si è trattato del primo vero collaudo dell'apparato, avvenuto purtroppo in condizioni drammatiche.
La nostra Protezione civile, eccellente in più di un settore, ma giovane di esperienze così complessive, si è trovata, senza paragoni del passato, a gestire un'emergenza globale, di notevole gravità e di relativamente lunga durata. Forzatamente di colpo essa è maturata attraverso un sofferto, ma propedeutico e doloroso passaggio. L'esperienza è sofferenza.
Mi sono sentito dire su alcuni soccorritori venuti da altri paesi che sono bravi, efficienti, organizzati, ma sono passati da esperienze di questo tipo due, tre, quattro volte.
Alle domande che i cittadini si pongono su cosa ha funzionato e cosa no o sulle risposte ad alcuni problemi, perché occorre dare delle risposte oneste e veritiere, è necessaria una decantazione degli elementi in sospensione che non permettono una limpida decifrazione dei fatti. È un'attitudine umanamente comprensibile e rispettabile quella di chi, essendo stato colpito, ritiene di rilevare delle possibili mancanze e di individuare in alcune persone o in determinati apparati delle responsabilità. In questa fase le certezze categoriche espresse da talune forze politiche sull'inefficacia del Dipartimento di Protezione civile e le valutazioni tassativamente colpevoliste verso l'operato di vari responsabili non contribuiscono a creare un clima costruttivo.
Agendo in questo modo è possibile fare confusione tra ciò che può non aver funzionato al meglio nel sistema complessivo di protezione civile, al di là di colpe e di responsabilità oggettive, dal lavoro meritorio dei tanti singoli protagonisti. Sarebbe una grande ingiustizia quella di mortificare un impegno e una dedizione generalmente encomiabili. Prendiamo atto che vi sono organismi che sono attivi per esaminare sotto il profilo delle responsabilità tutta la vicenda.
La politica io credo debba dare in modo determinato, ma equidistante il suo contributo alla trasparenza e alla conoscenza sui fatti. In questa direzione ritengo opportuno che in III Commissione, senza alcun intento inquisitorio, si debba avviare un approfondimento su tutti gli aspetti di questa calamità, compresa la gestione dell'emergenza.
Voglio dare un'altra chiave di lettura all'emergenza riprendendo alcuni dati che ha già citato l'Assessore Vallet.
Mediamente un terzo, con cuspidi di due terzi in alcune zone, delle intere precipitazioni annuali sono cadute in due giorni. Teniamo conto che parte di questa pioggia ha sciolto e portato con sé un numero indeterminato di milioni di metri cubi di neve precedentemente caduta.
Anche qui non c'è niente di nuovo perché se si va a rileggere quello che è successo nel 1846, proprio in quei giorni lì ci fu un rialzo termico, ma a parte questo, nelle punte di massima piena la Dora Baltea smaltiva all'uscita della Valle oltre un milione e settecentomila metri cubi l'ora, 2.500 metri cubi al secondo, quasi cinque volte la media della sua portata massima annuale, ma fra questi due fenomeni, l'arrivo e l'uscita, resta indeterminato l'enorme quantitativo di materiale che è stato movimentato prima con il suo prelievo e quindi depositato dentro e attorno ai corsi d'acqua.
La nostra società si è trovata all'interno di questo spaventoso sviluppo di energia distruttiva, di cui farò cenno più avanti, alla fine del quale probabilmente neppure nel momento del suo parossismo si è avuta in termini di percezione media, di quale entità è stata.
Tra gli argomenti fondamentali oggetto di confronto è il rapporto esistente tra catastrofe e pianificazione territoriale.
Il laconico divieto di edificazione a distanza, per altro minimale, dai corsi d'acqua stabilito del RD n. 523 del 1904, ha dimostrato la sua debolezza e la sua inefficacia in rapporto agli eventi di criticità delle aste torrentizie e di quella fluviale così come una serie di azioni in esso previste per una difesa attiva sono solo parzialmente state attuate o sono cadute in disuso.
Nel frattempo si è determinata una situazione molto ibrida. La crescita della popolazione e lo sviluppo sociale hanno favorito la realizzazione di insediamenti in zone più esposte di altre ai dissesti, ma anche in spazi territoriali che l'economia rurale aveva riservato all'agricoltura, senza alcun riferimento alla sicurezza, semmai alla fertilità. Molti nuclei abitativi storici non sono meno a rischio di altri centri più moderni e non si contano quelli che da tempo immemorabile sono sorti in adiacenza ai corsi d'acqua. Per contro la realizzazione di infrastrutture ha esposto al rischio situazioni che non lo erano. Infine stati di pericolosità si sono prodotti in seguito alla naturale evoluzione dei processi di modellamento della superficie.
La legge 28 aprile 1960 prevedeva che il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico indicasse le zone della Valle d'Aosta in cui "? sia inibita ogni attività edificatoria?"; è presumibile che tra queste ci fossero quelle esposte a pericoli di alluvione, frane e valanghe. Per la sua complessità e per le vicende che hanno interessato tale norma questa individuazione non è mai stata fatta.
Successivamente la legge regionale n. 14/1978 stabilì all'articolo 1 che sui terreni "? sedi di frane e di alluvioni o di smottamenti, in atto o potenziali, e sui terreni soggetti al rischio di valanghe o di slavine?" era vietata l'edificazione. Con legge regionale 9 giugno 1981 n. 32 veniva data puntuale definizione di tali aree che vi risparmio. L'articolo 1 di questa legge al secondo comma prevedeva che: "I comuni sono, comunque, tenuti a individuare e delimitare in cartografia catastale i terreni di cui sopra in base alle indicazioni e definizioni richiamate, con deliberazione del consiglio comunale; tale cartografia costituisce elaborato integrativo del piano regolatore generale?" eccetera.
In questi giorni è stata reiteratamente richiamata l'inerzia da parte dei comuni nella predisposizione di questa cartografia. È indubbiamente vero, ma essa va messa in relazione all'oggettiva difficoltà di individuare queste aree sulla base di criteri vaghi e opinabili di cui alla definizione della legge: a memoria d'uomo, fenomeni prevedibili, terreni soggetti ad alluvioni, eccetera. Inoltre il disposto normativo non prevedeva alcuna differenziazione d'uso in rapporto al tipo di evento calamitoso imponendo su queste aree un vincolo penalizzante che impediva l'uso di essi anche quando compatibile con determinati caratteristiche del rischio stesso.
L'obbligo di effettuare nella pianificazione urbanistica la cartografia delle zone a rischio di dissesti, successivamente è stato ribadito con la legge n. 44/1994. In essa si stabiliva che i comuni si sarebbero dovuti dotare di questa cartografia su base catastale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, in difetto avrebbe provveduto la Giunta regionale. Questa cartografia era parte integrante del piano regolatore e doveva essere aggiornata secondo le modificazioni che si verificavano sul territorio.
Infine in coerenza con le prescrizioni del PTP questo obbligo è stato reiterato con la legge regionale n. 11/1998, la quale prevedeva tra 1'altro nuovamente il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia. La norma metteva in capo alla Giunta regionale l'onere di formulare i criteri con i quali procedere all'individuazione delle aree prevedendo una diversificata tipologia e pressione vincolistica a seconda del tipo e della gravità del rischio esistente per le singole aree. Questo adempimento è stato assolto dalla Giunta regionale con provvedimento n. 422 del 15 febbraio 1999, quindi meno di un anno e non mi pare che si possa dire che la Giunta sia stata inerte.
La domanda che viene posta è: quale relazione c'è tra le vite umane perse e i danni subiti in questa calamità e la mancata dotazione dello strumento cartografico richiamato e reso obbligatorio 19 anni or sono? Chi mette in diretta relazione le due questioni o che sostiene che, siccome non c'era la cartografia degli ambiti inedificabili perché soggetti a frane, valanghe e alluvioni, si è costruito in zone eccessivamente esposte tanto da essere colpite in questo o in precedenti eventi, esprime una valutazione molto superficiale e non corretta.
Primo perché non è vero che ci sia stato un livello di irresponsabilità così diffuso da parte dei professionisti che hanno elaborato i piani regolatori e degli amministratori locali da proporre l'edificazione di zone evidentemente esposte.
Secondo perché i piani e dunque le relative zonizzazioni erano preventivamente esaminati dai tecnici delle diverse strutture regionali, i quali esprimevano pareri, peraltro vincolanti proprio in merito ai potenziali pericoli naturali come frane e alluvioni. Essi avevano l'incarico di evidenziare e proporre l'esclusione dalle zone di insediamenti urbani le aree esposte.
Terzo perché sui piani regolatori predisposti dopo il 1978 veniva espresso un parere da parte di un'apposita commissione (CRPT prima e Commissione per la pianificazione dopo) della quale facevano parte tecnici specializzati nelle varie discipline, interni ed esterni alla Regione, tra i quali si contavano quelli in geologia, sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria, eccetera. Questo parere è sempre stato tenuto nella massima considerazione dall'Esecutivo regionale, soprattutto nel caso di valutazioni negative aventi riferimento con l'ambiente e la sicurezza.
Questa procedura ha tolto importanza alla cartografia consentendo di approvare i piani in assenza di essa. Di questa opinione doveva essere anche il precedente Assessore all'urbanistica che ha proposto l'approvazione di ben 21 piani regolatori con o senza cartografia. Quello che non si capisce è come mai ora egli accusi di inadempienza e di leggerezza le passate Giunte per le decisioni assunte in mancanza di essa, si scandalizza per la mancanza di essa.
La cartografia costituisce uno strumento importante in quanto fotografa una situazione e rafforza in prospettiva l'imposizione del vincolo, ma non lo impone. Esso è deciso a monte della cartografia e si concretizza nel momento in cui è individuato il rischio e si sottrae l'area che ne è esposta ad insediamenti edili. Il vincolo di inedificabilità precede la cartografia, non la segue.
È già stato detto che certe relazioni non sono così immediate perché basti pensare che le aree a rischio che sono state individuate, le famose R4 citate anche da un ministro, nel corso di questa emergenza hanno determinato delle situazioni di crisi pressoché irrilevanti, mentre sono state interessate delle aree ritenute al di fuori di ogni evento calamitoso.
È possibile che la recente edificazione abbia interessato anche delle aree esposte, ma questo è dovuto alla sua inesistenza ovvero all'impossibilità di previsione della sua esistenza in sede di predisposizione della pianificazione.
Alla luce di quanto detto non è dunque corretto affermare che si è lasciato il territorio all'edificazione selvaggia ignorando i rischi esistenti, fatto salvo qualche dettaglio che è difficile estrapolare da un contesto generale.
Il recente evento calamitoso impone di aggiornare la situazione delle aree interessate da frane e alluvioni non tanto da un punto di vista cartografico quanto sostanziale e di accelerare i tempi delle consultazioni e delle concertazioni per la definitiva perimetrazione, ma costituisce un ulteriore riferimento perché i vari responsabili individuino i siti e le modalità vincolistiche con il maggiore rigore possibile. Sono decisioni che vengono assunte nell'interesse tanto della collettività quanto dei singoli cittadini, per questo devono essere improntate all'insegna della prudenza e della corretta valutazione della capacità di annullare o mitigare i rischi da parte delle opere di prevenzione e di difesa idrogeologica.
Infine mi si permetta di rilevare che, per quanto riguarda le frane, le valanghe e le esondazioni disastrose di lave torrentizie, il problema è tutto peculiare alla montagna e sta a noi affrontarlo e risolverlo, ma in fatto di alluvioni lascia perplesso sentire fare del sentenzialismo accusatorio da parte di cittadini che arrivano da paesi che sono una sfida ai fiumi. A noi non è mai passato per la testa, quando abbiamo visto con apprensione e dolore alluvionare città italiane ed europee, di dire che ciò è successo perché si è costruito eccessivamente o eccessivamente in vicinanza del fiume. Saremmo grati se ci riservassero il medesimo riguardo.
Mi rifiuto di accettare il principio secondo il quale ciò che per altri è sviluppo economico, come l'urbanizzazione, il progresso, i servizi e le infrastrutture, dicevo, quello che per altri è sviluppo economico e crescita sociale, da noi è degrado fisico e morale.
Il secondo tema sul quale ci sono valutazioni contrastanti è quello delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali.
Dirò subito che è un errore ipotizzare che le sistemazioni idraulico-forestali ancorché potenziate e perfezionate, possano essere definitivamente risolutive per i tutti i problemi idrogeologici.
Vi è però la certezza, perché scientificamente dimostrata, che esse consentono di migliorare l'intero sistema idrogeologico interno ed esterno alla Valle, nel caso specifico, e sono risolutive per situazioni di criticità puntuale sul territorio e su singoli tratti dei corsi d'acqua. La questione nodale è che non è semplice dimensionare le opere in base all'entità della criticità, non ultimo per le difficoltà poste in sede di loro previsione; nel caso dei torrenti a causa soprattutto della variabile più indeterminata ossia il trasporto solido e nel caso delle frane l'ubicazione e la dimensione.
Ma il lavoro sino qui compiuto sulle pendici e sulle aste torrentizie e su quella fluviale hanno dato una grande e positiva risposta. Senza le opere eseguite, lo abbiamo constatato in questa come in tutte le altre calamità di questo tipo e in alcuni eventi di piena che hanno interessato singole aste torrentizie, le conseguenze sarebbero state molto più gravi forse anche in termini di vite umane. Prima di spendere alcune considerazioni in merito alle sistemazioni idrauliche intendo esprimere tutto il mio disappunto nei confronti delle dichiarazioni fatte dall'On. Turroni del gruppo Verde in merito agli interventi realizzati sui corpi idrici negli anni '80.
Quelle affermazioni sollecitate da uno strumentale passaggio di veline da parte di qualche personaggio locale, oltre a rappresentare un colpo nella schiena di una Valle d'Aosta già profondamente ferita, sono nel merito dogli interventi palesemente false. Ritengo che un personaggio investito della carica dell'On. Turroni, prima di lanciarsi in simili pesanti accuse in un momento così delicato, aveva il dovere di accertarsi della loro fondatezza.
Quegli interventi di sistemazione idrogeologica, apparentemente massicci, erano sollecitati da situazioni di rischio e di degrado pregresse, aggravate dalle conseguenze dell'alluvione del 1978. Essi furono quanto mai provvidenziali. Non ho remore ad esprimere, anche a nome di tutti coloro che hanno operato sul territorio nei momenti difficili di emergenze alluvionali, un sentito ringraziamento agli uomini politici, agli amministratori, ai tecnici e ai funzionari che hanno avuto parte attiva nella realizzazione di tutte le opere regimanti e di stabilizzazione dei versanti in qualsiasi tempo eseguite. Oggi sono in molti a poter dire che se hanno ancora la casa (tra l'altro vecchia di qualche secolo), l'azienda e forse la vita è stato grazie ad essi. Mi piacerebbe sapere chi in buona fede può provare di avere avuto un danno da quegli interventi.
Vi sono sistemazioni intensive eseguite fin dal secolo scorso e altre più recenti, tra le quali molte di quelle incriminate che hanno realizzato la risoluzione di criticità con la totale assunzione nel contesto naturale delle opere stesse. Certo si poteva e si può fare di meglio, forse si sono commessi anche degli errori, ma ciò rientra nella dimensione umana e costituisce un passaggio per crescere in esperienza, il prenderne atto non deve diventare un motivo per disprezzare e denigrare l'opera compiuta.
Il reticolo idrologico regionale ha una lunghezza di circa 1.100 chilometri, gli interventi realizzati a tutt'oggi hanno interessato in modo discontinuo e su tratti puntuali 50, 60 chilometri tra aste torrentizie e quella fluviale; ciò significa sì e no il 6 - 7 percento dell'intero tessuto.
È stato detto con molta enfasi e poco rigore tecnico-scientifico che le arginature avrebbero aumentato la velocità e conseguentemente determinato un accorciamento dei tempi delle piene e una maggiore violenza delle stesse con ciò aggravando pesantemente i loro effetti. Sono accuse che meritano delle risposte.
Quando ci si riferisce alle arginature o alla stabilizzazione del fondo l'effetto velocità, peraltro di incidenza irrilevante per rapporto alla lunghezza dei singoli corsi d'acqua, è ampiamente compensato dalla mancanza di quello molto più distruttivo dell'erosione. Se si chiamano in causa le sistemazioni degli alvei sulle conoidi, che rappresentano le opere più evidenti, ricordo che esse sono realizzate con la creazione di soglie o di briglie, che agiscono creando il gioco della caduta e della ripresa della corrente, ma quest'ultima avviene in tratti di pendenza artificialmente ridotta allo scopo di mitigare la velocità. Esse realizzano poi la trattenuta, in assenza di erosione, di parte del materiale presente nei deflussi, ciò avviene in occasione delle piene critiche dove il deflusso è costituito da lave torrentizie ricche di materiale in sospensione anche di notevole dimensione. Si tratta di flussi che non sono costanti, ma procedono a pulsione e con alternanza di depositi e trasporti, che nell'insieme determinano un andamento simile a quello naturale, ma anche qui in assenza di erosioni.
L'aumento di velocità avviene nel caso di correnti esclusivamente idriche per la diminuzione del coefficiente di attrito, ma esse sono puramente teoriche quando le piene sono uguali a quelle che abbiamo avuto in questa alluvione.
Con uno studio condotto dal Politecnico di Milano si è appurato come su uno di questi torrenti regimati, la sistemazione del tratto terminale, lungo la conoide, determinava una variazione della velocità di deflusso del tutto insignificante, il che è comprensibile tenuto conto in questo, come nella generalità dei casi analoghi, che il tratto regimato è sempre inferiore dell'uno percento dell'intera lunghezza dell'asta (per lo più è al di sotto dello 0,5 percento), per cui il potenziale e teorico decremento di tempo su acque pulite non può che essere ad esso proporzionale.
Prendo atto con molto rammarico delle affermazioni che sono state ribadite in questa sede secondo le quali sono da imputare alcuni danni, alla Bassa Valle e al Canavese, alle opere di regimazione realizzate nei bacini valdostani. Sono affermazioni gravissime che mettono in moto pesanti sospetti e pericolose prese di posizioni contro la nostra Regione. Un semplice confronto dell'evoluzione della piena con la cronologia e le quantità dogli afflussi meteorici registrati ai pluviografi e alle temperature, dimostra la coerenza dei fenomeni e la congruità dei tempi in cui si sono realizzate le piene e la dimensione delle portate.
Mi viene da pensare che se mettiamo assieme tutta la serie di affermazioni e valutazioni gratuite e tendenziose ampiamente riportate dagli organi di stampa, pare di cogliere un tentativo, sostenuto anche da forze politiche qui presenti, di prendere a pretesto questo tragico evento per processare la Valle d'Aosta con l'intento nemmeno tanto occultato di mettere in discussione la sua autonomia.
È un tentativo che va rigettato con forza senza con ciò proporre alcuna forma di resistenza alla necessità di fare chiarezza o rifiutare un esame critico e obiettivo su quanto si è fatto, si poteva e si doveva fare o non fare e ancor meno di sfuggire alla ricerca necessaria ad individuare responsabilità di ogni genere e a chi sono in capo, quelle politiche comprese.
Credo sia importante, e su questo concordo, che la Dora, ma per la Dora il problema dovrebbe essere risolto, e in particolare i torrenti abbiano delle casse di espansione per poter esondare liberamente in caso di piena. Sarebbe pertanto opportuno, utile ed economico evitare di eseguire o rieseguire delle arginature per riportare il letto dei torrenti all'interno di sezioni artificiali che probabilmente non reggeranno alle prossime piene.
Detto questo, dobbiamo essere più convinti sull'opportunità e sulle modalità con le quali dobbiamo realizzare invece le opere che prevedono una puntuale difesa e regimazione dei corsi d'acqua e qui forse una certa responsabilità dei Verdi, già richiamata, mi permetto di sottolinearla.
A proposito di metodologie faccio presente a questa Assemblea che se fossi il responsabile di un qualche ufficio preposto al settore delle sistemazioni idrauliche, mi rifiuterei nel modo più categorico, alla luce di una serie di esperienze, di approvare oggi la realizzazione di un'opera di regimazione intensiva come quelle che si debbono ancora fare o che si dovranno rifare in vicinanza e in difesa dei centri abitati, ovvero quelle destinate a trattenere il grosso materiale per mettere in sicurezza valori importanti come la diretta salvaguardia dell'incolumità pubblica, mi rifiuterei di approvarle se tali opere non sono previste in calcestruzzo armato e ben fondato.
Questa calamità ha confermato come gli argini costruiti in muratura, e che qualcuno voleva pure solo a secco, anche se correttamente eseguiti non resistono per lungo tempo a sollecitazioni dinamiche e a urti reiterati come sono quelle prodotte nel corso delle piene dalle acque ricche di materiale trasportato ovvero di lave torrentizie. In pratica dopo ogni piena queste opere dovrebbero essere rifatte, anche se apparentemente integre, ma il più delle volte non reggono sino alla fine dell'evento. Vi risparmio la spiegazione ma, se qualcuno lo vorrà, nel dettaglio gli farò la dimostrazione di quanto sostenuto.
Quello che invece mi preme sottolineare è che bisogna che questo Consiglio prenda atto che non si possono subordinare le esigenze di sicurezza alle esigenze personali, estetiche o a certi pruriti che propongono soluzioni tanto romantiche quanto inefficaci.
Il problema inizia dalle progettazioni che vanno affidate con criteri di professionalità a professionisti che conoscono la materia e non in base solo a certe regole che ritengo piuttosto dannose.
Si è già parlato della questione dei ponti.
Un altro pesante condizionamento che deve essere rimosso è quello relativo all'occupazione del suolo. Non si può pretendere che si facciano delle sistemazioni idrauliche efficaci anteponendo il principio della minima occupazione del suolo, quindi ridurre oltre il lecito le sezioni o far fare al torrente curve innaturali spesso susseguenti per evitare di toccare questo o quel terreno. Le curve sono dei punti di grande debolezza e generano l'effetto frusta delle correnti idrauliche e dei materiali trasportati.
Ci deve essere consapevolezza che i nostri torrenti e la Dora Baltea non si prestano, se non in piccolissima misura, per le sistemazioni di tipo bioingegneristico. A fronte delle sollecitazioni a cui sono sottoposte queste opere, si rischia il ridicolo a proporle; è vero che alcune di esse possono servire ad attenuare gli impatti visivi delle sistemazioni, possono essere complementari a queste, ma non le surrogano, si cade nel ridicolo a proporle, si cade nel tragico se ci si affida a loro.
Negli ultimi duecento anni, oggi compreso, ci sono testimonianze significative dell'esecuzione di opere bioingegneristiche che non sono né recenti per ideazione né passate di moda. In qualche caso queste tecniche si sono usate anche sulle aste torrentizie, ma per risolvere situazioni sopportabili e temporanee in attesa della rimarginazione e della stabilizzazione naturale in quanto questo era possibile, previsto e in tale modo veniva aiutata.
Ma in generale queste forze hanno bisogno di risposte tecniche che non possono avere dei condizionamenti se riferiti alla loro efficacia e alla loro strutturazione.
E qui chiamo in causa il processo di decementificazione; c'è stato un processo di decementificazione, ma è stato operato sui corsi d'acqua di pianura, ma non è stata mai presa in considerazione né in Italia né all'estero per quelle aste torrentizie costantemente sollecitate da piene laviche o dal trasporto di materiale lapideo di grosse dimensioni come sono quelle di montagna.
Sulle sistemazioni idrauliche credo che uno dei passaggi più importante sia quello di dare continuità agli interventi; è stato detto giustamente dall'Assessore, del quale ho apprezzato i contenuti della relazione e anche il discorso in prospettiva, che uno dei punti deboli di quanto è stato fatto finora è che sovente non si è data sufficiente continuità alle opere di manutenzione dei corsi d'acqua.
È appunto quello della continuità dei finanziamenti un tema importante, presente peraltro in alcune dichiarazioni rese alla Commissione ambiente della Camera da parte del Responsabile del Magistero per il Po, il quale sostiene che dare continuità significa provvedere costantemente alla manutenzione, anche talvolta un po' petulante dei corsi d'acqua; questo dovrà essere un obiettivo da perseguire con molta determinazione nel futuro.
Voglio ritornare su un episodio perché non vorrei che si ripetesse in quei termini nel futuro. Ho sentito in questo periodo rievocare la sistemazione del torrente Chamois come esempio di un'opera dannosa. Per memoria faccio presente che quel torrente aveva iniziato un processo erosivo molto pericoloso e incidente innescato da un fenomeno franoso.
Se non si fosse fermato con quella ottima sistemazione, oggi ci sarebbe una voragine che avrebbe ingoiato parte dei prati pascoli di Chamois con danni al villaggio di Nuarsaz e alla piana di Antey. All'epoca su questo intervento fu montata una sproporzionata e assurda opera di denigrazione che tra l'altro fece aprire un'inchiesta giudiziaria.
Il procedimento fu presto archiviato tanto risultò evidente la bontà e l'efficacia della scelta, ma la pesante e diffusa diffamazione costò molti e sofferti danni morali alle persone coinvolte che non erano tutte esponenti politici e un ritorno d'immagine negativo per la Regione.
Vorrei che ci ricordassimo di questi precedenti perché se vogliamo davvero mettere in maggiore sicurezza il territorio, dovremo eseguire interventi in quote e in ambiti più elevati di quanto avvenga attualmente. Si tratta di scelte che andranno difese contro opinioni contrarie, i cui sostenitori non si faranno scrupolo di usare l'arma dell'informazione contraffatta, soprattutto in sedi fuori dalla Regione.
Non possiamo pensare di intervenire in modo incidente in questo settore lasciando gli operatori delle strutture pubbliche in balia degli esposti, delle denunce e delle diffamazioni avanzate da chi non condivide queste scelte, in nome dell'abbandono e dell'inerzia quali rimedi alla fragilità della montagna.
Ai tecnici si deve imputare la responsabilità per l'esecuzione corretta e l'efficienza degli interventi, ma all'interno di una strategia complessiva di azione che privilegi la sicurezza nei termini voluti senza esitazioni da chi ha responsabilità politiche.
Si possono individuare delle mitigazioni ambientali, sia di tipo paesaggistico o biologico, ma ciò deve essere fatto senza porre dei condizionamenti che pregiudicano l'efficacia regimante e protettiva delle opere.
Il momento della scelta di un comportamento chiaro e determinato non è lontano poiché si deve eseguire un by-pass idraulico nel Comboé, la sistemazione del torrente di Epinel, delle Laures, del Saint-Barthélemy e di tanti altri ancora nei quali sono presenti situazioni critiche a quote elevate. Sono interventi che susciteranno ferree opposizioni e saranno combattute con tutte le armi possibili.
Questa calamità ha innescato processi di dissesto che vanno affrontati con la massima urgenza e senza ostacoli burocratici, fatta salva la corretta individuazione, progettazione ed esecuzione delle opere, improntate ad esprimere senza condizionamenti esterni la massima funzionalità.
Non mi dilungo su aspetti che sono già stati richiamati dall'Assessore Vallet e che condivido pienamente.
Mentre si svolge questa Assemblea vi è ancora molta gente che si interroga sulle proprie prospettive abitative, occupazionali ed imprenditoriali, per loro l'emergenza non è finita.
La generosa e straordinaria corsa alla solidarietà ha prodotto ottimismo e aiutato a ristabilire condizioni di normalità, ma ci sono aspetti e situazioni che non possono essere gestite interamente ed esclusivamente dal singolo né dalla solidarietà, occorre la partecipazione solidale e attiva delle istituzioni.
Sono un po' preoccupato per il fatto che stiano sorgendo dei comitati, essi possono avere un grande significato positivo se sono di appoggio anche criticamente alle istituzioni, ma se si sostituiscono ad esse, ci si deve chiedere se non ci sono delle insufficienze, individuarle e rimuoverle.
Ai cittadini dobbiamo dare delle certezze e in qualsiasi situazione essi si trovino hanno il diritto di avere delle alternative e uscire da posizioni di stallo, a loro deve essere data la facoltà di scelta, a noi quella di ampliare la loro possibilità delle scelte; questo è anche il principio dello sviluppo.
Un problema che non può essere eluso e deve trovare una soluzione urgente è quello della ricollocazione in altre abitazioni di persone e di famiglie e della delocalizzazione delle aziende; in molti casi esso è preliminare alla ricostruzione.
Da questa decisione non si può escludere a priori le infrastrutture situate nelle zone colpite o che risulteranno essere sottoposte a soglie inaccettabili di rischio.
Non si può affrontare questo serio aspetto della post emergenza come se si trattasse di spostare animali o mucchi di terra. Qui sono in gioco certamente la sicurezza delle persone e delle loro attività, ma si deve tenere conto anche di emotività, di sentimenti, di percorsi umani che non possono essere liquidati solo con degli incentivi seppure rilevanti.
Non dobbiamo poi dimenticare che queste persone si sono affidate ad un consenso rilasciato dall'autorità, fatto che li pone in una posizione di tutto rispetto e che non ha nulla a che vedere con la situazione degli abusivi.
Anche su questa spinosa questione abbiamo assistito alla comparsa di un ministro Verde che è venuto a dirci che le delocalizzazioni in base al "decreto Sarno" erano una procedura molto semplice redarguendoci per non avere saputo utilizzare i fondi disponibili.
L'opinione pubblica deve sapere che il ministro ha fatto riferimento ad uno strumento legislativo che non si è mai perfezionato poiché era correlato con la "legge Bassanini" ancora in alto mare soprattutto per le regioni a statuto speciale.
Circa i 2.000 miliardi dichiarati disponibili questi non sono mai esistiti, ma erano delle ipotetiche entrate che le regioni avrebbero avuto in seguito alla regionalizzazione, ancora tutta da realizzare, di beni demaniali. Dell'inefficacia di questi strumenti se ne sono accorti lo Stato e le regioni per cui concordemente era stato deciso di azzerare il vincolo di destinazione di questi fondi con una norma della finanziaria e affrontare in altro modo questo problema.
È vero che c'è la legge n. 228/97 sulla delocalizzazione delle attività produttive e in base ad essa era stata fatta una verifica nella realtà valdostana con esito negativo per due motivi: il primo per le difficoltà dei comuni a trovare i terreni, il secondo per l'insipienza degli aiuti previsti solo in conto interessi per una parte della spesa. Altro che cose facili!
Ora se il ministro queste cose non le sapeva quando ha fatto quelle dichiarazioni che hanno creato risentimenti verso la Regione e suscitato delle vane aspettative, ha dato prova di non essere aggiornato, cosa grave per un ministro; se le ha dette sapendo come stavano le cose ha commesso una grave provocazione ed ha mancato di rispetto verso chi è in serie difficoltà e attende delle risposte serie, non delle pagliacciate.
Lo ripeto ci si auspica che il processo di normalizzazione avvenga all'insegna della semplificazione e dell'autocertificazione. L'elenco delle priorità è tale che è difficile riuscire a capire su quale obiettivo concentrare prima l'azione. Certo è che interventi fatti precedentemente hanno già messo in evidenza alcune questioni che ritengo importanti e quindi non le richiamerò.
La Valle d'Aosta è passata per una drammatica prova dalla quale sta uscendo a testa alta nonostante le denigrazioni e le accuse. Questo è un dato di fatto che supporta l'urgente e importante azione intesa a confermare alla Valle l'immagine di terra fiera, efficiente ed ospitale.
La collettività valdostana con dignità e compostezza ha trovato dei punti di forza nella solidarietà, nella voglia di ricostruire e nella fiducia per l'avvenire. Si è fermata solo un attimo per dire arrivederci a coloro che la calamità ha voluto per sé; in realtà le vittime sono sempre state presenti assieme a coloro che nel dolore hanno continuato a palare, pulire, riordinare e adesso si accinge a ricostruire, produrre, commercializzare e svolgere servizi pubblici e privati.
Questa Comunità deve prendere atto che l'apparato di protezione civile ha affrontato una prova molto pesante e che andranno messi in registro tutti i passaggi risultati insufficienti, quelli da completare sia a livello centrale che locale, le enormi risorse umane da valorizzare meglio, attrezzare e addestrare con il supporto di un quadro normativo aggiornato.
C'è la consapevolezza delle attese, il quadro è chiaro, il Consiglio e il Governo regionale, i Parlamentari si stanno attivando non solo per dare rapidamente le risposte attese, ma di darle nel modo più favorevole possibile.
A parte qualche sbavatura il mondo politico si muove in modo compatto cercando di concentrare gli sforzi per trovare le migliori soluzioni ai problemi.
Questa catastrofe ha messo in evidenza l'urgenza di concludere e attualizzare la pianificazione territoriale come disciplinata dalle norme in vigore. Da questa esperienza drammatica deve prendere il via una più attenta incisiva e meno condizionata attività di difesa idrogeologica, dove ci deve essere anche lo spazio per il non fare.
Abbiamo consapevolezza che una comunità così duramente toccata e così reattiva deve poter fare affidamento su di una classe politica diligente, responsabile e attenta perché questo contribuisce a far guardare in avanti con fiducia e ottimismo.
Chi, parlo per coloro che sono impegnati in politica, ha passato le ore più angoscianti dell'alluvione sugli argini dei torrenti o della Dora, in mezzo all'acqua scura e invadente o si è attivato per fare girare le macchine del soccorso ha condiviso profondamente il dolore per la perdite di vite umane, è andato ad aiutare chi è stato danneggiato a togliere il fango dalle case, dalle cose, dai ricordi e dal futuro sa quanto la gente ha bisogno di sentire la politica vicina ad essa. Non possiamo disattendere le loro attese.
Voglio fare solo un'annotazione: è pervenuta la risoluzione firmata dai Consiglieri Curtaz, Squarzino e Beneforti; contrariamente a quello che aveva annunciato il Consigliere Curtaz, vedo che non compare più nella risoluzione la proposta di destinare il 30 percento dell'indennità di carica ai consiglieri regionali per l'alluvione.
Non so se compiacermene oppure no, ne prendo atto, ma voglio cogliere questa occasione perché ho ritenuto la proposta del Consigliere Curtaz per certi versi offensiva, sicuramente mortificante per i consiglieri regionali come me che hanno lasciato un lavoro decorosamente retribuito per mettersi in questo modo al servizio della collettività. L'indennità che la collettività mi dà mi serve per vivere decorosamente e per fare onestamente e all'altezza il mio lavoro.
A differenza del Consigliere Curtaz, che guadagna 200 milioni l'anno fuori di qui, e della Consigliera Squarzino che si porta a casa 50 milioni l'anno oltre a quello che prende qui per me il 30 percento è eccessivo e, quand'anche condividessi l'opportunità di destinare una parte di questa indennità o di altra entrata, per ragioni umanitarie lo farei con molta discrezione e con molta più umiltà e molto meno protagonismo.
PrésidentLa séance est levée, nos travaux reprendront dans l'après-midi à 16,00 heures.