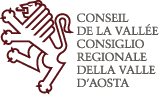Oggetto del Consiglio n. 3128 del 14 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1998
OGGETTO N. 3128/X Discussione generale del disegno di legge: "Iniziative a favore della famiglia".
Président La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV) La famiglia è da sempre l'istituzione primaria e basilare della società risultando sempre più importante ed indispensabile per l'espletamento di innumerevoli funzioni sociali. La qualità della vita e la vita stessa dipendono in misura considerevole dal ruolo che la famiglia ha e che si auspica possa continuare a ricoprire nella promozione di una cultura di partecipazione e di responsabilità civica nella cura delle nuove generazioni che dovranno essere in grado di affrontare e superare le problematiche che si profilano all'orizzonte.
Rispetto al passato la famiglia risulta oggi essere una realtà molto articolata e variegata. Il modello tradizionale, composto da due coniugi con due figli, è ormai superato e sostituito da famiglie composte da coniugi con un solo figlio, monoparentali, con unioni di fatto ricostituite.
La trasformazione socio-demografica in atto, dovuta anche alla diminuzione delle nascite e all'innalzamento dell'età media, agevola l'insorgenza di nuclei composti da anziani soli o in coppia.
Anche i nuovi stili di vita, dettati dall'esigenza di ricercare e mantenere un certo tenore di vita, contribuiscono alla formazione di nuclei familiari sempre meno consistenti, più fragili e con minore capacità di risposta rispetto alle situazioni critiche.
Per dare una prima risposta alle istanze delle famiglie con questo disegno di legge, oltre a riconoscere il ruolo e i diritti che la stessa deve avere, considerandola come società naturale fondata sul matrimonio, riconosciamo inoltre come formazione sociale primaria e con fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata. È formata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.
La Regione intende orientare i propri strumenti di programmazione e di legislazione al fine di: promuovere e realizzare sempre più una politica sociale diretta a porre la famiglia al centro degli interventi, considerandola soggetto attivo e responsabile; facilitare la formazione di nuove famiglie anche con incentivi economici; riconoscere concretamente il lavoro domestico con l'istituzione dell'Albo delle persone casalinghe dando loro la possibilità di accedere al fondo pensione e poter usufruire di un'indennità giornaliera per degenze ospedaliere e per infortuni domestici; sostenere ed incentivare le nuove nascite con interventi economici per far fronte alle maggiori spese che incidono in modo consistente sul bilancio familiare a seguito della nascita dei figli; elargire contributi economici a parziale risarcimento del mancato guadagno alle persone che sospendono o limitano la normale attività lavorativa per dedicarsi alla cura di familiari portatori di gravi handicap o anziani non autosufficienti; prevedere per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e per portatori di gravi handicap buoni spendibili per il miglioramento della qualità della vita; potenziare e coordinare i servizi presenti sul territorio e favorirne la fruibilità per quanto riguarda la gravidanza, la nascita e il puerperio; sostenere il diritto della coppia alla scelta positiva, libera e responsabile della procreazione aiutandola a superare i motivi che possono indurla a restrizioni non desiderate della fecondità; sostenere l'associazionismo familiare che possa dare impulso all'autorganizzazione sociale; sostenere la corresponsabilità di entrambi i genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli.
Con l'articolo 1, oltre ad enunciare i principi della legge, si riconosce come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse la famiglia comunque composta, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, solidarietà e mutuo aiuto, di educazione dei minori e di responsabilità nella cura delle persone che la compongono, attribuendo anche alla famiglia di fatto gli stessi riconoscimenti di cui gode quella formata sul matrimonio.
L'articolo 2 fissa le finalità che sono principalmente tese a perseguire una politica di sostegno alla famiglia agevolando la formazione di quelle nuove, valorizzando la funzione dei genitori nella cura e nell'educazione dei figli.
L'articolo 3 fissa gli obiettivi della legge, l'articolo 4 tratta gli interventi a sostegno della procreazione e della sessualità, sostenendo il diritto della coppia ad una procreazione libera e responsabile, prevedendo la realizzazione dei programmi di informazione e di educazione oltre all'assistenza psicologica, sociale e sanitaria.
L'articolo 5 prevede la consulenza genetica preconcezionale di informazione sui servizi e sulle norme di igiene in gravidanza, l'istituzione di corsi di preparazione alla nascita, la tutela e l'assistenza durante la gravidanza e l'assistenza al parto domiciliare.
Con l'articolo 6 si promuovono e si sostengono iniziative messe in atto da enti locali e privati per servizi socio-educativi per la prima infanzia con il potenziamento della rete degli asili nido, anche con forma di partenariato, e con l'istituzione delle "garderies d'enfance" per dare alla famiglia una forma alternativa di sostegno, di socializzazione e di aggregazione. Si prevede inoltre l'istituzione della tata familiare per i soggetti che per vari motivi non possono usufruire di servizi alternativi.
L'articolo 7 prevede interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza con il potenziamento di assistenza domiciliare educativa, con la promozione e l'istituzione di centri di incontro con finalità socializzanti culturali e pedagogici, con l'eventuale collaborazione dei genitori e del personale qualificato.
L'articolo 8 prevede degli importanti interventi che potranno facilitare la formazione di nuove famiglie, prevedendo aiuti alle persone sole con figli a carico.
È prevista l'erogazione di prestiti d'onore fino a 30 milioni a tasso agevolato per le spese connesse alla prima abitazione, l'abbattimento degli oneri di costruzione per alloggi destinati a famiglie di nuova formazione, oltre alla possibilità per i comuni che possono attuare forme di incentivazione alla locazione prevedendo agevolazioni per i privati che concorrano con il comune stesso alle modalità. Quest'articolo definisce in modo puntuale cosa si intende per famiglie di nuova formazione che possono accedere alle facilitazioni previste dall'articolo stesso.
L'articolo 9 istituisce l'Albo regionale delle persone casalinghe riconoscendo e tutelando il lavoro familiare come attività costruttiva per il benessere delle famiglie e della società. Per l'iscrizione all'Albo si prevede che il richiedente abbia la residenza in Valle da almeno tre anni ovvero che sia coniugato o convivente da almeno un anno con una persona residente in Valle da almeno tre, che abbia 18 anni e che sia privo di copertura assicurativa per attività lavorativa e che svolga l'attività di lavoro familiare.
Gli articoli 10, 11, 12 e 13 disciplinano le modalità per l'iscrizione all'Albo e prevedono l'indennità per infortuni domestici e per degenza ospedaliera oltre alla possibilità di accedere ai fondi pensione previsti dalla recente legge regionale del 26 giugno 1997 n. 21.
L'indennità per infortuni domestici è prevista in lire 35.000 giornaliere, mentre per l'indennità di degenza ospedaliera ci si rifà alla legge regionale del 21 aprile 1981 n. 20, già prevista per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per i commercianti.
L'articolo 14, a sostegno delle maggiori spese che la nascita di un figlio determina, prevede un assegno post-natale di durata triennale, variabile a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e rapportato al reddito. L'importo dell'assegno è determinato in lire 1,5 milioni annuo per il primo figlio, 2 milioni per il secondo, 2,5 milioni per il terzo e un ulteriore aumento di 500.000 lire oltre il terzo figlio.
A favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, verranno elargiti dei contributi per il periodo della gravidanza e per i primi tre mesi di vita del bambino.
Gli articoli 14bis, ter e quater prevedono e disciplinano la corresponsione di un assegno integrativo a sostegno delle famiglie numerose. Tenuto conto dei redditi complessivi dei nuclei familiari per il terzo e per ogni ulteriore figlio a carico viene corrisposto fino al 18° anno di età un assegno mensile di lire 50mila, elevabile a 70mila per nuclei nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente e questo a partire dal secondo figlio.
L'articolo 15 prevede indennizzi a favore di famiglie che includono soggetti in difficoltà e per la cura dei quali un familiare debba rinunciare temporaneamente allo svolgimento della propria attività lavorativa con conseguente perdita di reddito.
L'articolo 16 prevede la possibilità di accedere al fondo regionale di cui alla legge regionale n. 22/97 per prestazioni di assistenza a soggetti non autosufficienti.
L'articolo 17 istituisce un "voucher" annuale del valore massimo di lire 1.000.000 a favore di portatori di gravi handicap o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, spendibili per servizi pubblici o privati che siano finalizzati al miglioramento della qualità della vita.
L'articolo 17bis ha lo scopo di suscitare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie, prevede dei contributi finanziari fino all'80 percento delle spese ammissibili per progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica a scopo assistenziale ed educativo.
Con l'articolo 18 si promuove l'aggiornamento, promuovendo ed incentivando progetti sperimentali di aggiornamento, in particolare per quanto riguarda il servizio di tata familiare. Si prevede che a tali iniziative possano partecipare anche le associazioni del privato sociale.
L'articolo 19 ha lo scopo di verificare periodicamente l'efficacia delle azioni intraprese, attribuisce all'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali i compiti di osservatorio permanente che, avvalendosi anche di esperti, svolge funzioni di orientamento, monitoraggio ed analisi.
L'articolo 20 stabilisce che almeno ogni due anni, allo scopo di approfondire e valutare le situazioni, esaminare le politiche attuate ed avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie, la Giunta regionale debba convocare la Conferenza regionale sulla famiglia.
Alla Conferenza partecipano gli enti locali, l'USL, i consultori privati, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie e ogni altro soggetto che operi nel campo inerente alla politica familiare.
Gli articoli 21 e 22, infine, sono di carattere finanziario e di bilancio.
Per questo disegno di legge le commissioni consiliari competenti hanno dato il massimo contributo effettuando tutta una lunga serie di audizioni, cercando di fare propri i suggerimenti che hanno contribuito al miglioramento di una legge che interessa l'istituzione più importante e basilare della società, la famiglia.
Il testo che stiamo per approvare è l'ultimo di una serie che abbiamo di volta in volta rielaborato e cercato di migliorare. Credo che sia anche doveroso dare atto che anche alcuni consiglieri di minoranza per questo progetto di legge hanno dato impulso e collaborazione e vi assicuro che in questi cinque anni non è sempre successo.
Questa non è sicuramente una legge perfetta, ma è comunque una buona legge che riuscirà a dare alle varie tipologie di famiglie le prime, concrete risposte.
Essendo una legge che tiene conto delle esigenze di una pluralità di persone, è necessariamente una legge di mediazione per cui non può accontentare tutti. Personalmente ritengo molto importante una parte della legge che interviene a sostegno delle famiglie di nuova formazione con la previsione di aiuti quali: i prestiti d'onore, l'abbattimento degli oneri di costruzione per alloggi destinati a famiglie di nuova formazione ed agevolazioni sulle locazioni.
Come sappiamo, la legge prevede che ai contributi previsti all'articolo 8 possano accedere le coppie eterosessuali con l'esclusione quindi delle coppie formate da lesbiche ed omosessuali.
Personalmente, pur prendendo atto di una realtà che esiste, penso che non sia ancora giunto il momento di incentivare con aiuti vari la formazione di cosiddette famiglie di omosessuali e di lesbiche. Voterò a favore del mantenimento dell'aggettivo "eterosessuale" presente all'articolo 8 della legge e penso che per questioni etico-morali ognuno voterà secondo coscienza.
Si dà atto che, dalle ore 16.41, presiede il Vicepresidente Chenuil.
Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (Aut) Con questo mio breve intervento voglio solo esprimere alcune considerazioni di carattere sociologico, se mi si permette questa piccola presunzione. Al mio seguirà poi l'intervento più strutturato del collega Marguerettaz.
Il senso, anzi forse è meglio dire il ruolo della famiglia, checché se ne dica, da qualche tempo è cambiato: mentre una volta - questo credo valga sino agli anni '70 - i valori morali e sociali contenuti nel nucleo familiare medio e piccolo borghese erano uguali per tutti e corrispondevano agli obiettivi primari della società di allora, ovvero al mantenimento di tradizioni ed usanze ben precise e di alcuni "status" sociali comuni a tutte le classi medie e al perpetuarsi di tali tradizioni fra le famiglie, oggi le cose sono piuttosto cambiate. Sono cambiati i rapporti all'interno delle famiglie e gli obiettivi che la famiglia si pone soprattutto in ragione di una corsa al livellamento economico che ha abolito le classi sociali comunemente dette, ma soprattutto, proprio in virtù di tali presunte pari opportunità, ciò che è significativamente cambiato è il rapporto fra la famiglia e il mondo esterno ad essa, dove per mondo esterno intendo i contatti quotidiani che la famiglia ha con la realtà immediata che la circonda.
Spesso la famiglia moderna purtroppo, lungi da poter mettere a buon frutto le risorse tecnologiche, culturali ed intellettuali, patrimonio della nostra epoca, si trasforma, ma sarebbe meglio dire viene trasformata, in una sorta di mero contenitore nel quale i cambiamenti non avvengono in funzione di scelte operate sulla base di esperienze e sulla discussione, ma giungono imposte, volute da enti superiori ed esterni al nucleo familiare che utilizzano la televisione, la pubblicità, i giornali, la comunicazione di massa per far passare ed accettare i loro messaggi.
Questi enti sono facilmente individuabili, in quanto mentre una volta il potere sulla famiglia veniva esercitato privandola dei beni, oggi avviene l'esatto contrario: le catene dei supermercati hanno i magazzini stipati di ogni sorta di merce buona per tutte le tasche, i mass media elargiscono qualunque tipo di informazione, dalle più futili a quelle utili in tempi quasi reali.
La tecnologia elettronica offre evasioni e prospettive virtuali inimmaginabili solo pochi anni fa e tutto questo ci viene detto è fatto per il bene dell'individuo, della società e dunque, visto che la società è composta dal nucleo familiare, per il bene della famiglia.
Tutto cade dall'alto sulle teste di uomini, donne e bambini ai quali viene detto di non preoccuparsi perché c'è già qualcuno che pensa per loro, c'è già chi ha deciso e questo costituisce, secondo me, il nocciolo del problema.
Qualunque famiglia deve essere in grado di poter recuperare il suo ruolo di protagonista all'interno della società anche se si tratta di una società voluta e sostenuta da istituzioni che si dicono al di sopra delle parti. Spesso ci viene rappresentata l'unità della famiglia con immagini di un padre, di una madre e due o tre pargoli seduti di fronte alla televisione. Questa è un'immagine distorta e non rappresentativa di ciò che realmente significa unità familiare. Come cristiano e come democratico, ma anche (spero) come individuo attento al mondo che mi circonda e alle sue trasformazioni, sono convinto che la famiglia, essendo già un ente di per sé, debba poter dare un contributo fattivo e attivo moralmente e socialmente alla nostra Comunità e debba essere in grado di sostenere i suoi valori senza imposizione alcuna, semmai con un sostegno amorevole e sussidiario quando ve ne sia bisogno.
Se la famiglia è e deve essere il perno della nostra società, una legge che disponga le formule migliori di tale sostegno non può non tener conto dell'autonomia nel rispetto del contesto sociale che ogni famiglia degna di questo nome porta con sé.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Aloisi.
Aloisi (Aut) Intervengo su quest'importante quanto delicato disegno di legge che avrei preferito non fosse stato solamente il frutto di una parte politica in modo particolare della Giunta, anche in considerazione del fatto che un altro disegno di legge giace in Commissione.
E al di là di quello che sosteneva il relatore, ovvero che su quest'aspetto sono stati convocati in Commissione tutti i soggetti attivi della Società valdostana, credo che questo tipo di disegno di legge non soddisfi e avrebbe per certi aspetti meritato maggiore attenzione da parte di tutti.
Dicevo, è un argomento molto delicato quello che andiamo a trattare perché investe non solo la composizione della Società, ma investe per certi aspetti la coscienza di ognuno di noi. Siamo un'Assemblea legiferante e, quando ci muoviamo in questa direzione, dobbiamo tenere nella dovuta considerazione che le leggi devono essere non solo universali, ma soprattutto generali e quindi devono andare verso quello che è l'interesse della Comunità e della collettività.
Questa legge poteva essere confrontata con altri disegni di legge. Parte male perché contiene in sé un elemento pericolosissimo del quale nessuno di noi è riuscito a scrollarsi definitivamente e che è l'elemento del pregiudizio. Questo è un aspetto di sottocultura molto importante ed intorno a quest'elemento ha giocato da sempre la storia dell'uomo.
Il pregiudizio è quell'aspetto concettuale in virtù del quale molti credono di giudicare pensando di avere continuamente delle certezze, mentre su questi aspetti credo che il dubbio sia doveroso, ma il dubbio è maggiormente doveroso quando, rispetto a queste tematiche, si sente la necessità di capire, di conoscere, di comprendere e anche di valutare perché è la valutazione poi l'essenza principale intorno a cui ruotano lo sviluppo e la dinamica della società.
E capire e valutare significa anche tollerare, significa essere più attenti verso i deboli, verso il diverso, ma significa anche esaltare l'aspetto dell'amore, che non è l'amore come atto fisico, ma come quello che ognuno di noi può dare al suo simile o a quello che si trova in particolari momenti di debolezza. E questo, al contrario di chi sostiene il ragionamento di approfondire le conoscenze, può significare che il pregiudizio ancora insito in noi significa fanatismo a volte intransigenza, intolleranza e spesso anche emarginazione.
Di questo disegno di legge che, ripeto, investe la coscienza di ognuno di noi, condivido solo l'articolo 1, laddove ci si richiama non solo allo Statuto della nostra Regione, ma alla convenzione che regola i diritti dell'uomo. Quando parliamo di diritti dell'uomo, parliamo della possibilità di esprimere opinioni in libertà e ciò significa anche avere la consapevolezza di prestare rispetto a quello che gli altri sostengono e nel contempo anche difendere la propria posizione con la convinzione che poi se si è in errore, ci si può rivedere.
Appartengo ad uno schieramento libertario. Negli anni ?70 abbiamo fatto grandi battaglie di grande civiltà. Non ci dimentichiamo che, mentre negli USA, usciva un film, "Indovina chi viene a cena", che già prefigurava i matrimoni misti, fra due colori diversi, in Italia ancora non avevamo nemmeno iniziato la battaglia per il divorzio. Specialmente in Calabria, caro Borre, laddove la realtà era molto più dura e delicata, era più difficile fare quella battaglia perché c'era un pregiudizio culturale, c'era un certo maschilismo, cosa che per tua fortuna non hai vissuto qui in Valle d'Aosta, dove per certi aspetti il livello culturale era decisamente più elevato su quei problemi.
Solo chi è miope non può rilevare la differenza di clima in termini culturali in cui si viveva e come in passato si è vissuto anche con una certa esperienza il referendum sull'aborto. Sono state battaglie di grande idealità civile, di grande civiltà e su alcune sono rimasto fermo perché bisognava per certi aspetti sancire il cosiddetto concetto laico rispetto a quello che poteva essere la preminenza del pensiero cattolico.
E sull'aborto, a distanza di anni, anch'io ho rivisto la mia posizione, molto probabilmente non farei né mi comporterei così come mi sono comportato negli anni ?75.
Questa legge nasce, dicevo, all'insegna del pregiudizio e il pregiudizio non è altro che un'anticamera di razzismo. In modo particolare ho aperto gli occhi, qualora qualche volta li avessi chiusi, assistendo al dibattito sul Maurizio Costanzo Show quando Fini espresse quell'assurdo quanto insostenibile parere. All'inizio pensavo che parlasse per paradossi poi mi sono accorto che quello non era un paradosso che gratta gratta certe concezioni - checché ce ne volessero fare credere - erano ancora radicate, precise e presenti.
Partivo dal ragionamento che se il pregiudizio è l'anticamera del razzismo, allora capisco che l'accettazione del diverso è difficile e il diverso è anche colui che non appartiene alla specie e neanche al territorio, il diverso è colui che per certi aspetti non vive, non si comporta, non rientra nei canoni della comune morale. E noi, ringraziando Iddio, siamo in una Regione che il diverso lo ha accettato, dove la tolleranza è un fatto assodato ed acquisito quindi, sotto quest'aspetto siamo ad un livello civile decisamente elevato. Quando iniziamo con il ragionamento del razzismo partiamo da qualche categoria che poi significa per forza di cose coinvolgerne altre, significa tornare agli steccati, mentre il ragionamento ci deve spingere ad andare verso non solo una società multiculturale, non solo verso una società multirazziale, ma addirittura verso una società che per certi aspetti tenda ad anticipare quei fenomeni che si sono verificati in altre realtà.
Pregiudizio e razzismo, questi concetti contengono un terzo elemento che è quello dell'ipocrisia. L'ipocrisia di non voler sapere, l'ipocrisia di non voler capire, l'ipocrisia di non voler comprendere. E qui alcune confessioni religiose farebbero molto bene se si comportassero in modo completamente diverso, riuscendo a capire la dinamica che sta intervenendo all'interno della società. Non si possono accettare sempre i soliti ragionamenti delle pubbliche virtù e dei vizi privati, sono cose difficili da digerire, sono cose difficili da capire. Il valore umano e la libertà del valore umano devono tornare a quello che era un ragionamento della convenzione dei diritti dell'uomo, un valore irrinunciabile e un valore di rispetto e da rispettare sempre e comunque.
Questo mio ragionamento non fa altro che sottolineare la carenza di questo disegno di legge, il quale a monte e al di sopra di tutto doveva contenere un grosso, elevato e spesso livello culturale. Avevamo le condizioni per poterlo fare, non siamo stati in grado di farlo, forse perché concetti di primogenitura ancora imperversano in molti di noi, compreso me quindi, mi rammarico per questo ragionamento perché pregiudizio, razzismo ed ipocrisia non sono elementi definitivamente sconfitti.
Mi accingo a chiudere con una frase che ho letto in questi giorni su "L'Espresso", sulla rubrica di Enzo Biagi il quale, riferendosi ad un attore americano che faceva parti non proprio consone all'aspetto maschile, riportava una metafora di quest'attore: "Meglio nascere negri che gay perché se sei negro, non lo devi dire a tua madre".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Questa legge, a differenza delle altre delle quali ci siamo lamentati per la gestazione abbastanza corta, ha avuto una gestazione lunga, faticosa, travagliata.
Vi dico la verità, farò poi la proposta di mandarla al prossimo Consiglio perché la montagna questa volta ha di nuovo partorito il topolino.
A partire dalla costituzione della Repubblica italiana, che riconosce alle persone la titolarità dei diritti sociali, di cittadinanza, fondamento di qualsiasi Stato moderno e considerata la famiglia quale luogo di affetti e di responsabilità liberamente assunte, riteniamo una normativa indirizzata esclusivamente alla famiglia una grave forma di intromissione nelle scelte di vita di ciascun individuo oltre che una forma di discriminazione nei confronti dei singoli.
La famiglia non deve e non può sostituirsi ai compiti sociali propri delle istituzioni pubbliche; in famiglia il lavoro di cura deve essere distribuito e scambiato fra i soggetti validi; il benessere della famiglia e dei suoi componenti è garantito innanzitutto dall'esercizio del diritto al lavoro da parte di tutti i componenti, uomini, donne, giovani, del diritto ad una pensione adeguata nell'età anziana e del diritto ad una casa.
Ciò premesso, non si nega la possibilità che si possa intervenire con norme per la promozione e il sostegno della persona e della famiglia che prevedano in particolare: misure di sostegno alla maternità, congedi parentali, l'approntamento di una rete adeguata di servizi sul territorio per l'infanzia, gli anziani e le persone non autosufficienti, ripensamento complessivo degli orari e dei tempi della scuola, del lavoro, dei pubblici servizi e in generale della città attraverso promozione di piani comunali e degli orari.
Entrando nel merito della proposta presentata, ci preme sottolineare quanto segue: se nelle premesse pare che vengano riconosciute forme di famiglia diverse, nella relazione si fa esplicito riferimento alle coppie omosessuali, nella realtà queste ultime non vengono tutelate e vengono anzi discriminate, manca il benché minimo riferimento all'attività dei consultori familiari. All'articolo 4 si fa riferimento genericamente ai servizi esistenti, resi dalla Pubblica Amministrazione e dal privato sociale. Indispensabile invece è promuovere nell'ambito degli interventi su sessualità, procreazione, responsabilità e nascita, un rilancio ed una riqualificazione del consultorio familiare prevedendo anche programmi specifici rivolti agli adolescenti e ai giovani compresi i progetti di ricerca e sperimentazione in ambito educativo.
Non sono definiti nell'articolato criteri e modalità di verifica delle attività previste, siano esse gestite dalla Pubblica Amministrazione sia da un privato sociale genericamente richiamato. Sarebbe perlomeno il caso di definire i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché le adeguate capacità tecniche organizzative ed operative di gruppi, movimenti ed associazioni senza scopo di lucro chiamate in causa oltre che gli "standards" qualitativi ed organizzativi definiti e controllati periodicamente dalla Regione. È il caso dell'istituzione delle tate familiari attraverso generiche forme di collaborazione con soggetti altrettanto generici del privato sociale.
Allo stesso modo una verifica ed un controllo nella tutela dei diritti dei lavoratori impegnati nel privato sociale, sarebbe cosa alquanto auspicabile in quanto direttamente inserita nell'articolato.
Non sono previsti particolari e specifici interventi per situazioni a grave difficoltà sociale, problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale, se non attraverso un'ulteriore monetizzazione della presa in carico delle persone in difficoltà all'interno della famiglia.
Non si fa cenno a programmi particolari di edilizia residenziale pubblica, non si fa ugualmente cenno a possibili interventi che favoriscano il ricongiungimento familiare degli immigrati extracomunitari.
Il nodo cruciale del lavoro di cura, lontano dall'essere definito come relazione di responsabilità e di obbligo sociale all'interno del nucleo familiare, tant'è che viene riconosciuto e tutelato soltanto se viene svolto da un unico soggetto all'interno della famiglia secondo un modello superato di visione del lavoro e di ruolo servile delle persone casalinghe, viene liquidato attraverso un riconoscimento economico di difficile applicazione: albo a partire dai 18 anni e fondo pensione per persone casalinghe.
Per contro sono assenti misure di sostegno alla riqualificazione professionale e all'entrata delle donne nel mercato del lavoro. La normativa in generale predilige interventi di monetizzazione dell'assistenza ai soggetti in difficoltà, a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini anziché intervenire direttamente per migliorare i servizi e renderli maggiormente usufruibili attraverso ad esempio, forme di assistenza domiciliare. Particolarmente grave in questo senso il "voucher" per i servizi genericamente definito a cui verrebbe delegato il compito di sopperire ai disservizi esistenti anziché intervenire per promuovere il miglioramento.
La famiglia, e all'interno di questa, la donna pare doversi fare carico da sola delle numerose incombenze che la Regione trova più comodo delegare. L'assegno post-natale in particolare ricorda il premio di produzione erogato dal fascismo in generale, la normativa non contiene elementi per un cambiamento socio-culturale nel campo delle pari opportunità che anzi in molti casi sembrano messe irrimediabilmente in discussione.
Leggendo questa mia relazione penso di aver detto su questa legge quello che noi pensiamo. Mi hanno fatto piacere le parole libertarie del Consigliere Aloisi, mi ci ritrovo in pieno in questi momenti in cui si cerca di approvare una legge che lascia fuori delle categorie di persone, non si capisce bene perché. Quando da parte di altre regioni e da parte dello Stato si cerca di andare a riconoscere tutti i soggetti componenti la nostra Comunità, in questa Regione si fa una legge con diverse pecche secondo noi e con la pecca più grossa di non riconoscere le coppie di fatto.
Al termine di questo mio intervento rinnovo a questa maggioranza la richiesta di rimandare questa legge al prossimo Consiglio ed a una più attenta e puntuale valutazione di un atto in favore della famiglia, atto che a mio avviso non si è riusciti a partorire bene. Se non sarà così, voterò contro questa legge.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Dopo aver sentito l'intervento del collega Aloisi e anche altri interventi, mi sembra che la discussione su questo disegno di legge si stia mettendo su un binario etico o morale. È logico che se i singoli consiglieri, liberamente, decidono di leggere questo disegno di legge secondo questo taglio, va da sé che ogni Consigliere seduto in quest'aula, come già per certi versi anticipato dal relatore Rini, dovrà valutare questa legge non tanto da un punto di vista dello schieramento politico a cui appartiene, ma da un punto di vista personale. Ripeto, se si dà questa chiave di lettura, una chiave di lettura etica e morale al disegno di legge, è comprensibile un atteggiamento così da parte di tutti e trentacinque i consiglieri.
Il mio tentativo vorrà essere, magari non subito, ma in un secondo intervento, quello di spostare il baricentro del ragionamento, di evitare ragionamenti di tipo etico o morale. Cercherò invece di addentrarmi su motivazioni più politiche, più amministrative che reggono questo disegno di legge, ma su questa strada, ripeto, mi incamminerò forse in un secondo intervento perché quello che mi premeva condividere con voi era un ragionamento più generale sul tema della famiglia prima di andare a confrontare la proposta che ci viene presentata oggi con un ragionamento su canoni generali che poi dovrebbero portare all'elaborazione di un progetto di legge.
Inizierei con il dire che il semplice fatto che una Regione come la nostra si interessi di politiche familiari tanto da arrivare a presentare due proposte di legge nel corso dell'ultimo anno, a partire dal marzo '97, quando il sottoscritto insieme ai colleghi Viérin e Collé depositò una proposta di legge, fino all'ottobre dello stesso anno, quando la Giunta a sua volta propose questo disegno di legge, anche se modificato rispetto al testo iniziale, dicevo questo fatto è di per sé un fatto estremamente positivo. In Italia, nelle altre regioni, ma soprattutto a livello nazionale, vi è una tale assenza di politiche familiari che il nostro Paese si colloca in una posizione decisamente arretrata rispetto ad altre realtà europee in cui la legislazione della famiglia appare assai più sviluppata rispetto alla nostra.
In un colloquio internazionale, che si è tenuto nel novembre ?92, quando ancora i Paesi del Mercato europeo erano 12, è stato presentato uno studio commissionato dal Ministero della famiglia e degli anziani della Repubblica Federale Tedesca ad un'associazione tedesca che conteneva un confronto fra le politiche familiari dei 12 Paesi membri del Mercato europeo.
La politica familiare italiana, comparata con gli altri paesi europei, è stata definita con due parole: non esplicita e rudimentale. Non esplicita, diretta cioè non alle famiglie, ma ai singoli e di fatto una politica assorbita dalle politiche sociali in generale; rudimentale perché concepita come assistenza alle famiglie con problemi, essa infatti, come tutti noi sappiamo, interveniva soprattutto sulle famiglie a bassissimo reddito, non compensava i carichi familiari - tutti conosciamo sia le politiche fiscali ancora in vigore in questo Paese, sia gli assegni familiari che hanno un'inefficacia pressoché totale - e non permetteva ai genitori con figli piccoli di conciliare la vita familiare con il lavoro professionale infine, non aiutava le famiglie monoreddito. Il punto più positivo della nostra politica familiare riguardava un'unica cosa e cioè il congedo per la maternità e l'intervento per membri di famiglie portatori di handicap.
Quindi, nel nostro Paese non si è mai tenuto in debito conto di quanto sancito dalla Costituzione della nostra Repubblica che all'articolo 2 recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Dall'articolo 29 all'articolo 31 poi sono riconosciuti i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
La famiglia viene dunque riconosciuta dalla Costituzione come primo nucleo sociale che la persona umana incontra fin dall'inizio della sua esistenza, ambito naturale di accoglienza della vita, di formazione, di crescita della personalità, luogo della realizzazione personale.
La famiglia dunque è descritta come un soggetto sociale, come un fondamento e quindi come prima risorsa della società, ma come spesso accade, a tanti bei principi non è seguita una legislazione conseguente. Spesso, infatti, si è barattata tutta una serie di interventi e di misure verso singoli individui come politica familiare; questo genere di politica, che è impostata sovente sul rapporto assistenziale: ente pubblico-singolo individuo e che quindi non ha investito sulle risorse proprie che ha ogni individuo quale appunto la famiglia, ha senz'altro contribuito in maniera importante alla crisi del cosiddetto "Welfare State".
In questi anni la famiglia è apparsa sempre più chiaramente come un soggetto che svolge importanti e decisive funzioni dalle rilevanti ricadute sociali come giustamente ricordava il collega Rini. In questo senso però, come mi è sembrato di cogliere anche da alcuni passaggi della relazione di Rini, dobbiamo cercare di sfrondarci dall'idea della famiglia come di un soggetto cronicamente fragile e debole.
Credo che tutti questi anni che abbiamo avuto la fortuna di vedere nel corso della nostra vita hanno dimostrato semmai l'esatto contrario: la famiglia è di per sé una struttura forte della nostra società che nel corso degli anni ha saputo adattarsi ai vari cambiamenti a cui faceva riferimento il collega Lanièce e per molti versi supplire alle molte carenze dei servizi pubblici, caro Consigliere Chiarello.
Non c'è dubbio, inoltre, che la famiglia conserva ancora in Valle d'Aosta anche fra le nuove generazioni un'elevata considerazione sociale e si costituisce ancora oggi per la maggior parte della popolazione come ambito essenziale di vita e realizzazione personale.
Nonostante tutto questo si avverte piuttosto chiaramente come le famiglie siano sottoposte a delle tensioni via via crescenti. Segno evidente e preoccupante di questa situazione è ad esempio lo stesso sensibile calo delle nascite che in Valle d'Aosta porterebbe non da un anno o da due, ma da addirittura venti anni ad un saldo demografico negativo. Se in Valle d'Aosta non avessimo avuto nel corso di questi venti anni un flusso migratorio che ha tenuto in una media più o meno costante la popolazione della nostra Regione, avremmo oggi assai meno abitanti rispetto a vent'anni fa.
Non c'è oggi un indicatore che faccia pensare ad un'inversione di tendenza in questo senso, vale a dire, finché il flusso migratorio dura, la popolazione della nostra Regione rimarrà più o meno costante. Qualora dovesse venire a mancare questo flusso migratorio, è giusto che questo Consiglio regionale si interroghi su qual è la prospettiva del "peuple" di questa Regione.
Queste tensioni a cui la famiglia è sottoposta sembrano derivare da un complesso di circostanze... quando dico "peuple", non parlo di ragionamenti etnici, collega Squarzino, sto pensando ad un insieme di persone che abitano una terra e che hanno una tradizione, una storia, una cultura e per i quali questo Consiglio regionale dovrebbe adoperarsi. Non sto facendo questioni etniche.
Dicevo che queste tensioni a cui la famiglia è sottoposta sembrano derivare da un complesso di circostanze, ne cito alcune: il crescente impegno lavorativo della coppia, le esigenze di cura che derivano dall'invecchiamento ormai evidente della popolazione, le attrazioni provenienti dalla sfera del consumo e l'intervento del collega Lanièce credo che volesse sottolineare in particolare quest'ultima componente. Queste problematiche tuttavia non si manifestano in identica misura per tutte le famiglie. Le condizioni delle famiglie sono da un punto di vista socio-economico diverse, ma perché sono diverse? Perché innanzitutto sono diverse le esigenze di cura che esse manifestano a parità di condizioni socio-economiche in rapporto al numero della prole e alla presenza di persone prive di autonomia. È un passaggio che ricorrerà spesso nei miei interventi: o ci rendiamo conto che lo star bene del soggetto famiglia non dipende unicamente da un benessere economico derivante da un reddito più o meno alto, ma dal carico dei bisogni a cui la famiglia deve far fronte, o non ragioneremmo in termini di politiche familiari.
Riteniamo innanzitutto che una politica della famiglia deve essere rivolta all'insieme delle famiglie e non solo a quelle che manifestano disagi particolarmente gravi. Nei confronti delle famiglie povere o in condizioni di disagio occorre avere un'attenzione particolare, ma una politica della famiglia non è essenzialmente limitata a questo. Ci si deve proporre piuttosto di ridurre quelle tensioni a cui facevo riferimento e a cui la famiglia è sottoposta.
La politica della famiglia, a nostro avviso, deve essere orientata a ridurre le differenze nelle condizioni di vita, in particolare nelle disponibilità di tempo che caratterizzano le famiglie in relazione al numero della prole e alla presenza di persone prive di autonomia.
È proprio nel peggioramento delle condizioni relative di vita nelle famiglie con prole numerosa rispetto a quelle senza prole o con un solo figlio che vanno individuate le origini delle attuali difficoltà riscontrate nelle scelte procreative, testimoniate dallo scarto esistente fra il numero di figli mediamente procreati e quello considerato ottimale. In questo senso è doveroso ricordare che la nostra Regione è inserita in un Paese che ha il più basso tasso di natalità al mondo, pari a circa 1,2 figli per donna - voi tutti sapete che il tasso di sopravvivenza di una popolazione è pari a 2,1 figlio per donna - e la Valle d'Aosta è la Regione che a sua volta ha il più basso tasso di natalità fra le regioni italiane o perlomeno uno dei più bassi. Così come non può non far pensare il fatto che sempre rispetto alle altre regioni la nostra è quella che ha il minor numero di componenti per nucleo familiare, siamo nella media di 2,4 persone per nucleo.
Una politica della famiglia si deve infine porre culturalmente all'interno di quelle ipotesi di "Welfare Society" che sono scaturite dalla crisi di quei tradizionali sistemi di "welfare" incentrati sul ruolo predominante assegnato all'offerta pubblica. Esse prevedono che la presa in cura dei soggetti si realizzi mediante l'apporto integrato del privato sociale così come dei soggetti pubblici, per questi motivi è importante tentare di incentivare le forme di autoaiuto e di associazionismo fra le famiglie, ma su queste osservazioni mi soffermerò adeguatamente più tardi.
Ciò che mi interessa dire in questo primo intervento è che interessarsi di politiche della famiglia significa interessarsi di un soggetto diverso dal singolo individuo, significa interessarsi non più del singolo cittadino, ma significa interessarsi di un corpo sociale a cui due persone inizialmente danno vita. Questo è fondamentale per ragionare in temi di politiche familiari.
Promulgare una legge per la famiglia nella nostra Regione significherebbe fare una vera e propria rivoluzione di tipo culturale da una parte e di tipo istituzionale dall'altra, significherebbe cioè cambiare l'interlocutore dell'Amministrazione: non più il singolo individuo, ma i cosiddetti corpi intermedi della società, primi fra i quali la famiglia e le associazioni fra le famiglie, sarebbe quasi una rivoluzione Copernicana.
Ma per quali motivi un'istituzione pubblica come la nostra dovrebbe interessarsi alla famiglia? Quando un soggetto pubblico, sia esso lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune guarda alla famiglia, può farlo in due modi. La prima possibilità è quella di assistere questo soggetto, di farne oggetto di assistenza sociale e questa posizione parte da una visione di una piccola società strutturalmente fragile, incapace di costruire, anzi bisognosa di intervento. Apro una piccola parentesi: non è un caso che, nelle molte audizioni che abbiamo svolto su questa proposta e su quella presentata dal sottoscritto, da più parti - mi sembra anche dalla stessa componente sindacale - sia emersa una critica propositiva nei confronti di entrambe le leggi: piuttosto che promulgare una legge sulla famiglia, secondo costoro, sarebbe stato assai più interessante ed efficace riorganizzare tutte le leggi che regolano il settore dell'assistenza all'interno della nostra Regione. Va da sé che una proposta di questo genere si situa nella prima prospettiva che dicevo: abbiamo già tante leggi che assistono i soggetti deboli perché farne una in più che assiste un soggetto debole quale la famiglia? Riorganizziamo il tutto e faremo un miglior servizio anche alla famiglia.
La seconda possibilità con cui guardare la famiglia è esattamente l'inverso ed è quella a cui accennavo prima.
La famiglia è un soggetto forte, è un soggetto che se domani mattina questo Consiglio regionale non ha promulgato una legge non è che si sfascia, andrà avanti e risponderà come sempre ha risposto ai suoi bisogni e darà quelle risposte a livello sociale che fin qui ha sempre dato anche senza una legge regionale o nazionale. Da questa prospettiva la famiglia viene vista come un soggetto forte capace di rispondere ai propri e agli altrui bisogni. Allora, perché interessarsene? Perché, come diceva giustamente Rini, la famiglia svolge delle funzioni sociali che vanno al di là delle sue quattro mura domestiche, è per questo che un'istituzione qual è la Regione deve porre attenzione al soggetto famiglia perché l'opera della famiglia ha un risvolto sociale. L'Amministrazione regionale, al contrario, non ha nessun diritto di intromettersi in quella che è la sfera degli affetti familiari che è un'altra componente importante della famiglia, anzi direi che è la molla iniziale che dà vita alla famiglia, ma sulla quale la parte pubblica deve ben guardarsi dall'esprimere un giudizio essendo quello che importa alla parte pubblica esclusivamente un ritorno di tipo sociale.
Per dare al problema una distinzione di valore fondamentale, bisogna distinguere queste due possibilità. La politica sociale della famiglia esisteva già nel passato anche in Italia e si riduceva ad assistenza o a soccorso per la famiglia povera e ad interventi in favore dei singoli membri.
Corrispondeva ad una dottrina giuridica e ad una prassi sociale di stampo individualistico che emancipano solo dei singoli: il bambino, la donna, l'anziano, il malato, il portatore di handicap negando la famiglia sia come oggetto e sia come soggetto. Ad essa, sola o associata, non è permesso di assumere il ruolo di interlocutore, quindi di soggetto attivo e corresponsabile.
Desidero far vedere la differenza che c'è fra le due politiche, quella sociale fa aumentare i costi economici all'infinito, rende passivi gli utenti e soprattutto accentua, forse senza volerlo, la frammentazione interna al nucleo familiare e perciò l'indebolimento continuo della famiglia come entità connettiva, affettiva ed educativa. Se la politica familiare è ciò che deve essere e quindi non assistenziale, si mette al servizio di ogni famiglia solo perché è famiglia e non si propone la perequazione economica tra le diverse categorie sociali, le preme la crescita e la tenuta della famiglia come tale. Infine sa la parte pubblica che il denaro speso per le famiglie ritorna all'Amministrazione come un risparmio nell'uso dei servizi e come frutto di attività di solidarietà interne ed esterne alla famiglia come cercavo di dire poc'anzi. Così la famiglia è una risorsa solida e dignitosa su cui la parte pubblica può contare addirittura anche per risparmiare. I problemi di assistenza, di cura, di educazione dei singoli componenti ed in risposta ai singoli bisogni educativi, sanitari, economici fanno riferimento a diritti individuali ed è importante che tali diritti siano affermati, ma si può parlare di vera e propria politica familiare solo se tali diritti individuali vengono affrontati nel quadro del ciclo di vita familiare o dei rapporti intergenerazionali e cioè avendo come obiettivo il rinforzo delle relazioni all'interno della famiglia e la promozione e il sostegno delle funzioni di educazione e di cura che sono proprie della famiglia.
L'obiettivo di sostegno alla famiglia, nell'adempimento delle sue responsabilità, chiama in causa direttamente i servizi. A questo proposito, ho sentito il Consigliere Chiarello dire che la famiglia non può permettersi di interferire nei servizi pubblici: questo è il modo di vedere la cosa esattamente opposto a ciò che è per me, io sostengo l'esatto contrario: sono i servizi pubblici che non possono interferire nelle capacità proprie della famiglia di rispondere alle sue esigenze. Una delle argomentazioni che è uscita e che è formidabilmente interessante è la libertà della famiglia. Oggi se c'è una libertà che manca alla famiglia è quella di costruire, è quella di fare, è quella di autorispondersi a delle necessità alle quali potrebbe rispondere magari insieme ad altre famiglie perché o le si fornisce un certo tipo di servizio dalla parte pubblica oppure la famiglia stenta a darsi delle risposte.
Credo che ci sia nella nostra Regione, nonostante l'ultima cosa che ho detto, una forte potenzialità. Dicevo che fare una politica per la famiglia significa fare una rivoluzione innanzitutto di tipo culturale, perché quella della famiglia, intesa come capacità di crescita civile, è una cultura latente che ha bisogno di crescere, in particolare nella nostra Regione. Non è un caso che l'associazionismo fra le famiglie nella nostra Regione non è così sviluppato come in altre realtà, è però vero un fatto che ho potuto notare interessandomi un po' di queste cose a livello locale: che l'associazionismo fra famiglie nella nostra realtà nasce laddove c'è un problema grave che accomuna le famiglie e faccio due esempi per tutti. L'Associazione delle famiglie dei portatori di handicap, e le tante associazioni di famiglie che sono state colpite in uno dei loro componenti dal problema della tossicodipendenza ma, ripeto, la capacità di associarsi nelle famiglie valdostane è spesso dovuta ad un problema molto evidente e molto grande e che lascerebbe nella disperazione la famiglia che rimane isolata.
Vi sono altre potenzialità che oggi stentano ad emergere, ma che mi pare di vedere latenti. A questo proposito vorrei, a conclusione di questo primo intervento, leggervi una cosa che, personalmente, mi ha molto colpito e mi ha fatto dire le cose che dicevo adesso cioè di come, a livello della nostra Regione, vi sia una potenzialità che non aspetta altro che di crescere e compito nostro dovrebbe essere proprio quello di mettere in cantiere uno strumento legislativo che sostenga la crescita di queste famiglie.
Nel leggervi questo brano vorrei fare un'ultima osservazione. È una lettera apparsa sul giornale "La petite Société alpine de Cogne" che credo... no, non è politico, possiamo anche leggerci dei risvolti politici, ma non sono quelli che oggi mi interessano, sì, quello dell'opposizione, ma che penso riceviamo tutti... c'è una firma di una mamma di Cogne, che non leggerò, che scrive questa lettera aperta e che mi ha colpito perché ha un taglio diverso dalla posizione con cui purtroppo molte famiglie si pongono nei confronti di un problema o di un mancato servizio erogato dall'istituzione pubblica:
"Diventata mamma nell'anno 1993 ho potuto constatare personalmente le difficoltà per le madri che vivono a Cogne di conciliare la maternità con un eventuale lavoro. Il nostro Comune, infatti, dato il numero non sufficiente di nascite, non ha previsto un asilo nido che ospiti bimbi dai primi mesi di vita fino all'inizio della scuola materna. La distanza rispetto ad altri comuni impedisce di appoggiarsi ad altre strutture per l'infanzia, facendo sì che ogni mamma, che non può contare sulla disponibilità di un familiare, debba rimanere a casa senza possibilità di scelta. Ciò grava inoltre sul bilancio domestico: nella nostra società infatti un solo stipendio è appena sufficiente. Un altro problema è che il nostro Comune si basa prevalentemente su un'attività turistica e quindi la maggiore offerta di lavoro è nelle giornate di sabato e domenica, nelle festività. La scuola materna proprio in questi giorni rimane chiusa.
Riflettendo sull'argomento ho ipotizzato che l'eventuale nascita di un locale adibito alla cura dei bambini, come una ludoteca o una "garderie", già esistente in altri comuni della Valle, potrebbe essere di aiuto a molte famiglie, questa struttura potrebbe essere studiata anche per coinvolgere i bambini di molti turisti creando in questo modo per Cogne un nuovo servizio".
Ora, molti fra noi potrebbero pensare che questa lettera si concluda più o meno così: "Pertanto invito l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione regionale a provvedere in tal senso". Questa invece no! State a sentire: "Avrei piacere di discutere l'argomento con chi volesse approfondirlo insieme a me, con chi fosse interessato a lavorare in questa struttura e con chi volesse aderirvi. Se ci fossero i presupposti sufficienti, quest'idea non rimarrebbe più un sogno per molte mamme. Mi potete chiamare al numero..." e lascia il numero di telefono.
Una lettera di questo genere mi ha fatto molto riflettere e dovrebbe guidare tutto il nostro ragionamento sulla proposta di legge che oggi siamo chiamati a discutere.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Dopo la famiglia etica e dopo la filosofia della famiglia che ci ha illustrato il Consigliere Marguerettaz, cercherò più modestamente di descrivere una famiglia laica in uno Stato che vuole essere laico e liberale. Partirei da alcuni dati concreti che sono già stati ricordati in altri interventi, ma che vale la pena di ricordare.
Nel nostro Paese il tasso di attività fra uomini e donne è quasi dimezzato rispetto a quello che c'è in altri paesi europei, i Paesi scandinavi, ma anche altri paesi più vicini ai nostri confini. Abbiamo una famiglia e uno stato sociale fondato su un maschio capofamiglia che lavora con una grossa difficoltà ed un'incompatibilità fra lavoro familiare e lavoro remunerato soprattutto per quanto riguarda le donne. Non è un caso che il nostro sia uno dei paesi europei a minor tasso di natalità. Questo perché sulla famiglia gravano tutta una serie di servizi e di carichi che vanno dall'infanzia all'assistenza degli anziani che in altre realtà all'esterno del nostro Paese invece sono assolte in modo diverso da strutture sociali gestite e governate anche dallo Stato.
È vero anche che non ci troviamo di fronte ad un'unica famiglia ontologicamente data, un po' quella che è stata descritta nell'intervento che mi ha preceduto. Se andiamo a vedere le stesse classificazioni dell'ISTAT, troviamo almeno quattro classificazioni diverse di famiglie. Credo anche che il disegno di legge che è in discussione nell'articolo 1, commi 1 e 2, descriva bene questa molteplicità di famiglie che esiste nella nostra società anche perché una legge sulla famiglia deve comunque tener conto delle dinamiche sociali presenti in una Regione come la Valle d'Aosta.
Abbiamo anche una situazione in cui ci troviamo con un aumento della famiglia che è decisamente superiore all'aumento della popolazione, quindi c'è una forma di autonomizzazione da questo punto di vista e in presenza di tassi di nuzialità stabili. C'è nella legge - e questa è una delle disposizioni che più farà discutere - il riconoscimento delle coppie di fatto; a livello nazionale le coppie di fatto secondo i dati ufficiali sono l'1,5 percento delle coppie totali, in Valle d'Aosta dove questo dato è un po' superiore e possiamo anche pensare che sia sottostimato, siamo al 2 percento. Tenete conto che in altri paesi europei, come ad esempio in Svezia e Danimarca, le coppie di fatto sono intorno al 20 percento, quindi prendere atto di una realtà è sicuramente doveroso, ma teniamo conto che il fenomeno ha dimensioni estremamente limitate.
Nell'intervento che mi ha preceduto è venuto fuori come sulla problematica della famiglia esistano due concezioni. Da una parte la famiglia viene vista un po' come ontologicamente data cioè un corpo intermedio della società, un corpo - non è stato detto, ma è nelle cose - che deve essere unico ed indissolubile perché dalla divisione della famiglia deriverebbe un indebolimento della famiglia stessa e quindi non si potrebbe più parlare di una famiglia forte e autosufficiente e in quest'ottica si vede l'intervento esterno, in questo caso della Regione, più un intervento rivolto agli individui e più una forma di intrusione verso questo corpo intermedio della società che gode di una propria autonomia ed autosufficienza.
Dall'altra parte c'è una concezione diversa che ritiene che un intervento dello Stato o della Regione non debba essere visto come un'intrusione, ma piuttosto come una risorsa per dare la possibilità alla famiglia di sviluppare una propria azione rispetto ad una situazione esterna sia di carattere sociale, sia di carattere economico, sia legata alle stesse dinamiche familiari che consentano a tutti gli individui all'interno della famiglia una parità di diritti e quindi una garanzia dei diritti individuali di ciascuno. Per cui le azioni positive, che sono contenute in questa legge, vengono viste come un elemento per garantire un'uguaglianza ai membri della famiglia e maggiori opportunità per tutti i membri della famiglia.
D'altronde non dobbiamo dimenticarci che non sempre gli interessi e i diritti della famiglia coincidono con gli interessi e i diritti del singolo individuo. C'è tutta una legislazione che si è sviluppata nel tempo per quanto riguarda la protezione legale dei bambini, la questione che concerne il lavoro minorile, la tutela delle donne, per cui la famiglia è un'entità importante e nessuno vuole mettere in discussione questo, ma se la famiglia viene lasciata sola a gestire sé stessa non sempre produce gli effetti positivi che venivano indicati prima. Con questo non dico che debba necessariamente produrre effetti negativi, ma pur essendo d'accordo che ci debba essere un sostegno alla famiglia, questo non può prescindere dai diritti e dai doveri degli individui.
L'Italia, forse anche per particolari condizioni storiche, ha visto la presenza di due ideologie diverse della famiglia, da una parte l'ideologia cattolica, dall'altra un'ideologia che faceva riferimento a concezioni di Sinistra, Marxiste e questo ha fatto sì che in questo Paese, come giustamente diceva Marguerettaz, le politiche di sostegno alla famiglia siano fra le più deboli in Europa, siamo al dodicesimo posto nella graduatoria europea per quanto riguarda gli interventi a sostegno della famiglia. Infatti, sia per quanto riguarda gli assegni familiari che praticamente sono scomparsi, sia per quanto riguarda le detrazioni fiscali, i servizi, la casa e via dicendo non si può dire che ci sia una politica compiuta della famiglia anche se un qualche tentativo in questa direzione è stato messo in campo dal Governo non senza polemiche. Penso a questo provvedimento che riguarda la possibilità di un allargamento dei congedi parentali che ha creato un grande dibattito soprattutto fra i datori di lavoro.
Detto questo, credo che al fondo della discussione che facciamo ci siano indubbiamente valutazioni diverse rispetto ad alcune questioni che riguardano l'uguaglianza fra i sessi, la divisione del lavoro fra uomo e donna all'interno della famiglia e i problemi legati all'autonomia individuale e alla responsabilità sociale, ma credo anche che questa legge sia una legge che, almeno per quanto riguarda l'articolo 1, la definizione della famiglia, in cui si tiene conto in modo laico di una realtà che c'è nella nostra società valdostana, e per quanto riguarda l'articolo 3, la definizione degli obiettivi, sia una legge, dicevo, che pone in modo positivo alcune questioni.
Innanzitutto viene posta in evidenza la necessità che ci sia una parità fra uomo e donna nella responsabilità e nella condivisione dei compiti familiari; c'è un'attenzione ai soggetti deboli perché indubbiamente la famiglia può essere considerata un soggetto forte, ma anche qui ci sono famiglie più forti o meno forti delle altre ed avere attenzione ai soggetti deboli significa alleviare molti dei problemi che ci sono all'interno della famiglia. Ci sono questioni legate ad un potenziamento di servizio, che questo non debba avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'ente Regione sono assolutamente d'accordo cioè che si debba passare come si diceva da un "Welfare State" ad un "Welfare Society", nel senso che deve essere la società nel suo insieme che deve essere responsabilizzata per la gestione di alcune questioni che riguardano la vita sociale, questo è vero. Così come ci deve essere, e questo è previsto nella legge, una collaborazione fra la Regione e il privato sociale.
È altrettanto vero che nella legge vengono affrontate alcune questioni importanti per quanto riguarda l'indennizzo degli infortuni domestici e i provvedimenti sul piano della previdenza, così come si affronta - su questo poi tornerò - la questione di favorire la costituzione di nuove famiglie.
Uno degli ultimi articoli riguarda anche la necessità di monitorare e di seguire lo sviluppo dell'evoluzione della famiglia visto che la famiglia non è una e data; non è necessario consultare testi di antropologia per capire quanto sia mutevole la famiglia in una singola famiglia e in società diverse e credo che vadano seguiti gli sviluppi di quest'importante struttura sociale.
Vorrei venire ad una questione per me importante. All'interno della legge, in particolare all'articolo 8 che riguarda la costituzione di nuova famiglia, viene posta una questione che credo sia posta in termini contraddittori con lo stesso impianto della legge. L'impianto della legge nell'articolo 1, commi 1 e 2, definisce cos'è la famiglia e all'interno di questa definizione non c'è alcun riferimento alle caratteristiche o agli orientamenti sessuali dei singoli componenti la famiglia stessa. Ora porre, nel momento in cui si parla di costituzione di nuova famiglia, le questioni legate all'eterosessualità, quest'aggettivo che compare nel comma 2, lettere c) ed e) dell'articolo 8, credo che sia impostare una questione che va al di là della legge stessa.
È una questione che pone la necessità di garantire, cosa che nella legge non viene fatta, parità di diritti a tutti indipendentemente dalle scelte che sul piano individuale vengono fatte. Se l'intenzione della legge è escludere alcuni cittadini dalla possibilità di fruire del mutuo previsto in quest'articolo, credo che questa discriminazione non debba assolutamente essere, prima di tutto perché si ledono i fondamentali diritti di ogni individuo. Nel momento in cui si riconosce che la famiglia è un nucleo fondante della società, in cui si costituiscono dei legami di solidarietà, di mutuo aiuto e attività di cura, credo che il collegamento al fatto di essere etero o omosessuali non abbia nessun motivo di essere. Ci sono in tal senso delle indicazioni specifiche, acquisite a livello della stessa Comunità europea; la Gazzetta ufficiale della Comunità europea nel 1994 già richiamava gli stati membri a fare in modo che nelle norme giuridiche amministrative si eviti la disparità di trattamento delle persone con orientamento omosessuale.
Si potrebbe continuare con l'elencazione di raccomandazioni decise dall'Unione Europea, ma quanto ho letto credo sia sufficiente.
I diritti e i doveri dei cittadini sono indipendenti dalla razza, dalla religione e dall'ideologia di ciascuno e questa è una lezione che più o meno è stata appresa da tutti, dalla rivoluzione francese in poi; abbiamo visto recentemente che qualcuno si è distaccato da questo tipo di interpretazione, ma non voglio entrare in discussioni che hanno interessato i "mass media" negli ultimi giorni. Per quanto ci riguarda credo che uno Stato fondato su una garanzia di uguaglianza di diritti per tutti non possa compiere discriminazioni di questo tipo. Questo vale per lo Stato, vale per le leggi regionali; sarebbe un'anomalia nel panorama nazionale una legge di questo genere. Da questo punto di vista insieme ai Consiglieri Florio e Chiarello ho presentato un emendamento che va nella direzione di garantire un'uguaglianza di diritto di accesso a tutti i cittadini valdostani a quanto previsto dall'articolo 8. Aggiungo che, per quanto riguarda il mio Gruppo, la valutazione complessiva sulla legge sarà legata all'esito della votazione su quest'emendamento.
Si dà atto che, dalle ore 17.59, presiede il Presidente Stévenin.
Président La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) Arriviamo al voto su quest'importante legge in un momento che forse non è il più felice: alla vigilia dello scioglimento di questo Consiglio quando la fretta impedisce gli approfondimenti e i confronti che sono sempre meno costruttivi e sempre più influenzati dalla campagna elettorale.
Nello stesso tempo, pur nell'affanno del momento, appare evidente l'importanza di una legge che rappresenta una svolta significativa nella politica sociale dell'Amministrazione regionale. La legge non è esente da limiti e da imperfezioni, è vero, ma è meglio una legge migliorabile, perfettibile, su cui dovrà lavorare chi dopo di noi verrà.
A nome della Fédération Autonomiste ribadisco innanzitutto il fatto positivo costituito dalla stessa presentazione della legge che per la prima volta considera la famiglia come soggetto di diritti e di doveri pubblici e non solo l'espressione di sentimenti individuali.
Nel programma della Fédération Autonomiste si enuncia che la Federazione crede nel ruolo della famiglia come cellula primaria della società facendo proprie le definizioni che già il programma della Lista ADP-PRI-Indipendenti del 1993 dava di essa: unità di servizi primari e ambito di formazione di comportamenti solidaristici.
Tali enunciazioni mi sembrano perfettamente in linea con la relazione della proposta di legge, dove si dice che la famiglia è formazione sociale primaria e soggetto fondamentale di interesse pubblico. E qui inizia la diatriba dialogica con argomenti che, più che basati su quanto dice la legge, si aggrappano a pretesti per affermare le tesi che si vogliono reclamizzare.
Ci è parso semplicemente ridicolo il chiasso sollevato sull'articolo 8 che riguarda un prestito per l'arredo dell'abitazione, mentre si è fatta scivolare l'attenzione sull'articolo 1 che invece garantisce i servizi e gli aiuti a tutti i nuclei familiari. Non sarebbe il caso di parlarne oltre se non per mettere in risalto un dato che finora nessuno ha fatto notare: nella preparazione dell'articolo 8, trattandosi di una materia attinente alla casa, probabilmente l'Ufficio ha preso l'elenco degli aventi diritto degli iscritti all'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1995 ebbene, in quell'articolo si dà il diritto di entrare in graduatoria a tutte le convivenze, con buona pace di chi ha accusato la Regione Valle d'Aosta di discriminazione. Parlando di famiglie di nuova formazione, quell'articolo 5 è parso forse eccessivo agli estensori che sono ricorsi alle precisazioni che hanno destato scalpore.
Sarei del parere che, per quanto riguarda quell'articolo 8, sarebbe bene che il regalo di nozze per i mobili lo si facesse solo ai giovani che si sposano per la prima volta ma, al di là di quell'articolo, che ha avuto importanza più per le affermazioni di principi ideologici che non per la sua effettiva portata, la legge, dicevo, segna una svolta nella politica sociale della Regione perché, anziché sostituirsi alla famiglia, si vuole aiutare la famiglia nei suoi compiti naturali, soprattutto quando si parla della persona malata e bisognosa di assistenza. È in questi casi che l'intervento pubblico viene moltiplicato se trova il sostegno della famiglia e se a sua volta è di sostegno alla famiglia.
Tali aiuti e servizi sono previsti in varie leggi regionali che con la presente legge sulla famiglia non vengono abrogate e neppure coordinate. È già emersa in Commissione l'esigenza di predisporre un testo unico di tutte le norme di assistenza sociale per coordinarle con la politica familiare senza che vi debba essere identità fra politica familiare e politica di assistenza sociale. Questa legge infatti, deve inaugurare una politica familiare della nostra Regione.
Nella politica familiare conviene distinguere i due aspetti, come molti ci hanno raccomandato, al fine di raggiungere sia gli obiettivi che vogliamo, sia l'efficacia nei provvedimenti. Il primo aspetto riguarda le situazioni di gravità sanitaria e sociale e può coincidere con la politica di assistenza sociale perché riguarda comunque interventi in favore di famiglie con problemi più o meno gravi. Il secondo aspetto riguarda invece gli interventi di sostegno alla famiglia normale che possono essere ricondotti a tre ambiti: a) l'incentivazione della procreazione in funzione del riequilibrio della popolazione per classi di età, è dimostrato matematicamente che se le classi di età continueranno a disporsi a piramide rovesciata, vi sarà il crollo di tutto il sistema previdenziale; b) la restrizione delle risorse al fine di ridurre gli aspetti di diseguaglianza dipendenti dalle situazioni familiari attraverso strumenti che consentano la possibilità di accesso all'istruzione, alla casa, al lavoro, la possibilità di fruire di servizi sociali; c) il sostegno alle responsabilità familiari soprattutto degli anziani e dei minori.
Per questo secondo aspetto della politica familiare ripetiamo che la legge in discussione ne segna l'inizio e dovrà essere non solo il prossimo Consiglio, ma l'intera società civile valdostana a continuarne l'approfondimento e a studiare i nuovi strumenti a servizio della solidarietà familiare e sociale.
Vi è infine la questione della diversa visione di cosa si intende per famiglia in leggi di questo tipo. A questo riguardo la Fédération Autonomiste, dopo un approfondito dibattito al suo interno, ritiene che non si possono imporre con leggi comportamenti individuali che attengono alla sfera delle coscienze, pertanto lascia libertà di voto al singolo consigliere.
Certi comportamenti sociali si sono determinati e i problemi che essi creano vanno affrontati; non risolveremmo certo, ad esempio, il gravissimo problema dei figli di divorziati escludendo le loro famiglie dai servizi sociali. I provvedimenti di assistenza sociale vanno estesi a tutti in quanto persone, ma al di fuori della legge crediamo che si possa favorire un costume diverso soprattutto con strumenti culturali attraverso l'affermazione e il dibattito dei fini sociali dell'istituzione familiare. È con questi strumenti culturali che l'idea che la vera famiglia è quella basata principalmente sul matrimonio può vincere la partita e non attraverso gli sbarramenti legislativi, evitando però principi discriminatori nei confronti di altre composizioni familiari e di situazioni di famiglie di fatto.
Sono convinto che la Pubblica Amministrazione dal canto suo debba essere imparziale e questo vale in tutti i sensi: se è giusto che i servizi vengano dati anche ai figli dei conviventi, è meno giusto che abbiano sconti come figli di ragazza-madre.
Ai fini di una corretta applicazione della legge risulterà pertanto importantissima la certificazione di quei legami socialmente assunti, indicati nel 2° comma dell'articolo 1.
Concludo esprimendo, pur con le considerazioni sopra menzionate, un giudizio positivo al disegno di legge.
Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) È apparso chiaro anche dagli interventi precedenti come sia difficile fare un disegno di legge che riguardi la famiglia ed è una difficoltà che è collegata alla stessa difficoltà di individuare quale obiettivo abbiamo in mente: la famiglia in quanto tale oppure i singoli membri, specialmente quelli più in difficoltà?
Se pensiamo alla famiglia in quanto tale, ci poniamo il problema di definire quale tipo di famiglia. Sono apparse già negli interventi precedenti posizioni diverse su che cosa si intende per famiglia. Io vorrei solo qui ricordare che tutte le analisi attuali sono concordi nel dire che ci troviamo di fronte a più tipologie di famiglia, non possiamo più parlare di un unico modello di famiglia anche perché è tipico delle società complesse trovarsi di fronte a modelli diversificati. Le società complesse sono contraddistinte dal pluralismo culturale e quindi da una pluralità di rappresentazioni e di modi di intendere i comportamenti accettabili socialmente. Questo prendere in carico il modello di famiglia in una società complessa credo che sia una delle operazioni di tipo culturale che con questa legge dobbiamo fare.
Rispetto all'altro problema, se vogliamo prendere in esame i singoli membri della famiglia, dobbiamo anche verificare che attualmente sta cambiando il modo di intendere i rapporti all'interno della famiglia. In genere le leggi regionali che sono state emanate in altre regioni privilegiano interventi rivolti alle singole categorie di persone. La nostra stessa legislazione regionale ha già una serie di leggi che si rivolgono ai minori, all'assistenza economica di chi non raggiunge un minimo vitale, norme che riguardano aiuti ai minori, norme che riguardano aiuti a favore di persone anziane, handicappate, alcoldipendenti, tossicodipendenti, affette da HIV e via dicendo. Che cosa sarebbe stato necessario fare allora nella nostra Regione? Ritengo che nella nostra Regione c'era bisogno prima di tutto di fare una legge quadro che mettesse ordine fra le diverse tipologie di intervento e che comprendesse alcuni di quei settori non ancora presi in considerazione. L'idea di quest'Albo delle persone casalinghe è un'idea interessante che in una legge quadro poteva essere inserita come uno degli elementi integrativi all'interno di una legge quadro più generale. C'era bisogno anche di individuare degli spazi di azione riconosciuti alle famiglie in quanto tali.
Chiediamoci se questo disegno di legge risponde a questi obiettivi. Possiamo dire con molta chiarezza che questa non è una legge quadro anche se questo era stato chiesto da tutti coloro che sono stati sentiti in V Commissione abbiamo sentito, anche se è stata un'esigenza che in Commissione è emersa da più parti, ma quest'esigenza non si è tradotta in una proposta legislativa. Teniamo conto che tutta una serie di elementi che in Commissione sono stati presentati dai soggetti ascoltati, hanno avuto uno stop da parte della Commissione, quindi anche all'interno della Commissione c'è stato un lavoro tale per cui quest'idea non è stata vincente rispetto alla situazione attuale.
Ancora ci chiediamo se non c'era bisogno di integrare l'esistente legislatura con alcuni interventi in alcuni ambiti. A questo riguardo dobbiamo dire che in questa parte la legge si presenta piuttosto come un "collage" di singoli interventi che rispondono però a logiche diverse, nel senso che non c'è una filosofia di fondo in cui trovino una loro collocazione tutte le varie tipologie di intervento previste. La prima parte della legge è essenzialmente una dichiarazione di principi che o sono già presenti nel piano socio-sanitario o sono presenti in altre leggi regionali; alcuni di questi sono di per sé affermazioni importanti che però rimangono affermazioni di puro principio e faccio due esempi. Quando all'articolo 2 nelle finalità si dice che la Regione promuove un'azione tesa a "... sostenere il diritto della coppia alla scelta positiva, libera e responsabile della procreazione, offrendole anche opportunità sociali e sostegni socio-culturali idonei a superare i motivi che la inducono a restrizioni non desiderate della fecondità;" diciamo che, rispetto a questo piano, la legge non dà nessuno sbocco operativo, chiaro, tale da aiutare a superare questa tipologia di motivi.
C'è poi una seconda parte della legge, gli articoli 4, 5 e 6, che riprende alcune affermazioni del piano socio-sanitario senza dire come fare per realizzare quanto questo Consiglio ha già a suo tempo approvato.
C'è una terza parte in cui sono inseriti alcuni elementi di novità: un prestito di onore alle famiglie di nuova formazione, dei contributi per bambini di famiglie numerose, l'assistenza alle persone in difficoltà, "vouchers" per anziani, indennità per infortuni domestici e per degenza ospedaliera per le persone casalinghe, sono interventi tutti estremamente interessanti che però presentano una serie di ambiguità su cui dopo voglio tornare.
C'è la quarta parte che è la più innovativa, nel senso che cerca di delineare uno spazio di azione e di autorganizzazione per le famiglie, un modo con cui la famiglia possa partecipare alla politica regionale per delineare le scelte che la Regione intende fare nell'ambito della famiglia. C'è però anche a questo riguardo un elemento di ambiguità perché viene individuato un terzo soggetto che interviene nell'organizzazione e gestione dei servizi oltre agli enti locali e al privato sociale, nel senso che queste famiglie prendono corpo attraverso una gestione solidaristica di servizi, ma senza che si individui bene in cosa consista questa gestione solidaristica e in che rapporto sta con quelli che sono gli interventi degli enti locali e delle cooperative sociali.
Dicevo che ci sono in questa legge una serie di incertezze e di ambiguità, vorrei metterne in risalto due o tre.
C'è una scelta di fondo che non condividiamo, nel senso che vengono erogati soldi invece di garantire servizi; c'è un assegno post-natale, ci sono dei "vouchers" per gli anziani, ci sono delle indennità per gli infortuni domestici.
È vero che bisogna intervenire in aiuto della famiglia per metterla in grado di acquistare i servizi, ma lo scegliere come una delle strade principali quella di dare denaro per aiutare la famiglia, è una scelta molto pericolosa che va nell'ottica di monetizzare i figli. Prendiamo l'assegno post-natale, certo che costa mantenere un figlio però, la scelta che è stata fatta è molto strumentale. Innanzitutto, forse che un figlio costa soltanto per i primi anni di vita? E dopo? Non solo, le difficoltà che hanno i genitori per avere un figlio possiamo forse superarle con quest'assegno post-natale? Come ricordavano già altri prima di me, uno dei motivi per cui noi siamo nazione ed una Regione a bassa natalità sta proprio nel fatto che non esiste da parte della donna e della famiglia la possibilità di avere tutti i figli che vorrebbero avere. Da ricerche fatte è stato accertato che esiste nelle donne un desiderio di maternità pari a 2,4 figli per donna, cosa che invece è ridotta nella realtà a 1,2 quindi, vuol dire che da parte delle famiglie esiste il desiderio di avere dei figli; se non lo fanno è perché ci sono delle oggettive difficoltà che riguardano in particolare la donna. Se prendiamo atto di alcune statistiche, vediamo con molta chiarezza che il tempo che le donne dedicano al lavoro della casa e al lavoro di cura dei figli è cinque volte maggiore del tempo che dedicano agli uomini. Nella Conferenza mondiale a Pechino è apparso che la donna italiana è quella che lavora di più: oltre alla propria professione, c'è il lavoro di cura; fa quindi un doppio lavoro: in casa e fuori casa. È stata fatta recentemente a Torino una ricerca in cui si è provato a calcolare quante ore vengono dedicate al lavoro retribuito nell'arco di una giornata per tutto l'arco dell'anno compreso anche il sabato, la domenica e le feste e si è fatta una media, ne è emerso che il tempo dedicato al lavoro retribuito condotto da un individuo nell'arco di una giornata è di 3 ore 36 minuti. Se calcoliamo sempre per la stessa tipologia di famiglie quale tempo viene dedicato nell'arco di una giornata al lavoro di cura, lavoro domestico tutto compreso, si raggiunge un tempo pari a 3 ore 10 minuti, quasi quanto quello richiesto dal lavoro professionale. Questi dati ci dicono come questo carico di lavoro sia indice della difficoltà per la donna di conciliare il lavoro di cura con il lavoro professionale e questo esiste anche per la nostra Regione, dove, in base ai dati ISTAT, il numero delle donne che lavorano oltre che fuori casa anche in casa è decisamente superiore di quello delle donne che lavorano solo in casa; si aggira sulle 16mila unità contro le 12mila unità di donne solo casalinghe. Questo per dire come la situazione della donna col doppio carico di lavoro pesa anche nella nostra Regione.
Cosa fare per aiutare a conciliare il lavoro di cura con il lavoro professionale, come facilitare la funzione dei genitori, come aiutare le famiglie ad accogliere i bambini? Sicuramente offrire loro una tipologia variegata di servizi è importante, non solo, ma è importante agire su tutte le tipologie di servizi. Abbiamo l'altro giorno votato una delibera in cui calcoliamo il costo che le famiglie devono sostenere per le colonie estive; nel momento in cui ci apprestiamo ad elaborare una legge sulla famiglia, aumentiamo anche l'onere che le famiglie devono sostenere per mandare i loro figli nelle colonie estive organizzate dagli enti locali. Quest'azione ci dice come una delle linee importanti da seguire dovrebbe essere quella di puntare di più su tipologie di servizi diversificate con dei costi che non penalizzino le famiglie.
La legge presenta, rispetto a quest'aspetto, un elemento interessante che è la previsione di tipologie diverse di servizi per la prima infanzia cioè la tata e "les garderies". Questa che è la parte più innovativa del disegno di legge rimane però soltanto a mo' di indicazione, non viene precisato bene cosa se ne vuol fare cioè si è persa ancora una volta l'occasione per delineare una tipologia di servizi che poteva essere utile per venire incontro alla difficoltà che hanno le famiglie di accogliere i bambini e di educarli, seguirli nel poco tempo che hanno a disposizione.
Prendo ancora un altro esempio per dire come ci siano delle ambiguità e delle incertezze in questo disegno di legge ed è l'articolo 8. Il titolo parla di interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione. Quindi se prendessimo sul serio il titolo dell'articolo, dovremmo trovarci di fronte ad una famiglia di nuova formazione cioè ad una famiglia che nasce per la prima volta, quindi dovremmo trovare un limite di età entro cui il soggetto ha diritto ad accedere a questo tipo di intervento. Ma questo non c'è.
Ancora, non si prende neanche in esame la possibilità che questo tipo di intervento debba essere garantito una sola volta e non più volte, altrimenti per assurdo ci troveremmo di fronte a soggetti che possono nel corso della propria vita formare più famiglie e quindi ogni volta ricorrere a questi contributi.
Dico anche per assurdo che un uomo e una donna settantenni, che decidono di sposarsi, questi possono accedere a questo mutuo, mentre non possono accedervi due donne anziane che decidono di mettersi insieme per far fronte alle difficoltà. Questo per dire che c'è una contraddizione tra quello che dice il titolo e quello che poi viene indicato.
In quest'articolo 8 si fa un passo indietro rispetto a quanto già questo Consiglio regionale aveva stabilito quando, nella legge regionale n. 39/95, aveva indicato qual era il nucleo familiare che poteva accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Mi chiedo perché questo Consiglio debba cambiare logica con cui osservare la famiglia. Per questo abbiamo firmato l'emendamento presentato su quest'articolo, non perché si voglia incentivare le famiglie omosessuali, come qualcuno ha detto prima, ma proprio per non escludere questa categoria di persone tanto più che nell'ottica dell'articolo c'è un'idea di non mirare solo ad una tipologia particolare di famiglia.
Infine, l'ultimo aspetto critico di questa legge. È una legge che promette molto, ma dà anche poche certezze, Assessore. Si parla di un assegno post-natale, ma non si sa chi ne ha diritto, non è stato inserito alcun parametro. È vero che sarà la Giunta a decidere, ma che speranze possiamo dare ai cittadini? Chi ha diritto a questo tipo di assegno: coloro che hanno il minimo vitale, coloro che hanno il doppio del minimo vitale, coloro che hanno un reddito pari al reddito medio?
Ancora, è una legge che promette molto ma dà poco. Prendiamo l'articolo 18, sostegno della cura di soggetti in difficoltà, è buona l'idea di dare un contributo a chi sta a casa per seguire nella propria famiglia un familiare in difficoltà, ma di fatto promettiamo a queste persone 388.000 lire mensili. Mi sembra che sia una cosa ridicola tanto quanto una pensione sociale; ci vorrebbe almeno il doppio della pensione sociale altrimenti, è un finto aiuto che viene dato, nel senso che appare come un aiuto che può consentire ad un familiare di stare a casa per seguire un malato in difficoltà e poi l'aiuto è minimo se non irrisorio.
L'impianto complessivo della legge quindi non ci convince, abbiamo presentato alcuni emendamenti, vediamo se saranno accettati. Abbiamo cercato di esprimere le nostre perplessità e abbiamo presentato emendamenti anche in Commissione, dove però è prevalsa una direzione diversa rispetto a quelle indicate dai vari gruppi che avevamo ascoltato. Era stata chiesta una legge quadro e abbiamo avuto un "collage", erano stati chiesti più servizi e qui sono stati elencati i servizi, per i quali non esistono finanziamenti, erano state chieste procedure e strumenti per realizzare quanto indicato nel piano e nelle altre legge e invece sono stati rimodulati gli stessi obiettivi senza però giungere ad indicazioni operative concrete. Presento qui due emendamenti.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz pour sa deuxième intervention.
Marguerettaz (Aut) Nel secondo intervento vorrei fare invece alcune osservazioni nel merito del disegno di legge che, per quanto mi concerne, non può seguire vie diverse se non quella di paragonare la proposta che oggi siamo chiamati a discutere con quella che era la mia proposta iniziale e che non sono qui con presunzione ad affermare che fosse la migliore risposta ad una domanda di politica familiare, proposta sulla quale poi la V Commissione si è astenuta a maggioranza, impedendo così che la medesima arrivasse in Consiglio.
Credo, e non me ne do atto da solo perché mi hanno dato atto di questo, che una differenza sostanziale fra la nostra proposta e quella dell'Assessore sia che la proposta dei Consiglieri seguiva una linea e su questa linea, condivisibile o meno che fosse, aveva il pregio di mantenere una certa coerenza. Non si può dire altrettanto del testo proposto dalla Giunta.
Dicevo prima al collega Florio, che il limite più grande che ha questa proposta di legge è il fatto di non avere avuto il coraggio di analizzare con serenità, secondo il proprio modo di vedere la realtà perché la politica vuol dire questo innanzitutto, la situazione della nostra società valdostana, di cercare di proiettarla nel futuro in prospettiva e da quest'analisi di tirarne una conclusione che fosse lineare cioè che seguisse un indirizzo politico, chiaro, netto, limpido, giusto o sbagliato che fosse.
Mi sembra invece che la proposta che ci giunge - in questo senso sono d'accordo con quanto ha detto la collega Squarzino - è piuttosto pasticciata, ricca di contraddizioni che poi andremo a vedere più dettagliatamente quando analizzeremo l'articolato perché ci si è posti debolmente di fronte a tutta una serie di domande che lecitamente poi vengono poste nel corso di un dibattito intorno ad una politica familiare quali quelle che sono anche emerse qui all'interno del nostro dibattito. La cosa che ha fatto più scandalo della proposta del sottoscritto era che tutti gli interventi fossero limitati ad una famiglia fondata sul matrimonio.
Tale proposta ha più di una motivazione che cercherò di illustrarvi e che spero serva a farvi capire la mia personale posizione sul perché l'articolo 1 di questa legge non mi può convincere.
Prima di addentrarmi in questa questione così difficile e così delicata, è bene sgomberare il campo da tutta una serie di equivoci. Le prime questioni da chiarire sono che una legge non può avere né dare né sottintendere un giudizio morale sulle scelte affettive che liberamente i cittadini fanno. Questa è la prima considerazione che voglio fare per cui non sono qui a dire che le coppie di fatto così come le coppie omosessuali sono dei cittadini di serie B, ma sono dei cittadini che hanno gli stessi diritti di ogni altro cittadino in questa Regione.
La seconda considerazione che voglio fare è legata alle cose che ho detto nel primo intervento. Se la Regione decide di investire sul soggetto famiglia, se pensa che investire su queste relazioni che si stabiliscono fra più soggetti sia utile non solo per l'Amministrazione anche da un punto di vista di impostazione di certe politiche sociali, educative e sanitarie, ma sia utile per la crescita della nostra società valdostana, è evidente che per tirare fuori un soldo dalle casse del bilancio pubblico non si può non chiedere un qualsiasi impegno da parte di chi il soldo riceve. Chiedo scusa della elementarietà del ragionamento, ma spero che così sia chiaro. È evidente che per tutti i servizi che quest'Amministrazione regionale offre, quest'impegno viene richiesto. Faccio velocemente tre esempi: laddove l'Amministrazione regionale tira fuori un soldo per un mutuo per la casa, impegna colui che lo riceve a costruire la casa e a restituire questi soldi; quando lo stesso soldo viene tirato fuori per gli studenti per gli assegni di studio, viene chiesto agli studenti l'impegno a sostenere un certo numero di esami; quando lo stesso soldo viene dato per il verde agricolo, viene chiesto che il beneficiario mantenga il suo prato verde. È normale, questa è l'ottica dell'Amministrazione.
Ora, qual è l'impegno che viene richiesto ai beneficiari di questa legge? Direi nessuno, se non un impegno di carattere affettivo che così come nelle coppie sposate come in quelle conviventi - purtroppo sappiamo tutti la fragilità umana da questo punto di vista - può venir meno.
Cosa rappresenta la famiglia fondata sul matrimonio rispetto a una coppia di fatto o ad una coppia omosessuale? C'è un dato e uno solo che pone questi due soggetti su gradini diversi, senza toccare minimamente - e lo sottolineerò ogni volta che farò questa differenza - il diritto individuale di ogni cittadino: quando due persone decidono di sposarsi in comune e anche in chiesa firmano questo foglio, un foglio molto semplice dove i coniugi sottoscrivono i diritti e i doveri che hanno reciprocamente nei confronti dei figli, nei confronti della vita familiare in genere. Sono gli articoli 143, 144, 147 che chi di voi è sposato ricorderà certamente, più o meno. Io li leggo perché può servire, per me personalmente a rinfrescarmi la memoria... per l'occasione non indosserò né la stola né la fusciacca...
Dicono questi articoli:
- "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
- I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano la residenza della famiglia a seconda delle esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli".
Per quanto mi concerne, per essere chiari fino in fondo, è questo semplice pezzo di carta che certifica un pubblico impegno assunto da due persone che si fanno carico, come è chiaro dalla lettura degli articoli, di problemi di carattere sociale e a fronte del quale è giusto spendere quel famoso soldo dell'Amministrazione regionale.
Le altre situazioni familiari non prevedono nessuna assunzione di responsabilità pubblica; probabilmente ci sono di famiglie di sposati che dopo due mesi finiscono con un divorzio o una separazione, ci possono essere invece delle famiglie di conviventi che durano tutta una vita, quindi non entro in questo merito. Dico solo che non si può non richiedere, e qui rientro in un discorso più generale, una responsabilità da parte delle famiglie. Non è pensabile di dare tutta una serie di servizi o di emolumenti, quali sono previsti da questa legge, senza richiedere nessun tipo di impegno ai soggetti che ne beneficiano.
Mettere sullo stesso piano tutti i tipi di famiglie come fa l'articolo 1, ovvero la Regione riconosce la famiglia comunque formata, significa, guardando soprattutto al futuro della nostra Comunità valdostana, porre un elemento che dovrebbe farci riflettere oggi. E l'elemento di riflessione è questo, la sfida che viene rivolta nei miei confronti quando faccio questo ragionamento è: "Tu non vedi la realtà, tu non ti rendi conto che le famiglie sono diverse, non ci sono solo gli sposati..." eccetera. Io sono convinto però che una politica non deve seguire solo ciò che avviene in una comunità, ma deve avere la presunzione, il coraggio, la forza, il rischio di guidare una comunità. Pensiamo se, quando ragioniamo in termini economici, ragionassimo sugli stessi termini con i quali ragioniamo su questa legge: non favoriremmo certo la crescita economica della nostra Regione.
Dicevo che diventa un elemento su cui riflettere in prospettiva perché vero è che oggi stanno crescendo le convivenze nella nostra Regione e vero è che sulla famiglia fondata sul matrimonio si sta lentamente spandendo un giudizio tendenzialmente negativo. Parlare oggi di matrimonio come ne sto parlando io sicuramente non è sinonimo di progressismo o di modernità o di apertura, ma certamente promulgare una legge qual è quella che stiamo discutendo comporterà nei confronti delle nuove generazioni un grosso rischio che è quello di far pensare che l'assunzione di responsabilità nel campo familiare così come in altri campi è fatto secondario e relativo.
Ecco perché paradossalmente una legge, che parte con dei principi sicuramente onesti e di buona fede, però impostata così com'è rischia di giocare contro l'obiettivo che vorrebbe porsi, rischia cioè di lavorare non per la crescita della famiglia, delle responsabilità familiari, delle reti di sostegno fra famiglie, ma per una disgregazione, uno svilimento della famiglia così come la intendevo.
Spero di avere risposto in qualche modo a chi pensava che il sottoscritto fosse prevenuto nei confronti dei conviventi o degli omosessuali. Torno a ripetere per la terza volta, prometto che non lo ripeto più, che sono questioni decisamente diverse: una è la libertà che va rispettata del singolo individuo di vivere la propria vita affettiva e sociale come meglio ritiene, un'altra è non richiedere da parte dell'intervento pubblico ai nuclei familiari verso cui ci si indirizza nessuna forma di impegno concreto e reale.
La seconda osservazione che voglio fare su questo disegno di legge, sempre in termini piuttosto generici, riguarda il ruolo che si dà a questa famiglia così come è stata individuata.
L'impressione che ne ho io, anche se devo riconoscere che l'Assessore nel corso degli ultimi mesi ha cercato di mettere una pezza, altrimenti sarei stato molto più determinato di quello che sono a dire queste cose, è che la famiglia diventa ancora troppo un oggetto dell'Amministrazione pubblica, un'entità che deve ricevere da parte della Pubblica Amministrazione. Per quanto mi concerne, ho visto solo quell'articolo aggiuntivo dei progetti sperimentali, è come se si dicesse alla famiglia: con questa legge ti facciamo provare se sei capace di fare qualcosa, se sei capace di tirare su qualcosa da te, ma c'è ancora enorme la presenza del pubblico che fa scendere tutta una serie di emolumenti, di servizi e cose di questo genere.
Terza ed ultima considerazione, di cui ho già avuto modo di parlare in Commissione e con l'Assessore, che ribadisco. C'è un problema che potrebbe giocare comunque a favore delle famiglie che però non abbiamo trovato presente in questa legge.
Quando ho proposto di inserire un capo della legge per me estremamente significativo che era quello che riguardava la valutazione dei redditi familiari, l'Assessore non mi ha detto che era contrario. Mi ha detto invece una cosa vera: che fare questo, pensare di mettere mano a tutti i servizi, a tutti i mutui, a tutti gli emolumenti, a tutto ciò che fa la Regione e per cui chiede alle famiglie di presentare la dichiarazione dei redditi, e noi sappiamo oggi che vengono valutati in maniera molto diversa a seconda del tipo di servizio e di Assessorato, chiedere, di fronte a questa situazione, di trovare un sistema che salvasse la famiglia, che rendesse omogenea la valutazione dei redditi familiari, che prendesse finalmente nella giusta considerazione il carico familiare, l'Assessore, dicevo, mi ha detto che questo è giusto in linea di massima, ma è spaventoso perché significa ripensare tutto il servizio regionale. Ed è qui che volevo arrivare quando dicevo, nel primo intervento, che pensare una politica per la famiglia significa dar vita ad una vera e propria rivoluzione di un sistema, cosa che, di fronte ad una proposta di questo genere, è talmente grande e difficile che spaventa affrontarla fino in fondo. Eppure, mi ripeto, rimane il fatto che una famiglia con un reddito di 50 milioni, dove ci sono 5 persone, è comunque più povera di una famiglia composta da una sola persona con un reddito di 30 milioni.
Il dibattito che si è svolto su questa legge è stato almeno per me estremamente interessante. Non voglio apparire come quello che è arrivato su questo tema con delle certezze e se ne esce con le stesse certezze e lo faccio senza fare della demagogia, ma voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti oggi, così come quelli che sono intervenuti, dall'Assessore ai membri della Commissione, tutti quelli che in questi mesi hanno contribuito a tenere vivo il dibattito su questo tema. Mi auguro che questo dibattito continui ad essere tenuto vivo perché io non voterò questa legge, altri la voteranno, la legge passerà, ma l'importante è su tematiche di questo genere di non sedersi. Non pensiamo che, una volta approvata questa legge, abbiamo risolto i problemi della famiglia anche perché quella Signora di Cogne, di cui leggevo la lettera nel primo intervento, credo che abiti lontano da tutta la nostra proposta di legge, non i 30 chilometri che ci dividono da Cogne, ma qualcosa come 3000 chilometri.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) En priant le Président du Conseil de distribuer les amendements techniques que je présente, permettez-moi de remercier les collègues qui sont intervenus portant des positions différentes, mais également dignes et importantes.
Permettez-moi aussi de faire une petite prémisse générale par rapport à l'analyse technique du projet de loi et ce pour célébrer la solennité de l'événement puisque notre Région est la première communauté locale qui présente un projet de loi complet, organique et à l'avant-garde.
Face à n'importe quel problème d'ordre social, culturel ou économique, il se peut que l'administrateur propose une comparaison avec le passé: autrefois le problème se posait de façon différente et à chaque fois que cet administrateur ne s'est pas caché un certain ton d'émotion ou de regret, il y a de quoi chercher à les expliquer comme les signes d'un respect pour la tradition perdue - quelqu'un pourrait dire mieux: trahie - et à cet administrateur on reprochera un certain arrièrisme, on affirmera qu'il ne sait pas comprendre la réalité et que le passé poétique auquel il fait référence n'a jamais existé. Le passé c'était la pauvreté, la dureté de la vie quotidienne.
Je prends le risque d'être accusé et ironiquement critiqué en vous rappelant ce que c'étaient le foyer valdôtain et la famille valdôtaine. La famille dans tous ces aspects est liée à la parenté sur laquelle les ethnologues attentifs aux lointaines réalités tribales ne se sont jamais penchés. Rappeler le foyer et la famille est en même temps mémoire, nostalgie et racines auxquelles se rapporter pour bâtir un présent différent et, si les ressemblances entre hier et aujourd'hui ne sont presque plus perçues, il suffit d'en être conscients et de savoir pourquoi nous nous en sommes tellement éloignés.
Les Valdôtains n'ont pas été les protagonistes, mais les victimes des changements sociaux qui se sont passés au cours du dernier siècle. Ils ont été spectateurs impuissants, puisque dépourvus d'instruments pour intervenir et déterminer le social.
Aujourd'hui nous avons l'autonomie, il est faux toutefois de rappeler la pauvreté du passé pour nier la validité du souvenir du passé. Aujourd'hui une autre, plus grave pauvreté obsède la famille lorsqu'il ne s'agit pas de pauvreté au sens économique et monétaire; ce sont les mécanismes de la société, son individualisme poussé, ces nouvelles valeurs de référence: la compétition, le succès à tout prix, à appauvrir la famille. La famille ne sait plus être le point fort de la société et s'affaiblit. Pauvreté ancienne et pauvreté moderne, la différence est dans les valeurs.
Si autrefois les valeurs n'avaient pas besoin d'être écrites, mais elles régissaient tout simplement la société, une société où la pauvreté matérielle était vécue avec dignité, aujourd'hui c'est par la loi qu'on peut sauver la famille de la nouvelle pauvreté.
Autrefois la dimension des villages se fondait sur la solidarité; aujourd'hui c'est aux institutions, Monsieur Marguerettaz, qu'il faut demander d'introduire dans le tissu social des éléments de solidarité par le biais des dispositions formelles nécessitant, pour être appliquées, même d'un soutien économique.
Voilà pourquoi je suis convaincu que seul l'administrateur qui a conscience de la valeur de la famille au sens traditionnel, seul l'administrateur qui a en soi le témoignage d'une identité et d'une racine culturelle peut, par la force de la loi, préserver la famille au sens le plus propre du terme.
Quest'Amministrazione, questa Giunta, questo Consiglio nella sua interezza, con l'apporto costruttivo dell'opposizione, hanno voluto dare un segnale alla Società valdostana, innescando una serie di meccanismi di aiuto, sostegno, apporto, che concretamente, non solo sulla base di enunciazioni, valorizzano la famiglia.
Benché la mia introduzione sia imperniata sui riferimenti alla tradizione, questa legge è una legge non solo moderna ed attuale, ma è addirittura una legge di avanguardia, è una legge innovatrice, una legge che ha già avuto il plauso di importanti personaggi che dedicano il loro impegno alla soluzione dei punti di rottura degli equilibri della società moderna che vanno dal crollo appunto della famiglia, ai fenomeni delle dipendenze, del disagio, dell'handicap.
Non considero, quindi, questa legge semplicemente un dovuto intervento politico-amministrativo; sostengo piuttosto che è l'insieme dei valori di riferimento che, oltre ad assicurare alla società le risposte che attende, costruisce l'identità del singolo individuo, di una famiglia, di un villaggio, di un paese, di una regione, di una nazione, in definitiva di una società complessiva.
La relazione tecnico-politica accompagna questa legge e ne illustra le caratteristiche, gli intendimenti, ne spiega i dettagli, ne evidenzia i nodi e le problematiche, ne spiega, articolo per articolo, la natura.
È difficile il compito del relatore perché veramente, e il lungo dibattito e la complessa sua costruzione lo dimostrano, essa è così ampia che egli potrebbe momentaneamente dimenticare qualcuno dei passaggi, qualcuno dei contenuti citandoli a braccio o desumendoli sommariamente quindi, se non ne propongo un'ulteriore illustrazione è proprio perché ogni punto e ogni passaggio della legge meriterebbero un'illustrazione e su nessun punto e su nessun passaggio è possibile sorvolare.
Ho parlato di valori e non di ideologie, non per fare esercizio dialettico e demagogico. Anche parlando di famiglia, non potevamo scadere nell'ideologia e disegnare a tavolino un modello di famiglia ideale, perfetto, rispondente a credenze religiose o ad integralismi eugenetici così come non potevamo fare una legge per ricostruire la vecchia famiglia valdostana trascurando di sostenere tutto ciò che di diverso da essa ormai esiste. La famiglia è ormai un'altra cosa.
Questa legge prende atto di tipologie ormai diffuse, i "single", le famiglie monoparentali, le unioni di fatto, le famiglie ricostruite sono ormai realtà diffuse.
Rispetto ad esse dobbiamo toglierci dalla testa che il nostro compito sia quello di riconoscere o non riconoscere le realtà e peggio ancora sarebbe se come amministratori ci lasciassimo andare a valutazioni moralistiche che non hanno ragione di esistere.
La legge non può avere forza impositiva in questo senso. La legge deve assicurare che i fenomeni sociali, rispetto ai quali le strutture e le istituzioni pubbliche sono chiamate a intervenire, non siano regolati dall'arbitrio, dalla sopraffazione, dall'ideologia, ma armonizzati poiché è nella società che la legge stessa si determina e preesiste. Diventano un problema solo quando arbitrio, sopraffazione ed ideologia creano nei loro confronti una disparità di diritto e di trattamento.
Se essi esistessero solo perché è la legge a determinarli o se fossero legittimi solo perché è la legge a sancirlo, la società non crescerebbe e non si svilupperebbe mai.
Che tocchi proprio a chi, come me, sostiene i valori della tradizione, intervenire concretamente per risolvere situazioni tanto diverse da quelle che fanno parte del suo universo originale dei valori è comunque emblematico del disorientamento e dell'inefficacia che accompagna le attività e le scelte di chi opera, sceglie e lavora senza radici.
In tutti gli ambiti della società l'azione politica ed amministrativa, se non ha riferimenti nella storia, nella cultura dell'ambito in cui si sviluppa, può solo proporre soluzioni importate, che non sono soluzioni perché concepite per un altro modo di porsi i problemi. Il fatto che i problemi siano analoghi in tutto il mondo, non basta a giustificare il ricorso a soluzioni omologhe.
Vorrei proporre a questo punto un ulteriore esempio, più politico, che sposta l'attenzione dalla problematica che dobbiamo discutere oggi su un tema che riguarda il diritto in senso generale, la legge in senso generale e la realtà internazionale. Esistono le comunità, i popoli che, estremizzando la spiegazione di cosa siano, sono aggregazioni di famiglie che condividono un territorio, una storia e una lingua e costruiscono, dall'insieme di identità individuali e da ciò che li uniforma, un'identità collettiva. Ebbene, queste vivono indipendentemente dalle leggi che arbitrariamente decidono quando e se si debba riconoscere che hanno diritto di esistere.
La legge deve quindi prendere atto di ciò che la società consolida come usi, abitudini, esigenze.
Perché mi sono lasciato andare ad una digressione tanto ideologica? Intendo ottenere due risultati. Il primo è evidenziare come la conflittualità sociale, sia per quanto riguarda i popoli che per quanto concerne i gruppi e gli individui, si acuisce in presenza di un'arbitrarietà o di una carenza di legge; questa vale anche per la situazione della famiglia.
Le nuove tipologie misconosciute, criticate o non accettate, determinano una conflittualità. Non aspettiamo la rivoluzione in piazza, ma vediamo di mettere mano ad un disagio degli uomini e delle donne, vittime fino ad oggi di questo frutto poco laico della legislazione.
Rispetto a questa scelta di laicità però, bisogna ribadire che essa non è - ed aggiungo: come potrebbe esserlo? - impositiva. La legge non riconosce questo o quel tipo di famiglia, né discrimina questo o quel tipo di famiglia, la legge prende atto del porsi del modo diverso della famiglia oggi, prende atto delle difficoltà e della crisi della famiglia comunque composta e dà una risposta alla realtà. Ciascuno poi è libero di sostenere, difendere, portare avanti le proprie certezze, ammesso che certezze ci siano, a tutela di una tipologia o di un'altra.
Capisco le perplessità di quanti, nel solco della tradizione, chiamano famiglia quella composta da padre, madre e figlio o figli con la presenza oppure no dei nonni e ritiene che tutte le altre aggregazioni non possano essere definite familiari. Amministrando e facendo leggi, non possiamo cadere in sottigliezze semiologiche.
La famiglia è cambiata, sussiste il modello tradizionale e se ne propongono altre, nessuno può assidersi a censore o permettersi di castigare i costumi considerando che questa sia una situazione degenerativa. Mi sembra per certi versi di tornare all'epoca della questione sul divorzio. La legge sul divorzio non impose l'obbligo di divorziare, ma la possibilità di farlo, preservando insieme i valori di chi considerava il divorzio un'aberrazione ed un peccato contro la fede cattolica e chi preferiva affermare esigenze diverse.
Il secondo risultato che mi proponevo di raggiungere è politico-culturale, teso ad esplicitare i miei riferimenti specifici sul tema della famiglia. "La famille - scriveva Emile Chanoux - est le groupement basilaire de la société, qui est la cellule dont sont formés les tissus de celle-ci et qu'il sera indispensable de renforcer afin que la vie sociale soit alimentée par la richesse des vies individuelles dont elle se compose."
Sempre Chanoux scrive: "Il y a des pays qui meurent tout comme les hommes: ils meurent parce que les hommes des pays meurent et parce que ces hommes ne sont plus remplacés par d'autres hommes qui sont nés. Ils meurent parce qu'il manque dans ces pays la voix harmonieuse des enfants, parce qu'il n'y a plus de familles."
Nel testo di Chanoux c'è quindi la visione tradizionale della famiglia, non è quindi un caso che egli nel suo testo "Les pays qui se meurent", da cui ho tratto la seconda citazione, ne sostenga ardentemente la composizione tradizionale, ma ho tratto la prima citazione da un altro suo scritto: "Essai sur l'organisation administrative de notre Pays", nel quale Chanoux enuncia fra gli altri il seguente "principe politique": "Toute fonction sociale, qui peut être exercée par nos organes inférieurs plus proches de l'individu, ne doit pas être exercée par un organe supérieur plus éloigné de celle-ci, plus complexe; c'est-à-dire que de l'individu à la société on doit passer par degrés, par divers groupements sociaux afin que les rouages sociaux soient les plus simples possibles, qu'ils soient les plus proches possibles de l'individu auquel ils doivent servir. Voilà pourquoi nous sommes fédéralistes."
Ecco dove Chanoux inserisce il passaggio che vi ho citato sulla famiglia: "Après la famille qui est et cetera, et cetera, le premier organisme social de notre vie valdôtaine est le village, regroupement de familles qui habitent ensemble, le village est la conséquence de la nature du sol valdôtain."
Dialogando con Binel, Chanoux osserva: "L'ami Binel nous disait que la vraie liberté est dans l'observance stricte de la loi. Il faut donc que la loi puisse être observée, qu'elle soit simple, claire, accessible comme intelligibilité à tout le monde."
Non so ancora dire se la nostra legge sulla famiglia sia davvero semplice e chiara; certo ambisce ad esserlo per quanto sia possibile risulti semplificata legislativamente una realtà tanto difficile e complessa come quella della famiglia.
Certo è che, come ho tentato di dimostrare, difendendo la famiglia non si difendono solo i diritti individuali, come qualcuno ha detto, e quelli della loro prima aggregazione, ma si mette mano alla soluzione di un problema che riguarda l'identità collettiva. Il mio sogno è di rivedere, come auspicava Chanoux, i villaggi pieni di vita, di bambini che giocano sotto l'attenta e comprensiva sorveglianza degli anziani.
"La montagne - én veladzo - é dé tsan - ou solèi - dé minoù - qui dzoyivan - é dé vioù - qui avétévan - lo tèn passé - é lo tèn - é lo tèn - é lo tèn y é passoù - é to sèn - é to sèn - y é poumé."
(traduzione letterale dell'intervento svolto in patois)
"La montagna - un villaggio - e campi - al sole - bambini che giocavano - e vecchi - che guardavano - il tempo passare - e il tempo - e il tempo - e il tempo è passato - e tutto questo - e tutto questo - non c'è più."
Così canta la cantante valdostana Maura Susanna, interpretando una canzone di Magui Bétemps.
"Ouèi lé tsan i son vaco - é lé dzèn van tcheu ya - lo veladzo s'éndor - bénéfor é tsou-grà.
Ouèi lé tsan son tcheu vaco - dé minoù n'a poumé - lo veladzo y é mor - tsou-grà é bénéfor"
(traduzione letterale dell'intervento svolto in patois)
"Oggi i campi sono incolti - e la gente va via - il villaggio si addormenta - assenzio e erbacce
Oggi i campi sono tutti incolti - non ci sono più bambini - il villaggio è morto - erbacce e assenzio"
Non ricostruiremo, lo ripeto, il "foyer", la famiglia valdostana, ma certo diamo con questa legge un segnale che il popolo valdostano è ancora vivo, pronto a rispondere in modo adeguato alle sfide dei nostri tempi.
Passando alla parte più tecnica ed analitica del disegno di legge, mi pare che quattro siano i punti fondamentali che sono emersi: il problema dell'omosessualità, della monetizzazione, degli assegni post-natali, della famiglia di fatto.
Inizierei con il problema della famiglia di fatto. Come già ho avuto modo di rilevare nella relazione, siamo in una situazione in cui andiamo a toccare una materia che è normativamente oggi del tutto assente dal panorama legislativo nazionale. È sufficiente in questo senso verificare il disegno di legge presentato dal Governo in materia per rendersi conto che la famiglia non basata sul matrimonio non viene ancora riconosciuta oggi in nessun disegno di legge pertanto, ci troviamo in difficoltà perché, a fronte di tante affermazioni, di concreto non c'è assolutamente nulla.
Gli assegni post-natali: se prendiamo la relazione predisposta dal Ministero degli affari sociali al disegno di legge governativo - e questo vale anche per il concetto della monetizzazione -, si dice testualmente: "L'impegno dei legislatori deve essere sollecitato ad esprimere un nuovo contratto sociale; il nuovo Welfare State significa infatti imporre una revisione critica degli attuali strumenti di intervento nelle politiche sociali, adottare scelte sul piano dei servizi e dei trasferimenti monetari tanto efficaci da scongiurare il pericolo dell'allargamento delle fasce di povertà nelle quali si trovano essenzialmente le donne e gli anziani". Si parla esplicitamente di trasferimenti monetari che poi nel disegno di legge governativo vengono esplicitati in modi diversi.
Si dice inoltre: "Al fine di rimuovere gli ostacoli delle scelte di maternità, analogamente a quanto avviene in Francia e in altri paesi della Comunità sia per le non lavoratrici che per le lavoratrici, che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito entro i 30 milioni annui, si prevede la corresponsione di un'indennità di gravidanza e di puerperio di 300mila lire mensili, esentata da imposte, da erogarsi alla data di inizio della gravidanza fino al compimento di tre anni del bambino". Questo non lo dice l'Assessore Vicquéry, ma lo dice il rappresentante governativo per cui respingo nel modo più assoluto chi vuole banalizzare questo disegno di legge dicendo che è un disegno di legge che monetizza perché così non è: non solo non monetizza, ma va nella logica di aiutare le famiglie che è uno dei punti chiave che molti di voi avete testé citato.
Ma passiamo al punto che ha attirato l'attenzione del Consiglio regionale e non solo, ovvero l'articolo 8. Direi che ci si può porre su tre piani distinti: uno è il piano puramente etico, il secondo è il piano del diritto e l'altro è il piano di fatto.
Sul piano etico concordo e sottoscrivo pienamente quanto è stato detto dal Consigliere Marguerettaz, "nulla quaestio", nessuno può permettersi di mettere in discussione la libertà di scelte individuali qual è l'espressione sessuale. Personalmente ho addirittura un senso di ammirazione per coloro che hanno il coraggio - sottolineo questo termine - di esprimere pubblicamente una loro supposta diversità per cui vorrei con questo tagliare la testa al toro a quanti hanno osato affermare che la posizione dell'Assessore Vicquéry sia paragonabile a politici che ultimamente hanno molto maldestramente toccato questi temi, confondendo tematiche delicatissime come quelle dell'omosessualità con pedofilia e quant'altro. Siamo su piani totalmente diversi, ho un profondo rispetto di tutte le diversità.
Sul piano di diritto la cosa è leggermente più complessa perché a sua volta possiamo distinguere il piano di diritto in tre sottolivelli: il livello costituzionale, il livello del diritto ordinario e il livello della giurisprudenza.
Sul livello della giurisprudenza confesso di non avere una raccolta specifica in materia, ma non mi risulta, pena essere smentito, che ci sia giurisprudenza affermata in cui si riconosce allo stato la situazione della coppia omosessuale ma, ripeto, su questo posso essere smentito perché andrebbe fatta una ricerca approfondita che non ho fatto.
Sul piano della Costituzione, riprendo gli articoli della Costituzione che riguardano questo tema perché sono articoli fondamentali. Recita il comma 1 dell'articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Dice il 2° comma: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Primo, piccolo inghippo. La Repubblica non ha rimosso questi ostacoli a 50 anni dalla votazione di questo testo di legge; ha altro a cui pensare, dice giustamente il Consigliere Lanivi, ma siamo in una situazione di non rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che permettono questa libertà.
L'articolo 4 parla addirittura del diritto dei cittadini al lavoro per cui qui potremmo aprire un tema interessantissimo, ma andremmo fuori dal seminato.
Passando al titolo II, rapporti etico-sociali, il 1° comma dell'articolo 29 dice: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
Sempre sotto il titolo II, rapporti etico-sociali, troviamo l'articolo 37 il quale dice al 1° comma: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato eccetera."
In ultimo, correlandolo a questo tema, all'articolo 51, 1° comma, sotto il titolo IV, rapporti politici, si dice: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge".
Questo per dire che, sotto l'aspetto degli ostacoli, noi oggi andiamo a votare per la prima volta in Italia - lo sottolineo, poi ci sono interventi di alcune amministrazioni comunali che con atti amministrativi hanno by-passato i limiti costituzionali - una legge regionale con la quale istituiamo la famiglia di fatto. È una scelta politica chiara di questa Giunta per tutte le motivazioni che sono state dette, ma che vanno oltre il dettato costituzionale con i rischi conseguenti del dettato costituzionale. Sotto il terzo profilo, quello del diritto ordinario, mi limito a riprendere una parte dell'intervista fatta al filosofo Vattimo, il quale afferma: "Tuttavia il diritto dovrebbe cominciare ad essere più mite, più rispettoso verso le persone, più sociale...", il filosofo, come sapete, è un omosessuale riconosciuto ed è importante che lo dica lui..., "... le reazioni alla proposta: riconoscere ai fini civili le unioni omosessuali, non le capisco. Non volete chiamarlo matrimonio? Chiamatelo come vi pare, ma ci sono questioni come l'eredità, la casa o tante altre cose banali che devono essere regolate. È in ballo la parità del diritto."
Io sottoscrivo in pieno questa dichiarazione del filosofo perché è un problema di non poco conto. Nel momento in cui andassimo ad affermare il principio del diritto delle coppie omosessuali al prestito per l'istituzione della nuova famiglia, ci porremmo di fronte a problemi applicativi enormi perché manca questo substrato nella legislazione nazionale.
Quando il Consigliere Marguerettaz mi dice giustamente che bisogna chiedere le garanzie, benissimo, le garanzie le chiediamo; a parte che i prestiti sono per loro natura rimborsabili e questo rientra nel diritto civile a tutti gli effetti come singolo individuo, quando si parla invece di aspetti più tecnici, come quelli che riguardano interventi finanziari di altro tipo, non vedo quale differenza ci sia fra una coppia e il singolo cittadino però, la situazione è che a tutt'oggi manca il riconoscimento ai fini civili dell'unione omosessuale per cui tutto quanto rientra in una legislazione come la nostra pone problemi di questo genere. La controprova è nel fatto che in tutta la legislazione regionale esistente mai è stato usato il termine di coppia omosessuale per questi motivi, presumo. Venerdì scorso questo Consiglio regionale ha votato due disegni di legge, uno riguardava l'edilizia residenziale pubblica, l'altro la prima casa, che escludono dalla possibilità di inserimento nella legislazione delle coppie omosessuali. Poi, ripeto, questa è una posizione dell'Amministratore Vicquéry, dal punto di vista della persona Vicquéry, ho già avuto modo di ribadire quali sono le mie convinzioni e vorrei che fosse chiaro. Vorrei che fosse altrettanto chiaro che comunque vada la votazione il Consiglio regionale sarà assolutamente sovrano e io mi limiterò a prendere atto dell'esito della votazione.
Voglio solo porre un piccolo problema di tipo amministrativo che potrebbe inficiare totalmente l'aspetto della legislazione - lo dico a futura memoria - perché ci sono dei problemi pratici che vanno ben al di là delle ideologie e di aspetti di più alto livello.
Non voglio in quest'intervento addentrarmi in altri temi più tecnici che affronteremo nella discussione dell'articolato. Ritengo che comunque vada a finire la Regione Valle d'Aosta potrà porsi come esempio da seguire. Lo dico anche qui a futura memoria: questa non è e non potrà essere una legge perfetta, è una legge sperimentale che sarà ritoccata e ritoccabile nei prossimi anni perché molti degli istitutivi innovativi previsti vanno posti sul campo, a partire dall'aspetto reddituale per finire ad aspetti pensionistici, retributivi e contributivi, perché in nessuna legislazione sono ancora inseriti. Essendo la legge sperimentale, sicuramente dovranno metterci mano i prossimi amministratori perché così è.
È importante però che con tutti i limiti e con tutti i punti interrogativi si proceda come abbiamo proceduto quando abbiamo votato la legge sul minimo vitale: quanti di noi sapevano se quella legge avrebbe avuto dei risultati concreti e se avrebbe portato a 10 miliardi all'anno o a mezzo miliardo all'anno le necessità di contributo? Non lo sapevamo. Oggi siamo in una situazione di sperimentazione che è durata tre anni, abbiamo dei paletti su cui ragionare, siamo in una fase molto transitoria perché è in ballo il sanitometro e ci sono, nell'ordine, la riforma delle politiche sociali e tutta la politica dei ticket.
All'interno di ogni disegno di legge si stanno usando da parte dello stesso Governo dei parametri di valutazione del reddito totalmente diversi, si va dal reddito convenzionale (cosiddetto ISE) al reddito minimo garantito, o definito anche l'assegno di povertà, al minimo vitale a favore di famiglie e ad altri concetti che andranno nell'arco dei prossimi due anni a scombussolare totalmente le politiche sociali in Italia per cui siamo in una fase molto delicata che sicuramente ci servirà da esperienza per i prossimi anni.
La mia proposta è di guardarci bene attorno, di esaminare i pro e i contro perché arriveremo, Consigliere Marguerettaz, ad una riforma globale delle politiche sociali, ma partiamo da uno zoccolo duro che non è certo basso; siamo la Regione d'Italia che percentualmente spende pro-capite di più di tutto il resto d'Italia in politiche sociali, siamo i primi in Italia. Questo diciamocelo almeno, già altri hanno per compito istituzionale quello di dirci che tutte le cose vanno male, ma diciamocelo. Quindi partiamo da questo zoccolo duro e ricostruiamo il tutto, ma facendo attenzione ad un aspetto fondamentale: su alcuni istituti non possiamo intervenire. Non possiamo intervenire sul diritto al lavoro, su tutta la parte previdenziale e pensionistica, sulle revisioni contrattuali perché non è nella facoltà della Regione andare a toccare i tempi-lavoro delle madri o delle donne in generale, non possiamo intervenire su materie sottratte alla competenza legislativa regionale. Questa è stata la grossa difficoltà nell'imbastire un disegno di legge la cui stesura è iniziata da più di un anno e che arriva all'esame dell'assemblea grazie alla collaborazione fattiva di tutti i Consiglieri di maggioranza e di opposizione.
Termino qui questo primo intervento per riprendere poi gli argomenti puntuali sui singoli articoli.
Président Je déclare close la discussion générale. La parole au Conseiller Perrin G.C..
Perrin G.C. (UV) Pour vous demander, Monsieur le Président, une très courte suspension d'abord du Groupe de l'Union Valdôtaine et ensuite de la majorité.
Président Alors, une suspension de 10 minutes pour une vérification.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,39 alle ore 21,29.